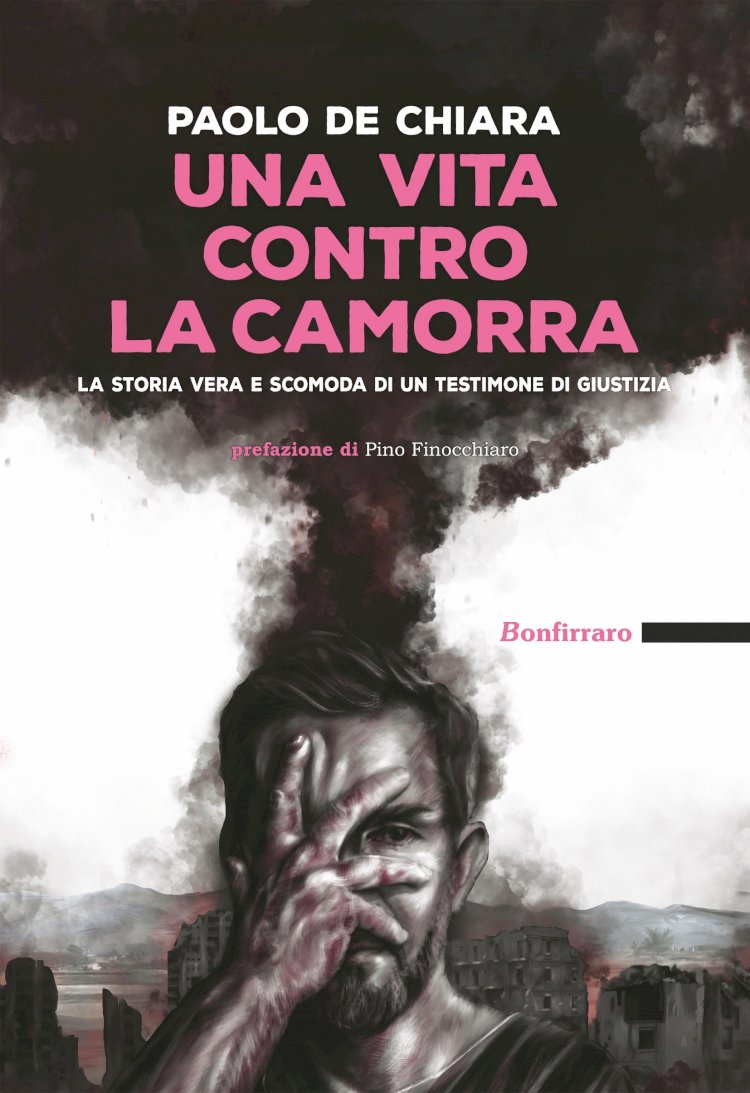AMA LA TUA STRADA
Le brave ragazze sognavano in silenzio, sotto le coperte nelle loro camere perfette, ben fatte e ripulite come i genitori imperativamente richiedevano di fare; ma loro no, urlavano alla notte, gridavano più forte che potevano, plasmando l’alba e anche il giorno a seguire…
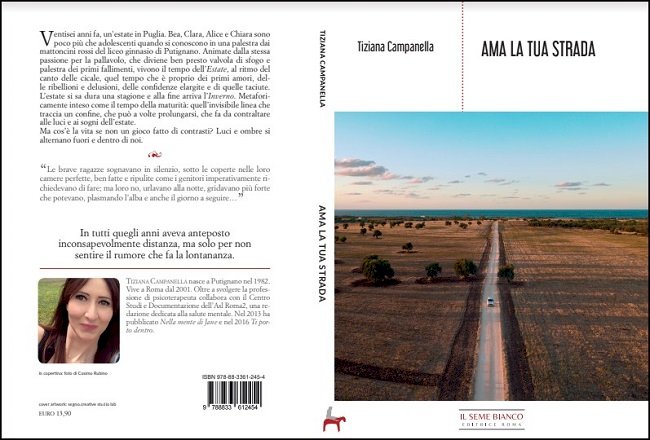
Per gentile concessione dell'autrice* pubblichiamo un estratto del libro AMA LA TUA STRADA.
di Tiziana Campanella
© 2021 – Il Seme Bianco
ISBN 9788833612454
COLLANA: Magnolia
PAGINE: 144 p.
PREZZO:13,90 €
PARTE PRIMA
Estate 1
Erano gli anni in cui passava alla radio Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers e si viaggiava in auto senza cinture di sicurezza lungo la statale deserta. La notte era a portata di mano, negli occhi soltanto voglia di esagerare. La selva di Fasano era oscura, ma non faceva paura, nessuno la temeva, nessuno la teme quando si è giovani: altro non è che un promontorio da attraversare che ti porta fino al mare. È questo che conta. Che ti porta fino al mare. E che si può attraversare. L’unico imperativo era… andare.
Sembra di cavalcarla davvero la notte quando la vivi. Anche allora le ragazze ne assaporavano ogni particella di profumo. Quattro ragazze, sempre insieme, diverse ma essenzialmente uguali nel loro essere fuori dagli schemi.
I falò sulla spiaggia. Momenti di baldoria, verità e libertà. Accampate come streghe in cerchio a rivelare i propri segreti. E la serata andava: il tempo scorreva fluido, leggero, il fuoco alimentava passioni nel cuore di ciascuna; i sogni sembravano stelle non così lontane. Non dovevi fare altro che alzare lo sguardo nel buio della notte, danzare con essa, e staccarle dal cielo.
Sdraiate su quella sabbia bagnata le ragazze sapevano che quelle serate insieme avrebbero tracciato la loro storia. Chi, cosa sarebbero diventate non sapevano dirlo. Rinviato a oltranza il momento del cosa farai da grande, se ne assaporava una sottile teoria.
Adam’s Song dei Blink-182 suonava da quel cd mezzo rovinato in quella Fiat decappottata amaranto che ha fatto la storia. Si andava sempre lontano dalle strade del paese, per poter alzare il volume, abbassare i finestrini e sentire il vento accarezzare e scompigliare i capelli. Si guidava fino al mare, a bordo birra e il pericolo addosso di fare cavolate.
Le brave ragazze sognavano in silenzio, sotto le coperte nelle loro camere perfette, ben fatte e ripulite come i genitori imperativamente richiedevano di fare; ma loro no, urlavano alla notte, gridavano più forte che potevano plasmando l’alba e anche il giorno a seguire, pur di scandire la loro voce. Pur di lasciare la loro firma.
Quattro ragazze assetate, una più dell’altra, di avventure, esperimenti e desideri. Il paese era un buco nero e corto che risucchiava energie, nella più fortunata delle ipotesi manipolava per ricreare a sua perfetta immagine e somiglianza. Con loro questo antidoto malefico non aveva mai funzionato. Immuni regnavano nel loro campo minato.
Era stretto. Era maledettamente stretto quel paese. Era come una strana bolla di vetro realizzata da pareti soffocanti. In perenne lotta per cercare un luogo che fosse in grado di contenere il loro dannato modo di sentire. E vivere. Neanche l’euforia di Basket Case dei Green Day bastava per sedare tutta quell’insofferenza che a volte diventava estrema, bisognava scaraventarla però da qualche parte quell’energia, altrimenti sarebbe diventata aberrante. Un luogo in comune c’era. Anzi due. Uno era il liceo ginnasio, più precisamente la palestra di quel liceo, l’altro è un segreto.
Mattoncini rossi, era fatto dai più bei mattoncini rossi quel liceo, e quella palestra, un po’ più lontana dal centro, dall’occhio diffidente e giudicante della gente. Una strada non asfaltata conduceva all’ingresso. È lì che si sono conosciute. Bea, Clara, Chiara e Alice. Tredici anni appena e la voglia di stringere in mano una sigaretta per sentirsi già donne, già pronte alla guerra. Era la squadra di pallavolo under 14. Una divisa in mano e una gran voglia di prendere a schiaffi quel pallone. Si guardavano di soppiatto, si scrutavano. Un destino comune. Quello di imparare a fare due cose importanti nella vita che non avrebbero mai dimenticato: fare squadra e non arrendersi mai, soprattutto quando si perdeva. Imparare a vincere te lo insegnavano tutti, ma i bravi allenatori, i bravi insegnanti di vita, t’insegnano a perdere. E a ripartire. E a non mollare. E ad appassionarti ancora più di prima. E il loro allenatore Beppe, era così.
Quello fu il loro primo campo da gioco e di vita. Piccoli esperimenti per piccole donne. La divisa era bianca e blu, piccole culotte lasciavano intravedere bozzoli di farfalle pronte a scrollarsi tutto il loro pesante guscio da bruchi. Tre lunghe ore di allenamento, ma erano le più belle di tutta la giornata. Clara e Alice andavano a scuola in quel Liceo, Bea e Chiara in un Istituto Tecnico fuori paese. Eppure in quella palestra erano una cosa sola, per un obiettivo comune. Vincere insieme.
2
Erano gli anni delle scritte sui muri con l’Uniposca, pennarelli colorati che rendevano indelebile la tua opinione. C’erano i diari di scuola. A tutto servivano tranne che per appuntare i compiti. Diventava pesante come un dizionario per il volume che raggiungeva. Biglietti del treno di un giorno speciale, uno scontrino a indicare una data da ricordare, una fotografia rubata o i testi delle canzoni preferite ritagliate dai giornali. Le ragazze a turno se lo scambiavano. Quando non potevano aggiornarsi l’una con l’altra, allora il diario diventava un punto d’informazione della propria situazione. Un bollettino metereologico della propria emozione. Smemoranda era il preferito di tutte, pagine bianche da riempire con i propri pensieri, frasi dei Baci Perugina incollate, nomi di ragazzi che occupavano spazi interi, giornate nere su pagine strappate, altre incollate per cancellare qualche delusione, qualche promessa mancata o qualcuno da dimenticare. Riflessioni passeggere firmate e datate con il proprio numero di maglia: 11 Alice, 8 Clara, 2 Bea, 3 Chiara.
Bea aveva un rapporto particolare con quel suo diario, difficilmente se ne separava, quasi fosse un prolungamento di se stessa. Di ciò che pensava ma non riusciva a esprimere. A dire il vero non aveva soltanto quello. Scriveva da sempre. Undici anni appena, una penna in mano e una sigaretta in bocca. A casa, in un cassetto chiuso a chiave, c’erano i suoi raccoglitori di emozioni, fitte agende scritte a mano, senza spazio, senza regole di punteggiatura, quasi che l’impellenza fosse solamente quella di buttar giù. Tirar fuori una parola dopo l’altra senza fermarsi mai. Se tutto intorno impediva di poter dire una sola parola, là dentro ogni cosa prendeva vita e forma. I giorni belli erano contrassegnati da una stella, quelli neri da una luna. E non li faceva leggere mai a nessuno. Tranne che, qualche volta, ad Alice.
Il diario era l’unico vero motivo per ritornare a scuola. Il primo oggetto che si comprava l’ultimo che si lasciava. E non importava se l’Invicta pesava troppo, magari si rinunciava a un libro, ma il diario proprio no. Era il passaporto personale per il mondo. Era l’unico che aveva accesso anche in palestra, era un oggetto di cui ti vantavi per come l’avevi scelto, riempito e abbellito. Si capiva chi fossi dal diario che avevi. Se era vuoto, allora eri come lui. Se era anonimo, eri anonimo anche tu con lui. Triste lui, triste tu. La scelta del diario era un modo di essere e di sentirsi ma anche di riconoscersi e affermarsi. Non c’era altro. Era l’unica vetrina da esibire aldilà della propria faccia e del proprio corpo. Erano anni diversi.
Appena l’allenamento finiva, si passava il tempo sedute su quelle scale fuori dal liceo, poche luci illuminavano quell’angolo lontano da occhi indiscreti, si sfilavano via le sigarette avvolte nella carta da giornale e si passava in rassegna qualche pagina di diario. In questo si condividevano le prime affinità; si rammendavano rapporti. I ragazzi erano fuori dal gioco. Quando le ragazze facevano gruppo, i ragazzi le temevano. Erano viste sotto una cattiva luce. Il paese era pieno di pregiudizi e di malelingue impossibili da zittire.
Fumare a quell’età era attività da clandestini. Oltre i capannoni dove i maestri cartapestai creavano i carri di carnevale, poco più in là della palestra, c’era il cimitero. E in quei minuti, prima che qualcuno dei genitori puntuale arrivasse, si facevano le passeggiate in silenzio, ciascuno accanto al proprio boy del momento. Ragazzine in fasce gesticolavano acerbe tra baci e carezze innocenti, che si sa, agli esordi, hanno il sapore dell’incorruttibile e seducente gioco dell’amore. Chiara e Clara erano le più intraprendenti, flirtavano come se lo facessero da sempre, ma solo per padroneggiare meglio dentro di sé quella imprescindibile voglia di sapersela cavare, anche con i ragazzi, per dettar legge ovunque visto che in casa non era possibile.
Bea e Alice avevano sfumature più romantiche quasi da timorate di Dio, ma solo superficialmente, perché dentro, ciò che le animava, era una silenziosa passione ancora senza nome. Quei primi baci rubati, a quell’età, tra silenzi e boccate di sigaretta, alla fine sarebbero stati presto dimenticati e sostituiti, esattamente come quando un bambino si trova in un parco giochi e non ha voglia di andare sempre sulla stessa giostra. Si ha voglia di esplorare, di individuare nuovi colori, nuove sensazioni, conoscere ancora e fare nuove esperienze.
Qualche volta, dopo palestra, quando c’era ancora tempo a sufficienza prima di dover rientrare, ci si dava appuntamento nel posto segreto, saltuariamente di sera, più abitualmente facendo “bollo” a scuola. Quel posto segreto era al limite del confine del paese, oltre i binari del treno sempre emozionanti da attraversare, sempre con un brivido addosso perché qualche volta il passaggio a livello diventava rosso e si rischiava sul serio che qualcuno le beccasse in flagrante. Infine si voltava a destra verso la Grotta del Trullo, una sorprendente grotta carsica che prendeva quel nome per via di un piccolo e isolato trullo costruito in prossimità dell’entrata. Dei muretti in pietra separavano l’adiacente parco comunale, i campi da tennis e quelli da calcio, e sullo sfondo a perdita d’occhio si estendeva un bosco fitto, dove le ragazze spesso vi si perdevano. Era lì che probabilmente i ragazzi facevano le prime esperienze con il fumo e l’alcool, ma in fondo in fondo solo per assumere l’atteggiamento del “mi sento più grande”.
Non sapevi mai chi avresti incontrato. Non c’erano ancora i cellulari. Bastava uno sguardo e ci s’intendeva, si filava dritto sui motorini, si nascondevano bene, dietro le siepi e i cespugli per non essere viste, per non essere osservate. Si rischiava di essere giudicate quando quattro ragazze si mettevano insieme a fare cazzate.
Eppure, a quei tempi, il collante che le univa era decisamente meno velenoso dei tempi che sarebbero sopraggiunti. Ma questo non potevano saperlo. Si schivavano occhi indiscreti e mamme con bambini, furtive si intrufolavano nel parco come fossero ladre dopo una rapina.
Qualcosa rubavano, è vero, ma lo rubavano fortunatamente alla vita, lo strappavano per modellarselo a loro piacimento. Erano ore a loro disposizione, tempo ottenuto a incastro come pezzi di un Tetris, il mitico videogioco.
Sempre ci si vedeva lì, perché tra quegli alberi in quel parco, c’erano i campi da calcio, dove si allenavano i ragazzi. Era un continuo passare e ripassare per affinare l’arma più aguzza che le donne hanno in mano, non solo quella della seduzione che tutti danno per scontato, ma quella dell’intelligenza emotiva. È sempre un gioco di incontri perché è sempre un gioco di sguardi e di intenzioni. Kiss Me di Lene Marlin passava nelle cuffie dai walkman delle ragazze, ne canticchiavano qualche parola appena pronunciata, come una preghiera indicibile che non può essere confessata. Quanta voglia c’era di essere baciate, strette per mano o solo sfiorate. Era tanto martellante tanto da offuscare la mente. Erano gli anni del film Romeo e Giulietta, e ciascuna ragazza aveva negli occhi e nel diario le figurine di Leonardo Di Caprio. Su quegli spalti, su quei gradoni, ci sono ancora scritti i loro nomi e un + a sommare il nome del proprio amato. Scalfite nel cemento impressioni di un’adolescenza. Qualche volta la questione si faceva seria e allora capitava che ci si divideva e ci si allontanava. Non era la prima volta che gli stava così vicino, eppure Bea scelse lui come suo cavaliere senza sapere dove, come e quando.
Si chiamava Fabio, scherzava con tutti e non badava mai a lei, nessuno sguardo nessun contatto. Eppure divenne il suo punto nevralgico. Le donne non sono così vigliacche, s’intestardiscono e silenziosamente covano fin da piccole, la fiducia in quelle cose che hanno il carattere dell’impossibile; è una prerogativa femminile. Non smettere di amare ciò che si ama. Bea lo sapeva fin dall’inizio che sarebbe stata una partita difficile.
Clara destreggiava sigaretta e birra con il suo Alberto; Chiara e Alice ridevano contente; ma Bea sognava a occhi aperti e creava una realtà diversa. E quando qualcosa, e accadeva molto spesso, non corrispondeva ai suoi desideri o ideali, tornava a casa, spedita puntava alla sua camera, ci si chiudeva dentro e accendeva internamente qualcosa, che scaraventava fuori solo attraverso una penna. La mente viaggiava così lontano (oltre ciò che osservava) che qualche volta non le sembrava di stare al passo con il tempo che viveva. La sua difesa diventava la sua arma migliore, restava ore e ore a scrivere e a fantasticare mondi migliori, a navigare in storie ancora non vissute. A quell’età, innocenza e leggerezza fanno da contraltare a delusioni e ferite, che probabilmente si ricordano a vita.
Bea ricorda come uno dei primi ragazzi, da sempre silenziosamente corteggiato, le avesse dichiarato una cotta per una sua compagna di scuola. Incassò il colpo, era sera inoltrata, fuori da scuola, per incontrarsi avevano scavalcato i cancelli e lei si aspettava qualcos’altro. Seduti alla luce rossa dei lampioni, osservava le loro ombre vicine, si passavano la sigaretta sfiorandosi appena le mani, in trepida attesa. Attesa spezzata da una dichiarazione non corrisposta. Non disse nulla, andò via, disse tutto alla sua amica Alice. I due si misero insieme e lei tornò in camera a leccarsi le ferite. C’era tra tutte e quattro le ragazze, una certa sfida sottintesa a essere la più figa, ma non in termini di bellezza, ma più intesa a sapersela cavare nelle situazioni, uscirne a testa alta e soprattutto non frignare per i ragazzi.
Ma Alice sapeva leggere bene l’animo di Bea, sapeva che quando andava via all’improvviso era perché qualcosa aveva fatto scacco matto dentro di lei. Ed era vero. Si chiudeva in stanza che diveniva l’unica zona sicura della trincea, avviava lo stereo, infilava il suo cd preferito, Zooropa degli U2, cuffie alle orecchie, seduta su un tappeto, premeva start e qualcosa dentro partiva, e allora, solo allora, si sentiva libera. Stay suonava e cullava quella tacita malinconia che gli artisti ancora in erba non sanno di avere. Non sapeva ancora che quella scia, non l’avrebbe lasciata mai più. È parte integrante della sua essenza e del suo stare al mondo. Lei ci riusciva così. A quell’età non c’è un modo giusto o sbagliato, c’è il proprio modo che attraverso i soliti gesti viene perpetuato. Scrivere le apparteneva.
Così come Chiara sapeva mischiare bene le parti per far uscire un buon cocktail, Clara schiacciava forte su quel pallone e faceva sempre punto. Bea amalgamava ingredienti che non capiva come tenere insieme, fuori da quel diario facevano solo un gran baccano, ma tra le pagine tornava la pace, ordine e un certo sereno. Alice, da sempre, la più saggia del gruppo, era coscienziosamente la più grande delle altre, e la sua particolare dolcezza era unita a caparbietà e voglia di prendersi ciò che si vuole dalla vita.
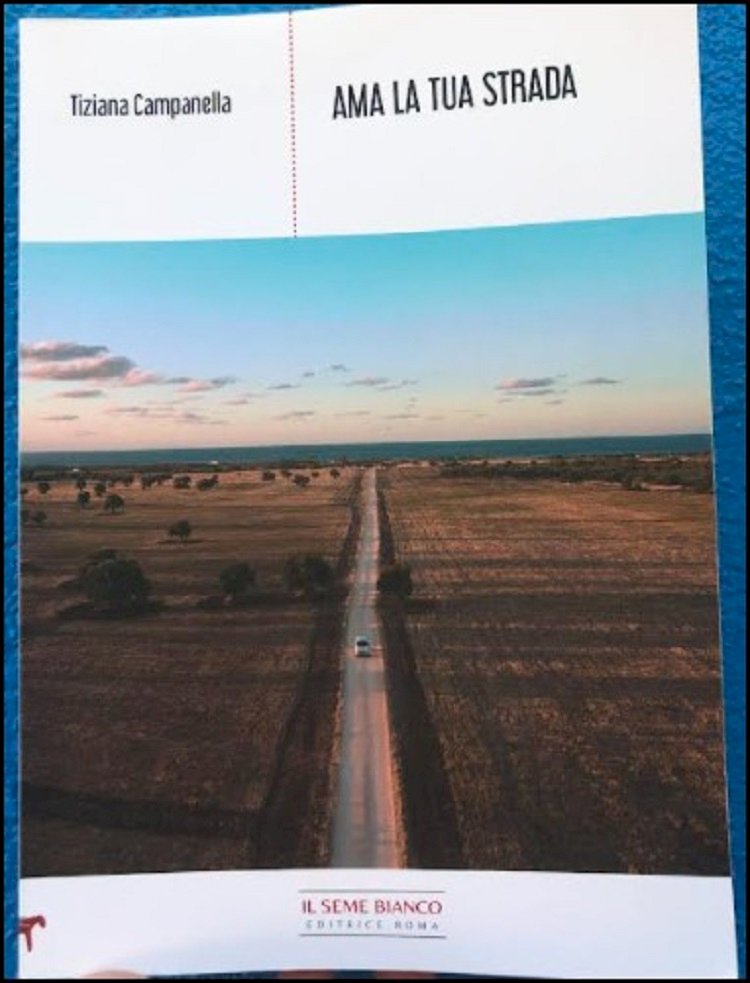
BIOGRAFIA:
*Tiziana Campanella nasce a Putignano nel 1982. Vive a Roma dal 2001. Oltre a svolgere la professione di psicoterapeuta collabora con il Centro Studi e Documentazione dell’Asl Roma2, una redazione dedicata alla salute mentale. Nel 2013 ha pubblicato Nella mente di Jane e nel 2016 Ti porto dentro.