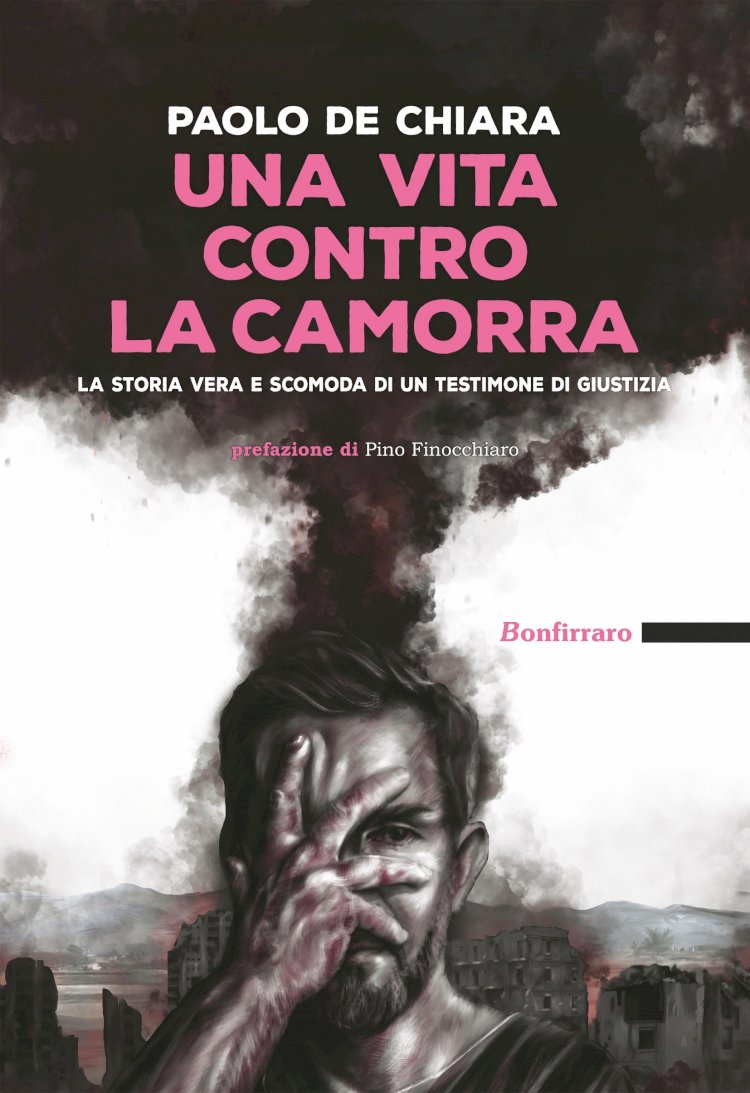IL DOPPIO MURO
PER GENTILE CONCESSIONE pubblichiamo un estratto del libro e una nota di Vincenzo Incenzo.

Lui entrò non appena la madre fu fuori dalla stanza, in mutande,
mangiando un pezzo di ciambellone. Le briciole cadevano ovunque.
La mia vescica urlava.
«Hai fatto un cazzo di casino tutta la notte. Ho dormito malissimo!»
Queste furono le prime parole che mi rivolse, da marito, poi si
chiuse in bagno per una doccia che durò mezz’ora mentre io, raggelata
quella realtà che faticavo a riconoscere come la mia nuova vita, rischiai
di farmi la pipì addosso. Trascinandomi a gambe strette nel mio
abito nuziale, sbottonato malamente sulla schiena, tolsi dal letto le lenzuola
della prima notte, in pratica pulite in quel senso, le misi in lavatrice
e poi le appesi fuori; la prova per “i cristiàni”, in bella vista.
Quando entrai in bagno feci appena in tempo ad abbassare le mutande.
Fare la pipì non fu né facile né liberatorio. Anzi. Rimasi per un
po’ a fissare le piastrelle davanti a me mentre, goccia dopo goccia, sperai
di espellere lacrime non piante e delusione. Chissà perché mi vennero
in mente le Fiumare secche, in estate.
Osservai la gonna che avevo tirato su velocemente, per evitare di
bagnarla con la mia urina, i lembi erano già sporchi di terra. Lasciai che
ricadesse dalle mie cosce fino al pavimento. Mi resi conto che era pesante.
E calda. Quanti indumenti indossavo? Il vestito iniziò a stringermi
come fosse una morsa. Ci stavo soffocando dentro e più cercavo
di respirare e più mi stringeva le carni. Restando seduta sulla tazza, girai
le braccia fin dietro la schiena e, allungandole il più possibile, sganciai
un altro bottone, e poi ancora un altro e un altro. Dolore agli arti. Mal
di testa. Sonno. Allora afferrai le due parti laterali del bustino e tirai
forte. Il rumore dello strappo del tessuto lacerò la mente della giovane
sposa che non ero stata.
Due bottoni volarono sul pavimento.
O, forse, furono i miei occhi a volare via per sempre dalla realtà.
Con frenesia incontrollabile, mi liberai di quell’inutile vestito fino
alla vita.
A cosa era servito?
A cosa servivo, veramente, io?
Mi accasciai sulle cosce, nuda, e il cesso mi sembrò una comoda
culla, accogliente e rassicurante. Il tulle, sotto i miei piedi, mi coccolava
e mi inebriava di menzogne.
Altri occhi mi si aprirono.
Iniziai a intessere il mio bozzolo. Da quel momento avrei cercato,
ogni giorno, di ritrovare quella ragazza vestita di bianco, piena di sogni
e aspettative, che bramava la sua prima notte di nozze.
Con un ultimo sforzo raccolsi i due bottoni.
Piccoli. Bianchi. Lucenti.
Occhi che non erano stati capaci di vedere.
Sollevai la gonna, schiusi le cosce e li lasciai scivolare in quell’acqua
giallognola.
Chiusi gli occhi nuovi.
Gocce di pipì. Lente.
Ancora una…
Intessevo.
Ancora una…
Mi addormentai.

Il DOPPIO MURO, di Camilla Cuparo.
Una nota di Vincenzo Incenzo.
Leggere Camilla Cuparo è un’esperienza del corpo. Scrive come se ogni sillaba fosse l’ultima, si lancia sulla pagina come un kamikaze, senza nessuna certezza di salvarsi. E fa riemergere da fondali rimossi e fangosi la parte più oscura di noi stessi. Ogni sua parola è carne viva, sessuata e crudele, ogni suo pensiero si sporge sul precipizio di un abisso.
Una scrittura sinestetica, disperata e desiderante, speziata e puzzolente. La sua pagina risuona, vibra, rimbomba, libera liquidi delicati e osceni. Le immagini bruciano di un fuoco antico e si ricompongono in sovraccarichi sensoriali che ti scavano nella pelle.
Tutto nel suo scrivere sa di Sud.
È un sud geografico, certo, ma è anche un Sud del corpo e dell’anima quello che impregna i personaggi, trascinandoli ad un crocevia che li lacera tra istinto di liberazione e retroterra culturale, mentre il dialetto serpeggia e si spande come un bicchiere di vino rovesciato all’improvviso sulla tovaglia buona della domenica. Il romanzo.
Come in uno dei suoi meravigliosi quadri di pittrice, Camilla divide lo spazio, dispone i colori, e inizia. Maria, Peppe, Sara, Marco. Una madre, un padre, una figlia, il suo amante sposato. I piani incrociati ci offrono il prisma di un flusso spaziotemporale intenso e drammatico, un vero e proprio processo in realtà, dove ognuno vuole essere assolto, dove ci si rispecchia ad anni di distanza, dove i sensi lottano con le tradizioni alla ricerca di felicità impossibili e i corpi diventano spugne dell’ineluttabile che assorbono il destino e sputano fuori saliva e ribellione. Oggetti senz’anima come la naftalina diventano balocchi presaghi, un sacramento come il matrimonio si trasforma in patibolo del tragico, fotografie come fantasmi conducono a ricordi in cui si salva l’onore sequestrando libertà e vergogne; una cometa appuntata sull’albero di Natale fa sanguinare più di una lama nel cuore.
In gioco non ci sono solo delle vite ma una cultura e un’epoca; l’aria pesa di pianti trattenuti e silenzi imposti, di maschilismo e carezze che lasciano sangue sotto le dita, di pazienza inesplosa e odori di cucina, di irritante rassegnazione e madonne che piangono, di espressioni e minacce che come lenzuola della prima notte si espongono per far tacere. Camilla dipinge, e compone il quadro in preda a un folle coraggio.
I colori grumosi e vivi convergono sulla madre, che cresce in mano a Sara, figlia che non riesce a verticalizzarsi e che il malato rapporto con Marco indebolisce ancor di più; una madre che mendica attenzione invece di darne, affondando la sua bocca asciutta di baci coniugali sulla giugulare dell’innocenza; una madre che svuota la vita e decora la casa, culla e tomba, domicilio precario e definitivo, difeso dalle tarme e dai sogni, dove la verità non ha diritti e i silenzi avvelenano. Come un satellite gravita il padre, preda di una vigliaccheria che è di quel genere di maschio, che vuole legittimarsi attraverso corpi più giovani, nell’unico alfabeto che è in grado di impugnare. Le sue certezze si smagliano come l’addome della moglie, le sue fughe sono paure e ciniche rincorse verso un’irrecuperabile giovinezza. Fino allo scontro con la figlia, alla violenza, e allo sbocco delle loro infette ferite. E poi, in un effetto domino una rivelazione dopo l’altra.
Sangue comunicante, che si travasa nei dialoghi risolutivi, feroci e passionali di Sara con la madre e poi con Marco, vernice finale del quadro che ci consegna la sconfitta del genere maschile. Amore e morte, in una staffetta dei ruoli, dove l’abbandono è la regola del gioco, e dove l’amore è il vessillo che nessuno potrà più raccogliere. Il possesso agognato dell’altro, come in una tragedia greca arriverà solo con una nemesi perfetta e grottesca, e l’unico modo che avrà Sara di abbattere il ‘doppio muro’, dietro il quale si sono nascosti per anni i genitori, è alzarne un terzo, definitivo ed assoluto, sulla cima del quale le loro voci arriveranno ormai come rumori lontani e ovattati e leggero e nuovo sarà il sapore della libertà.
Quella libertà a cui Camilla consegna solo una parola nel suo romanzo, l’ultima, e che che ancora oggi per tante donne, ed ecco l’urgenza del romanzo, non è prevista.