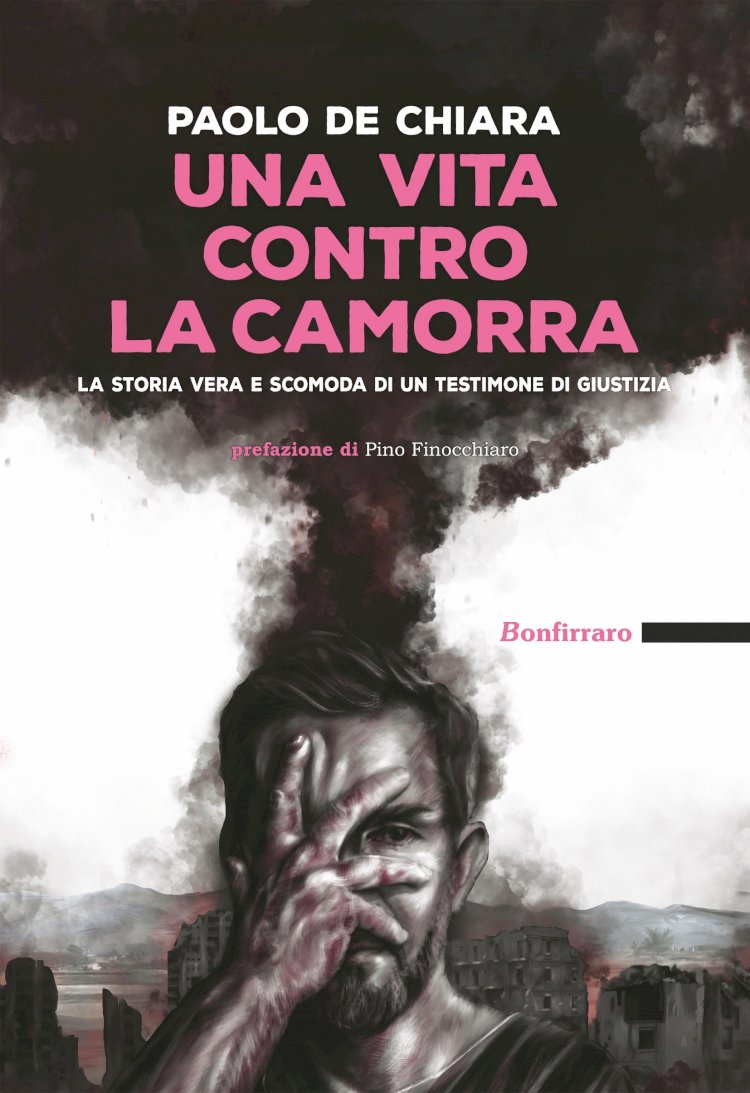La parola ai giurati
Il problema delle influenze esterne nei confronti dei giudici, togati o popolari essi siano, anche nell’ordinamento italiano rappresenta il punto più alto di fragilità del sistema.

Era il 1957 quando uscì nelle sale cinematografiche “La parola ai giurati”, opera prima di Sidney Lumet. Basata su una sceneggiatura scritta da Reginald Rose, la pellicola era l’adattamento cinematografico di una produzione televisiva realizzata per la CBS all’interno della serie antologica “Studio One” che andò in onda nel 1954.
Il film racconta lo sviluppo di una vicenda processuale. Inizia all’interno di un'aula di tribunale e lo spettatore è immediatamente informato del fatto che siamo di fronte ad un processo per omicidio di primo grado. Un uomo è morto e suo figlio è accusato di essere l'assassino. In accordo con la legislazione statunitense, il verdetto doveva essere espresso all'unanimità perché un verdetto non unanime avrebbe portato alla ripetizione del processo. La giuria è informata che un verdetto di colpevolezza condannerà certamente il ragazzo alla sedia elettrica, poiché il giudice rifiuterà qualsiasi richiesta di grazia. I dodici giurati si dirigono verso la stanza in cui svolgeranno il proprio lavoro e dove, discutendo il caso, scopriranno la personalità l'uno dell'altro. Lumet, facendo saltare in aria l’idea hitchcockiana del “cinema puro”, mette dodici uomini attorno a un tavolo a parlare e ottiene non solo una delle prestazioni attoriali più memorabili della settima arte, ma anche uno dei più profondi studi sulla natura umana mai messi su pellicola. Per chi volesse capire l’intreccio, importante per lo sviluppo narrativo del film, può decidere di guardarselo, cosa che consiglio vivamente.
E’ evidente che ci sono notevoli differenze tra il processo penale all'italiana e quello americano, considerato da molti più moderno e funzionale. Una delle differenze è innanzitutto quella che riguarda il collegio giudicante. Come si ben evidenzia nel film di Lumet, negli Stati Uniti esiste la Giuria popolare che emette il verdetto di colpevolezza o innocenza e tocca poi al giudice togato comminare la pena in caso di colpevolezza tenendo conto dello sviluppo processuale.
In realtà sia il processo americano sia quello italiano sono entrambi accusatori, dove è sempre l‘accusa che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Il processo penale americano si avvale, per il giudizio, della Giuria, che è scelta tra i cittadini della comunità territoriale, con il contraddittorio dell’accusa e della difesa per la scelta dei singoli giurati, in Italia invece no.
Quando si agisce con la presenza dei giudici popolari è il Tribunale a convocarli tramite l’estrazione dei nomi dall’elenco dei giudici popolari.
Nello specifico, il giudice popolare è il cittadino italiano che è chiamato a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Ogni due anni, nell’anno dispari, i Sindaci invitano con manifesti pubblici chi è in possesso dei requisiti e non già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. I requisiti per far parte di una giuria popolare in Italia, oltre all’età anagrafica, sono i seguenti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale e un titolo di studio minimo, rispettivamente la scuola media di primo grado per la Corte d’assise e la scuola media di secondo grado per la Corte d’assise d’appello. Non possono fare il giudice popolare i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Con il rito abbreviato, che in America non esiste come metodo, è invece il Gup che gestisce il processo. Il Gup è un magistrato che proviene, quasi sempre, dalla magistratura inquirente. In altre parole, un giudice per le indagini preliminari o un giudice per le udienze preliminari che determinano, praticamente, chi mandare al processo e chi prosciogliere, hanno fatto anni di processi come pubblico ministero, acquisendo una formazione prevalentemente accusatoria. Non è così in America dove la magistratura inquirente non può avere ruoli giudicanti.
Il problema delle influenze esterne nei confronti dei giudici, togati o popolari essi siano, anche nell’ordinamento italiano è il punto più alto di fragilità. Lo dimostra il processo per l’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile.
Vincenzo Puccio, sospettato di essere il suo assassino, seppur catturato dai carabinieri subito dopo l'omicidio, sarà assolto in primo grado tre anni dopo, creando sgomento e rabbia sia nei magistrati sia nei suoi colleghi.
Una delle cause principali e determinanti dell’assoluzione di Puccio fu il voto dei giudici popolari, condizionati pesantemente dal contesto esterno e che si sviluppò attraverso minacce e intimidazioni nei loro confronti provenienti dal contesto mafioso ma anche con la promessa di favori e raccomandazioni.
Di fatto questo portò a un’assoluzione che, ancora oggi, è citata come esempio della pericolosità delle influenze esterne nei confronti del collegio giudicante, sia per la parte togata sia per quella popolari.
D’altra parte il mantenimento del giudice popolare accanto al giudice togato, è realizzato al fine di creare una magistratura legata al comune sentire piuttosto che una magistratura autoreferenziale che rischierebbe di diventare troppo resistente ai cambiamenti sociali. Oltretutto un vantaggio tipico della presenza del giudice popolare è che essa garantisce il supporto da parte della collettività alla funzione giurisdizionale, consentendo di aumentare la reattività da parte dell’organo giudicante ai valori dominanti della società, riducendo sensibilmente i contrasti e le riserve che il popolo possa avvertire nei confronti di una sentenza. Visto però da altro punto di vista, questo ha delle ripercussioni proprio sull’imparzialità che si richiede a un giudice, la quale potrebbe essere sensibilmente compromessa quando il giudice fosse ingiustamente influenzato dagli altalenanti umori della pubblica opinione, divenendo quasi succube di questa. Questo problema diviene ancora più rilevante oggigiorno, quando parlare degli omicidi più efferati nei maggiori media è diventata un’abitudine culturale, e non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, come l’Inghilterra e gli States, dove si è visto che potere sconfinato abbia la giuria.
Il problema si fa ancora più serio se si pensa che il fenomeno ha preso piede a tutti i livelli di comunicazione, quindi non solo sulla carta stampata e in televisione, dove la cronaca nera da sempre fa audience, ma almeno è soggetta a uno specifico controllo di veridicità delle informazioni fornite, ma anche sulla rete.
L’imparzialità del giudice popolare appare quindi un serio problema e diviene il rovescio della medaglia della naturale vicinanza sociale al caso di specie che rischia di tradursi in un giudizio viziato da una serie di elementi, in primis l’eccessiva emozionalità del giurato.
Tale decisione, infatti, può tendere a conformarsi con le idee espresse dall’opinione pubblica o, comunque, può esserne influenzata. Inoltre i giurati possono farsi guidare dalle loro emozioni personali quali la vendetta o le istanze di risentimento sociale, possono essere corruttibili o non culturalmente adeguati e, in tali ipotesi, le istruzioni della componente togata fornite all’inizio non sortiranno alcun effetto.
Dagli anni ’80, quando fu celebrato il processo di primo grado del capitano Basile, a oggi tutto il sistema mediatico è cambiato notevolmente: ai giornali cartacei e ai programmi di approfondimento televisivo si è affiancata la rete, all’interno delle quale testate online e blog affiancano l’informazione tradizionale e nella quale hanno sempre preso maggior rilevanza i social network.
E’ proprio all’interno di questi che si esercita la c.d. “democrazia virtuale”, quella in cui ognuno può esprimere, tra foto di gattini e di torte realizzate a casa, il proprio punto vista, linkare articoli di testate e, soprattutto, può scrivere ciò che vuole, spesso senza alcun rispetto del diritto d’autore e della veridicità delle fonti.
Quest’aspetto diviene particolarmente delicato quando l’argomento sono gli sviluppi di processi in corso che portano spesso, ignorando le istanze processuali, a affrontare con “professionalità” una materia della quale non si conosce nulla. Questo accade su molteplici argomenti.
Abbiamo avuto esperti di geopolitica, di virologia, di emergenza sanitaria che basano le proprie competenze ed il proprio curriculum su “quello che trovano in giro” senza curarsi dei contenuti, della veridicità delle fonti e del fatto che possano essere fake-news o, ancor peggio perché difficilmente smascherabili, notizie contraffate, ossia basate su un fatto vero ma che viene volutamente distorto.
Altro aspetto da non sottovalutare, sempre a proposito dei social network, è la possibilità della creazione di falsi profili che vengono definiti troll. Un troll, nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.
Ma non solo, perché troll può essere considerato anche un profilo aperto e gestito da una persona vera e non virtuale con l’unico scopo di divulgare tesi e, quindi, condizionare gli utenti rispetto a un determinato argomento. Questo nuovo aspetto definisce i cosiddetti troll 2.0. Difficile essere immuni, soprattutto perchè il troll 2.0 è una persona vera, magari parzialmente coinvolta con gli argomenti che tratta e spesso assume il ruolo di vittima del sistema. Questo è il caso più pericoloso, ma sempre più diffuso, perché trasformerà in troll 2.0 tutta la propria rete, che condividerà e appoggerà le sue tesi e opinioni mentre il troll 2.0 si assurgerà al ruolo di opinion leader, ossia a novello capo popolo.
È impossibile, del resto, anche solo pensare di poter invertire questa tendenza, o di poter sanzionare chi si lasci andare a tali esternazioni, in primis perché numericamente stiamo parlando di migliaia d’individui presi da questa specie di “sindrome di giudizio via web”, e soprattutto perché nel mondo attuale il web è alla nostra portata dappertutto, anche sul nostro telefono cellulare.
Si può ben comprendere come l’opinione del giurato rischi di formarsi aliunde e non nell’ambito del processo, in ossequio a quel principio dell’oralità del processo stesso che addirittura vieta, in alcuni Paesi degli Stati Uniti, al giurato di prendere appunti durante il dibattimento, proprio per evitare che possa rimanere maggiormente impressionato da un elemento in particolare rispetto alla complessità del processo, senza contare che tale convincimento che si crea fuori dall’unica sede a ciò deputata, non è solo il risultato della cronaca giornalistica, ma è appunto influenzato dall’opinione dei “pari”, da chi tramite un “post” su Facebook o Twitter può deliberatamente condannare o assolvere un imputato e se ciò risulta già aberrante da un punto di vista umano, a maggior ragione è da respingere da un punto di vista squisitamente giuridico.
Tornando a “La parola ai giurati”, nello sviluppo dell’opera non si racconta l’iter processuale, non si raccontano le udienze che hanno preceduto quello che è il cardine narrativo del film e di come, tra un’udienza e l’altra, il giudice popolare sia oggetto del sistema mediatico che lo circonda social compresi. A tutto ciò dobbiamo anche aggiungere programmi televisivi che, in evidente ricerca di audience fondamentale per la conferma della stagione successiva da realizzare, affrontano con toni scandalistici ed esplosivi gli argomenti processuali di cui trattano magari ripresentando tesi e argomenti già noti da anni e testate online che dichiaratamente basano le proprie scelte editoriali su battaglie e sponsorizzazioni culturali di persone che giocano il ruolo di attore in determinati contesti.
In questo preciso momento storico, alcuni processi riguardanti la criminalità organizzata di stampo mafioso e altri che riguardano corruttele realizzate attraverso dei veri e propri sistemi, sono nel pieno del proprio svolgimento.
Per citarne alcuni, potremmo pensare al processo di secondo grado sulla “Trattativa tra Stato e Mafia”, processo che si tiene a Palermo e al processo, in corso a Caltanissetta, sul cosiddetto “Sistema Montante”, che si celebra in Corte d’Appello.
Del secondo si parla troppo poco, come se fosse più interessante ridurlo, mediaticamente parlando, al silenzio mentre il primo è argomento quotidiano sia nei social network sia nei programmi televisivi. E proprio in questo caso i troll 2.0 sembrano assumere una grande importanza.
Se, dunque, si può ben comprendere come anche un giudice togato possa essere vittima di un pregiudizio e di un pre-convincimento nella sentenza finale che possano derivargli da questo fenomeno, ancor di più questo diviene vero e preoccupante se a giudicare non è più un soggetto a ciò deputato, e quindi per ciò stesso auto-disciplinato a rimanere estraneo a ciò che avviene fuori dal processo, ma un soggetto chiunque preso dalla collettività e dunque ancor più esposto al bombardamento d’informazioni e alla sua conseguente influenza, al punto da ingenerare il sospetto di un plagio, o se non altro di una non più possibile imparzialità verso quel caso.
Con ciò non si vuole puntare il dito accusatorio nei confronti dei giudici popolari dei processi citati presi esclusivamente ad esempio, ma porre in evidenza come una ricchezza del nostro sistema giustizia possa diventare, oggi più che mai, un’arma a doppio taglio riguardo all’imparzialità che i giudici, sia togati sia popolari, devono mantenere.
Sempre a proposito dei giudici popolari, proprio in questi giorni è stata annunciata la messa in onda sulle piattaforme Rai, dell’ultimo lavoro firmato da Francesco Miccichè dal titolo “Io, una giudice popolare al maxiprocesso”.
È la storia di una professoressa e due casalinghe con la fascia tricolore, accanto ai giudici Alfonso Giordano e Pietro Grasso, di fronte a Liggio, Bagarella, Calò, a boss e sicari. Tra i protagonisti Donatella Finocchiaro e Nino Frassica. Si tratta di uno spaccato familiare che rivela le angolature di un impegno civile, spesso non colto da tanti semplici cittadini chiamati in periodo storico ad un ruolo così importante.
Ricordiamo che molti magistrati rinunciarono a presiederlo e non fu un caso che a presiedere la corte arrivò un giudice del Civile, il dottor Alfonso Giordano, che contrariamente a molti suoi colleghi non presentò certificati medici per ottenere l’esonero.
Come accadde anche per molti dei sorteggiati della giuria: timorosi impiegati, professionisti, commercianti.
Non fu così per le tre donne che sono raccontate nella docufiction che ripercorre anche i momenti delle minacce e dei rischi personali e familiari corsi dalle coraggiose giurate.