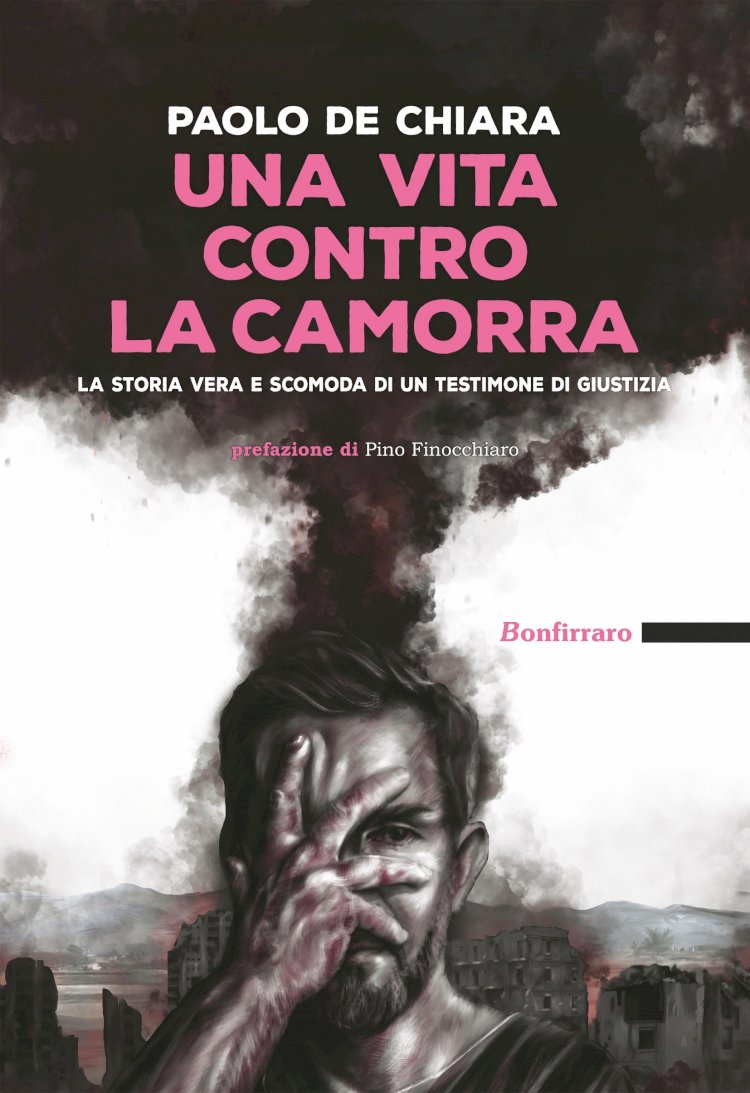Cinquantasette anni dopo: cosa è rimasto dell' «I have a dream»?
Il 28 agosto 1963 Martin Luther King pronunciava il suo discorso più famoso dal palco di Washington, al Lincoln Memorial.

Avevo un sogno. L'ho perso.
Sognavo che i miei quattro figli potessero vivere in una nazione nella quale non dovessero essere giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere.
Sognavo un Paese in cui gli uomini e le donne di colore non fossero vittime degli indicibili orrori ai quali venivano sottoposti dalla polizia.
Sognavo un tempo in cui la mia nazione potesse elevarsi dalle sabbie mobili dell'ingiustizia razziale su fino alla solida roccia della fratellanza.
Avevo un sogno. L'ho perso.
Erano tempi duri quelli degli anni Sessanta, negli Stati Uniti. La mia gente era oppressa, segregata, ammassata negli angoli più sudici della società.
Era ipocrita l'America a quei tempi. L'America che sfrecciava sulle strade larghe che odoravano di sogni e che poi costringeva le persone di colore a vivere nella povertà, nella paura, nella soggezione. L'America che fabbricava speranze a colori nei capannoni di Hollywood e che poi lasciava morire esseri umani per una variazione cromatica della pelle.
Avevo un sogno. Lo dissi al mondo intero da sopra un palco di Washington, il 28 agosto del 1963. Quelle stesse parole le avete trascritte con inchiostro indelebile. Le avete incise, intagliate col fuoco nel marmo dei monumenti, sui libri di scuola, nelle targhe lucenti dei parchi. Ne avete fatto canzoni, striscioni, inni alla libertà.
Mi avete intitolato piazze, edifici scolastici, strade, musei. Avete scritto libri e girato film sul mio sogno, ne avete tagliuzzato delle parti per tirarne fuori slogan e aforismi. Mi avete dato un'altra vita dopo la mia morte, illudendomi che qualcosa stesse davvero cambiando. Ho creduto, quando già non c'ero più, che l'America potesse aspirare a diventare veramente il Paese che sognavo per i miei figli e per i figli dei miei figli.
Poi, invece, avete costretto il mondo a imparere i nomi di George Floyd e Jacob Blake. E di tutte le vittime che ogni anno, ogni mese, ogni giorno, pagano per il colore della loro pelle. E pagano con la vita. Avete oscurato il mio I have a dream con un dilaniante e terrificante I can't breathe. Avete tirato giù il mio sogno dai balconi, lo avete srotolato dalle statue, dalle bandiere colorate sopra i tetti delle case e lo avete trascinato in strada calpestandolo e umiliandolo.
Avete annacquato il significato di fratellanza persino in un'epoca in cui un virus invisibile e sconosciuto ci ha insegnato che, difronte alla vita, siamo davvero tutti uguali.
L'America non è un Paese razzista, tuonano i potenti dai palchi agghindati di stelle e strisce per smerciare un po' di propaganda a buon mercato. Il Covid non esiste, i migranti sono i cattivi e l'America non è razzista. È questo il nuovo claim del millennio.
Poi però il Covid fa più danni di un immigrato irregolare e la macchina propagandistica non sa come spiegarlo. Poi però nei palazzetti non si gioca più e una spiegazione al mondo bisognerà pur darla. Perché finisce sempre così: la politica si tura il naso e sono altri a dover aprire le finestre.
Negli Stati Uniti lo ha fatto lo sport, con il gesto più bello di sempre. I Milwaukee Bucks si sono fermati nel momento più eccitatnte della stagione e, con loro, tutto il basket, poi il baseball e il calcio. Lo show stavolta si è fermato per davvero.
Avevo un sogno, ma non credevo che per ricordarlo al mondo persino i palloni dovessero smettere di palleggiare.
Avevo un sogno. Lo avete usato per sciacquarvi la bocca, poi lo avete buttato via. Come carta straccia sul fondo di una pozzanghera.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright WordNews