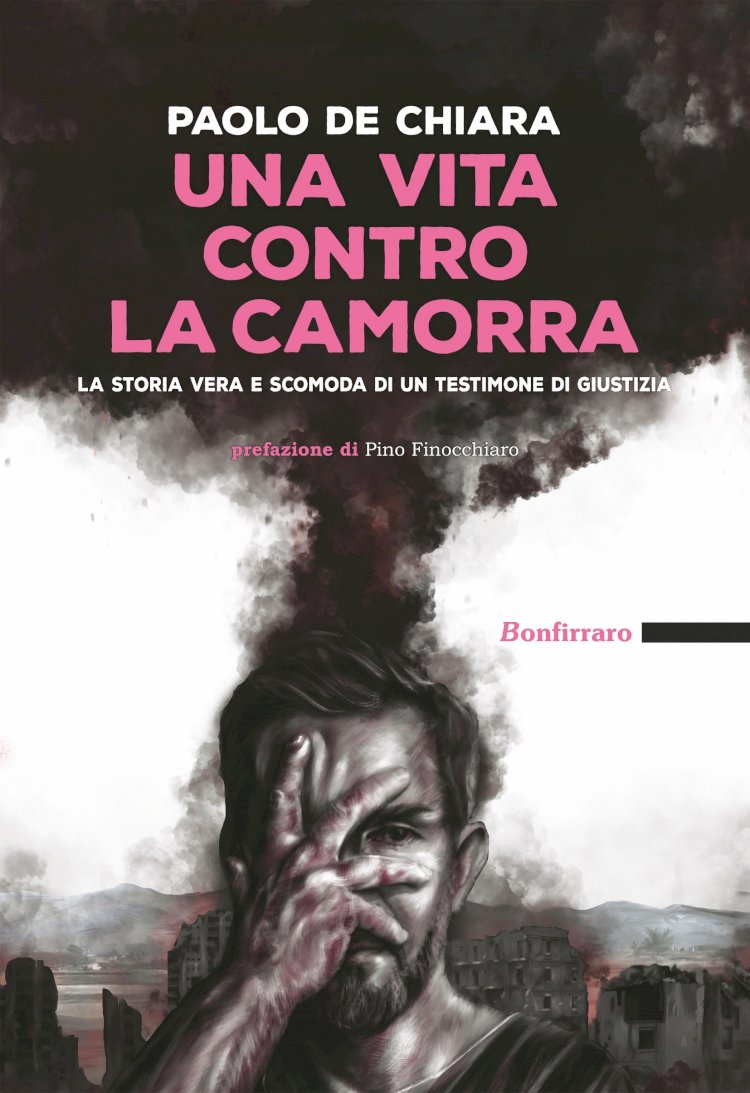Addio a Gianni Minà, un maestro di giornalismo
AUTORE DI STORICHE INTERVISTE. «Sono nato giornalista, lo sono stato, lo sono e lo sarò». Gli inizi della carriera nel 1959 come giornalista sportivo per Tuttosport. Ha incontrato e intervistato, con il suo stile, i grandi della terra. Aveva 84 anni.

Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari.

Ho passato una vita a raccontare storie, paesi, persone diventate amiche ininterrottamente, per più di 60 anni.
Se potessi continuerei ancora il mio lavoro di cronista che mi è entrato nelle ossa. Non potrei essere nessun'altra persona.
Ho cercato di raccontare la mia storia, le mie radici per lasciare una traccia alle mie figlie, e a chi mi vuole conoscere meglio.
Non credo ci sia bisogno di altro.
Gianni Minà, dal profilo fb
Lo vogliamo ricordare con le sue parole.
A DIEGO
di Gianni Minà
Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco.
Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista.
Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di proporgli domande scabrose.
So che la comunicazione moderna spesso crede di poter disporre di un campione, di un artista soltanto perché la sua fama lo obbligherebbe a dire sempre di sì alle presunte esigenze giornalistiche e commerciali dell’industria dei media.
Maradona, che ha spesso rifiutato questa logica ambigua, è stato tante volte criminalizzato.
Una sorte che non è toccata invece, per esempio, a Platini, che come Diego ha detto sempre no a questa arroganza del giornalismo moderno, ma ha avuto l’accortezza di non farlo brutalmente, muro contro muro, bensì annunciando, magari con un sorriso sarcastico, al cronista prepotente o pettegolo “dopo quello che hai scritto oggi, sei squalificato per sei mesi. Torna da me al compimento di questo tempo.”
Era sicuro, l’ironico francese, che non solo il suo interlocutore assalito dall’imbarazzo non avrebbe replicato, ma che la Juventus lo avrebbe protetto da qualunque successiva polemica.
A Maradona questa tutela a Napoli non è stata concessa, anzi, per tentare di non pagargli gli ultimi due anni di contratto, malgrado le tante vittorie che aveva regalato in pochi anni agli azzurri, nel 1991 gli fu preparata una bella trappola nelle operazioni antidoping successive a una partita con il Bari, in modo che fosse costretto ad andarsene dall’Italia rapidamente.
Eppure nessuno, né il presidente Ferlaino, né i suoi compagni (che per questo ancora adesso lo adorano) né i giornalisti, né il pubblico di Napoli, hanno mai avuto motivo di dubitare della lealtà di Diego.
Io, in questo breve ricordo, a conferma di questa affermazione, voglio segnalare un semplice episodio riguardante il nostro rapporto di reciproco rispetto.
Per i Mondiali del ’90, con l’aiuto del direttore di Rai Uno Carlo Fuscagni, mi ero ritagliato uno spazio la notte, dopo l’ultimo telegiornale, dove proponevo ritratti o testimonianze dell’evento in corso, al di fuori delle solite banalità tecniche o tattiche. Questa piccola trasmissione intitolata “Zona Cesarini”, aveva suscitato però il fastidio dei giovani cronisti d’assalto (diciamo così...) che occupavano, in quella stagione, senza smalto, tutto lo spazio possibile ad ogni ora del giorno e della notte. La circostanza non era sfuggita a Maradona ed era stata sufficiente per avere tutta la sua simpatia e collaborazione.
Così, nel pomeriggio prima della semifinale Argentina-Italia, allo stadio di Fuorigrotta di Napoli, davanti a un pubblico diviso fra l’amore per la nostra nazionale e la passione per lui, Diego, mi promise per telefono: “Comunque vada verrò al tuo microfono a darti il mio commento. E tengo a precisare, solo al tuo microfono.”
La partita andò come tutti sanno. Gol di Schillaci e pareggio di Caniggia per un’uscita un po’ avventata di Zenga.
Poi supplementari e calci di rigore con l’ultimo, quello fondamentale, messo a segno proprio da quello che i napoletani chiamavano ormai “Isso”, cioè Lui, il Dio del pallone.
L’atmosfera rifletteva un grande disagio. Maradona, per la seconda volta in quattro anni, aveva riportato un’Argentina peggiore di quella del Messico, alla finale di un Mondiale che la Germania, qualche giorno dopo, gli avrebbe sottratto per un rigore regalato dall’arbitro messicano Codesal, genero del vicepresidente della Fifa Guillermo Cañedo, sodale di Havelange, il presidente brasiliano del massimo ente calcistico, che non avrebbe sopportato due vittorie di seguito dell’Argentina, durante l’ultima parte della sua gestione.
C’erano tutte le possibilità, quindi, che Maradona disertasse l’appuntamento. E invece non avevo fatto a tempo a scendere negli spogliatoi, che dall’enorme porta che divideva gli stanzoni delle docce dalle salette delle tv, comparve, in tenuta da gioco, sporco di fango e erba, Diego, che chiedeva di me, dribblando perfino i colleghi argentini. C’era, è vero, nel suo sguardo, un’espressione un po’ ironica di sfida e di rivalsa verso un ambiente che in quel Mondiale, non gli aveva perdonato nulla, ma c’era anche il suo culto per la lealtà che, per esempio, lo aveva fatto espellere dal campo solo un paio di volte in quasi vent’anni di calcio.
Cominciammo l’intervista, la più ambita al mondo in quel momento, da qualunque network.
Era un programma registrato che doveva andare in onda mezz’ora dopo, perché più di trent’anni di Rai non mi avevano fatto “meritare” l’onore della diretta, concessa invece al cicaleccio più inutile.
Ma a metà del lavoro eravamo stati interrotti brutalmente non tanto da Galeazzi (al quale per l’incombente tg Diego concesse un paio di battute) ma da alcuni di quei cronisti d’assalto che già giudicavano la Rai cosa propria e che pur avendo una postazione vicina ai pullman delle squadre, volevano accaparrarsi anche quella dove io stavo intervistando Maradona. El Pibe de Oro fu tranciante: “Sono qui per parlare con Minà. Sono d’accordo con lui da ieri. Se avete bisogno di me prendete contatto con l’ufficio stampa della Nazionale argentina. Se ci sarà tempo vi accorderemo qualche minuto.” Aspettò in piedi, vicino a me, che terminasse l’intervista con un impavido dirigente del calcio italiano, disposto a parlare in quella serata di desolazione, poi si risedette, battemmo un nuovo ciak e terminammo il nostro dialogo interrotto. Quella testimonianza speciale, di circa venti minuti, fu richiesta anche dai colleghi argentini, e andò in onda (riannodate le due parti) dopo il telegiornale della notte.
Fu un’intervista unica e giornalisticamente irripetibile, solo per l’abitudine di Diego Maradona a mantenere le parole date.
Lo stesso aveva fatto per i Mondiali americani del ’94 quando aveva accettato per due volte di ritornare all’attività agonistica in nazionale prima per assicurare la partecipazione alla querida Argentina nel match di spareggio contro l’Australia e poi giocando tre partite all’inizio dei Mondiali stessi, prima che lo fermassero. Eppure, val la pena ricordarlo, nel momento in cui, con un'accusa ridicola era stato sospeso per doping dopo le prime due partite.
La Federazione del suo amato paese non aveva mandato nemmeno un avvocato a respingere legalmente l’imputazione che non stava in piedi: “Hanno preferito trafiggere con un coltello il cuore di un bambino” aveva commentato Fernando Signorini, il suo allenatore e consigliere, quando la mattina dopo ci eravamo incontrati.
L’intervista da un motel dove aveva soggiornato con i parenti l’avevo ottenuta io. I giapponesi l’avevano mandata in diretta e i francesi in differita, un po’ di ore dopo, non credendola possibile.
Così, insomma, questo modo di comportarsi da grande e da piccino lo ha portato a superare ogni avversità e pericoli - anche quelli che sembravano impossibili - della sua esistenza.
Dalla polvere di Villa Fiorito, nella provincia di Buenos Aires, dove è cominciata la sua avventura di più grande calciatore mai nato alla militanza politica nei partiti progressisti latinoamericani per i quali ha dato molte volte la propria faccia.
Nessun calciatore è mai arrivato a tanto.
Diego, per una ironia del destino, se n’è andato da questo mondo lo stesso giorno di un altro gigante, Fidel Castro.
Alla fine li rimpiangeremo, come succede a chi ha lasciato una traccia indelebile nel gioco del calcio e della vita.
E ora silenzio.
Il suo prezzo al mondo del pallone lo ha pagato da tempo.

LULA VA, ANCORA UNA VOLTA.
di Gianni Minà
A febbraio del 2020 sono andato ad ascoltare Lula alla sede della CGIL di Roma, subito dopo la sua scarcerazione da quelli che sono stati i due processi farsa. Chi lo aveva preceduto nel suo discorso spiegò dettagliatamente le fasi e le procedure di quello che era stato un golpe giudiziario. “Sono un settantaquattrenne, ma mi sento l’energia di un ventenne. Non mi arrenderò” aveva detto in quella che era la sua prima uscita pubblica per il lancio della sua candidatura nelle elezioni di quest’anno.
Lula, due volte presidente del Brasile (dal 2002 al 2010) era stato condannato senza prove per un presunto affaire proprio con la compagnia petrolifera di Stato, la Petrobras; questo intrigo con le fattezze del colpo di Stato era stato messo in moto da pezzi della Confindustria brasiliana che non avevano gradito il fatto che l’ex presidente, dopo che la Petrobras aveva scoperto e messo le mani nella propria costa Ovest sul più grande giacimento sottomarino del mondo, il Pre-Salt, si fosse negato a condividere la scoperta con gli Stati Uniti.
Uno spettacolo già visto e messo in atto molte volte specie dal governo di Washington che quando si tratta di petrolio, mette in cantiere guerre inutili e feroci.
Lula aveva provato a rompere questa logica ed è stato punito.
Anche se era stato il primo presidente democratico eletto e confermato dopo gli anni lugubri della dittatura militare, in quello che, con 214 milioni di abitanti, è lo Stato più poderoso dell’America Latina, agli occhi del governo di Washington però era stato il complice dell’ex presidente venezuelano Hugo Chávez nel ricambio progressista che il continente a Sud del Texas aveva avuto negli ultimi vent’anni. Anni in cui alcune nazioni si erano consociate in scelte libertarie arrivando a fondare, sull’esempio della Comunità europea, perfino una banca e una televisione continentale, come Telesur per controbattere l’informazione scorretta della CNN e di altri network privati normalmente proprietà di caciques abituati a calcare pedissequamente la linea degli Stati Uniti.
Ma sembra passato un secolo, più che una manciata di anni.
Dal 2016 Lula dunque era stato condannato in procedimenti penali che la difesa ha sempre definito “persecutori” e basati su falsità processuali. Nel 2021, dopo una serie di ricorsi, il giudice della Corte Suprema Edson Fachin aveva annullato non solo tutte le condanne a carico dell’ex presidente per “incompetenza territoriale e materiale” comminate dal giudice federale del Paranà Sergio Moro, ma aveva riconosciuto anche la sua parzialità. Lo stesso Moro, che fu nominato subito dopo questo processo, ministro della Giustizia dal governo di Bolsonaro ed era lo stesso Moro che aveva annunciato di candidarsi per la corsa alla Presidenza, ma che a marzo di quest’anno aveva deciso di ritirarsi.
Secondo Fachin infatti, sia i procuratori, sia i giudici avevano costruito prove contro Lula dando vita, con la collaborazione delle famigerate multinazionali nordamericane e con l’appoggio vitale di Tele Globo, il più poderoso network radiotelevisivo del continente, ad una campagna stampa mirata sia a distruggere la reputazione dell’ex presidente del Brasile presso l’opinione pubblica, sia soprattutto a consolidare le prove a suo stesso carico.
La Commissione Onu su questo processo aveva ritenuto che “le violazioni procedurali (…) avevano reso ‘arbitrario’ il divieto a Lula di candidarsi alla presidenza, denunciando la violazione dei suoi diritti politici, compreso il diritto di candidarsi alle elezioni. (…) E sebbene la Corte Suprema Federale abbia annullato la condanna e la reclusione di Lula nel 2021, queste decisioni non sono state sufficientemente tempestive ed efficaci per prevenire o riparare le violazioni”.
Comprese quelle relative, aggiungo io, alla negazione al permesso di uscire di prigione per partecipare alle esequie del fratello morto di cancro nel 2019 adducendo a “motivi di sicurezza”. Però, mossi a pietà, avevano concesso a Lula il permesso di un giorno per assistere ai funerali del nipotino deceduto per una meningite fulminante.
Ho conosciuto Lula, prima che diventasse presidente, grazie ad Antonio Vermigli, un generoso ex-postino di Quarrata che tiene in mano da molti anni la Rete Radié Resch (una rete della sinistra cattolica).
Lula veniva in Italia invitato dai vari sindacati e avevo imparato ad apprezzarlo proprio per essere riuscito nel miracolo di fondare il PT (Partido dos Trabalhadores) che, insieme ai cattolici progressisti e al movimento dei Sem Terra, lo aveva portato al governo del paese smentendo chi aveva tentato di sostenere “che i comunisti stavano per prendere il potere in Brasile”. Questo perché il PT era diventato l’esempio del più efficiente movimento progressista in quella che all’epoca è stata una vera e propria primavera dell’America Latina.
Egli si rifaceva al pensiero di Paulo Freire, pedagogo di fama mondiale impegnato nei confronti dei poveri e considerato, insieme al nostro Lorenzo Milani, uno dei pilastri del pensiero riguardante l’educazione democratica del Novecento, che si schiera in favore degli oppressi e per la dimensione collettiva del sapere e la giustizia sociale come processo di trasformazione, sia personale che sociale. Per Freire, infatti, il sapere esteso a tutti fa acquisire coscienza critica e la giustizia sociale è il fondamento per lo smantellamento delle strutture di oppressione.
L’entusiasmo e la sincerità di questo ex-operaio della Volkswagen, che al suo mestiere di tornitore aveva sacrificato il dito di una mano (“Ho perso questo dito quando avevo diciassette anni – raccontò una volta - Era proibito, per legge, lavorare di notte, ma lo facevamo ugualmente, per sopravvivere. Fu così che subii questo infortunio. Ne vado fiero. Non lo vedo come un difetto fisico, ma come il marchio registrato della vita e degli impegni che ho preso con la classe lavoratrice brasiliana”) aveva permesso ai brasiliani di ricominciare a sperare attraverso iniziative come il piano Fame Zero messo in piedi dal teologo della Liberazione Frei Betto che su incarico di Lula era riuscito nell’impresa di assicurare a 50 milioni di abitanti, i più poveri, tre pasti al giorno.
Era un nuovo mondo che si scrollava di dosso la dittatura militare e incominciava a diventare un esempio politico, mettendo in crisi perfino pezzi di socialismo occidentale.
Mi ricordo infatti che in quel periodo D’Alema invitò a Firenze quasi tutti i leader socialisti delle nazioni più importanti. A sorpresa però per il Brasile, non si ricordò di invitare Lula Da Silva, il leader di 50 milioni di brasiliani che votarono a sinistra. Preferì trasmettere l’invito a Fernando Henrique Cardoso, leader della coalizione di centro destra che governava in quel momento.
La giustificazione? Cardoso in gioventù era stato un sociologo progressista che D’Alema probabilmente aveva letto. Lula con bonomia giustificò questa gaffe: “Ho esaminato tutti i discorsi di Cardoso quando era fuori dal Brasile ed era professore alla Sorbona. Tutti i suoi discorsi pronunciati a Parigi, a Roma, e in Europa. In quelle prolusioni appariva un cittadino progressista, un sociologo progressista, un uomo di mondo preoccupato per le ferite dell’umanità. Il problema per noi è che le teorie che affermava in Europa non le ha mai messe in atto in Brasile. Sarebbe quindi importante che i dirigenti europei venissero a vedere cosa ha combinato nel nostro paese, per constatare che le sue scelte non hanno avuto nessuna attinenza con le parole pronunciate da voi. A Firenze, Cardoso sembrava perfino un socialista, mentre qui ha attuato una politica totalmente di destra”.
Lula raccontò anche che quando D’Alema volò a Rio con Fassino per il summit dell’Internazionale socialista, la prima cosa che fece fu chiedere una mozione di censura per Cuba. Fu lo stesso Lula, che pure è un moderato, a ricordare alla delegazione italiana che “per la maggior parte dei latinoamericani la Revolución è un esempio indiscutibile”.
Oggi il panorama politico internazionale è cambiato profondamente e le elezioni presidenziali brasiliane sono state un banco di prova fondamentale perché questo enorme Paese che rappresenta una delle più importanti economie del mondo ha un’influenza decisiva in America Latina. La storia del Brasile negli ultimi dieci anni è stata molto intensa: la rivolta sociale del 2013 che ha espresso disagio verso il sistema politico; la crescita del PSDB a un passo dal PT; la presidenza di Dilma Rousseff come tentativo di fermare le destre e il suo rovesciamento nel 2016 attraverso un colpo di stato fatto passare attraverso il suo impeachment; la presidenza di Bolsonaro, rappresentante di una vecchia destra e responsabile della sua radicalizzazione e infine la criminalizzazione di Lula con due processi farsa.
La vittoria di Lula è stata sul filo del rasoio, ottenuta dopo una corsa elettorale drammatica farcita da colpi bassi e fake news da entrambe le parti.
Intorno a Lula si è raccolta una grande coalizione politica formata da partiti, dai più importanti movimenti e dai più importanti centri sindacali del Paese: il Partito dei Verdi (PV), il Partito Comunista del Brasile (PCdoB), il Partito Socialista e Libertà (PSOL), il Movimento Sem Terra (MST), il Movimento de Trabalhadores por Direitos (MTD) e il Levante Popular da Juventude.
La chiave di volta di Lula è stata però la candidatura alla vicepresidenza di Alckmin, fondatore insieme a Cardoso del Partito Socialdemocratico brasiliano, proprio quel PSBD attore chiave del rovesciamento della Roussef. Alkmin è stato sempre un oppositore del Partito dei Lavoratori ma, nel 2021 si è dimesso dal PSBD per unirsi al Partito Socialista Brasiliano (PSD) lanciando la sua candidatura alla vicepresidenza del suo ex rivale Lula da Silva.
Ma in questo intricato patchwork Alckim garantisce la governabilità, perché sono i tucanos che storicamente governano nei gangli più strategici il Brasile, a prescindere dall’esecutivo di turno. In più la sua figura ha attirato l’elettorato di centrodestra spaventato dalla destra “cattiva” rappresentata da Bolsonaro. Nel suo mandato infatti l’ex presidente, con passi da gambero, ha fatto passare le tre riforme regressive sul lavoro, sulla previdenza sociale (dove si limita la spesa sociale dello Stato per vent’anni) e fiscale, con la benedizione degli Stati Uniti. La carcerazione di Lula infatti era soprattutto volta a impedire queste tre riforme. Ma Bolsonaro non ha prodotto gli effetti sperati, anzi: nel suo mandato 28mila industrie sono state chiuse, l’inflazione e il disagio sociale sono aumentati fino ad arrivare al punto più drammatico con la pandemia da Covid-19 che ha provocato quasi 700mila morti tutti addebitabili all’incoscienza di questo ex presidente che, con i suoi discorsi antiscientifici, è riuscito a cambiare radicalmente la reputazione di questa nazione, costruita a fatica da Lula dieci anni prima durante i suoi due mandati. Sono ancora vividi gli appelli accorati di aiuto dei brasiliani e le foto delle fosse a cielo aperto pieni di cadaveri ammassati.
Oggi, con anche l’appoggio di gran parte della borghesia brasiliana, il PT di Lula è un grande fronte democratico. Bisogna capire però se riuscirà a fare quello che non è riuscito a ottenere nei due precedenti mandati, ma soprattutto se avrà le condizioni politiche per realizzare i suoi scopi, che sono quelli di sempre: riforme politiche e sociali, lotta alla fame e alla disoccupazione, aumento della qualità della salute e dell’istruzione e la conservazione dell’ambiente.
Ma il fronte democratico è un po’ lo specchio dello stesso PT che racchiude in sé un po’ di tutto ed è questa la sua grandezza, considerato che oggi non è importante tanto vincere, quanto governare in modo equilibrato e onesto: “Questo partito, nella storia politica del Brasile degli ultimi anni, è forse il più pluralista del paese – mi disse Lula in una mia intervista - Abbiamo marxisti, ecologisti, credenti cattolici, protestanti, evangelici. C’è chi si batte per Cuba, chi apprezza la nuova politica cinese. Abbiamo musulmani, buddisti laici. C’è pluralismo effettivo nel Pt. Siamo riusciti a dimostrare l’importanza di una democrazia vissuta nella diversità. Ma non ci interessa che tutti tifino per la stessa squadra di calcio. Non abbiamo bisogno che a tutti piaccia lo stesso colore per convivere democraticamente e in modo sano. Il Pt è questo: viviamo in modo sereno. Siamo diversi, ma concordiamo sui punti essenziali. Crediamo sia possibile costruire un altro Brasile, ma certo la chiesa progressista, il movimento popolare, le comunità di base e il movimento sindacale sono le principali ragioni del successo del Pt”.
Frei Betto che lo ha appoggiato ma anche criticato, oggi sostiene: “Il modo di rafforzare il governo Lula non è propriamente negli accordi dietro le quinte, nelle alleanze di partito, nei patti federativi. Questa strada è già stata percorsa ed è sfociata in scandali e sconvolgimenti. Non ci si può fidare di un gioco in cui il partner non si comporta bene. Il rammendo fatto sopra favorisce sempre chi disprezza quello che sta sotto. Il cammino da intraprendere è quello della coscientizzazione, organizzazione e mobilitazione popolare. Senza persone per strada e nelle reti il governo Lula correrà anche un rischio di impeachment. Per consolidarsi dovrà soddisfare la fame di pane e anche la fame di bellezza attraverso l’educazione politica del popolo”.
Staremo a vedere, ma l’araba fenice comincia a rinascere.