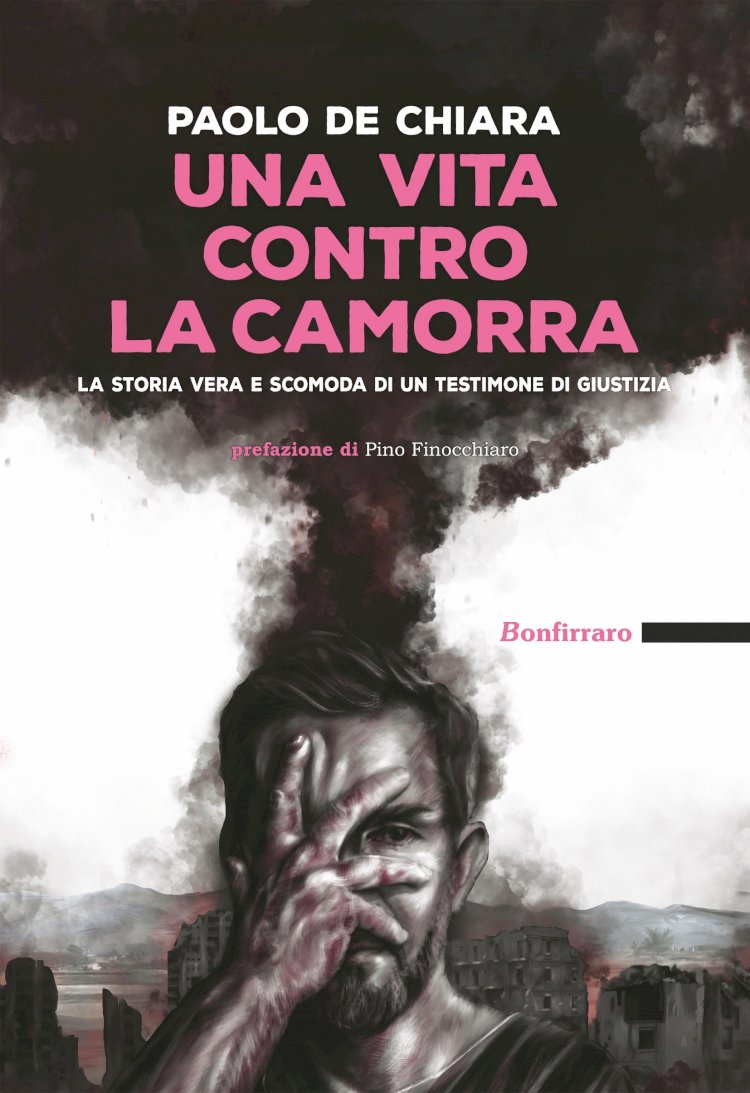Beppe Fenoglio, scrittore partigiano e partigiano scrittore
Sono passati cinquantotto anni dalla morte di Beppe Fenoglio, il più realista dei romantici e il più romantico dei realisti. Uno scrittore non allineato, un eretico. Un uomo sfortunato, apprezzato davvero solo dopo la morte. Un partigiano nello spirito, che ha tenuto fede alla promessa di impegnarsi a dir di no fino in fondo.
Partigiano, come poeta, è parola assoluta.
Ci si può cucire sopra una vita, un'avventura straordinaria. È un vecchio baule scassato dal quale si possono tirare fuori storie che riempiono l'anima, un pezzettino alla volta. Storie che aprono squarci, ci guardano dentro. Storie che profumano.
La storia di Beppe Fenoglio sembra tirata fuori da un baule così. Dentro c'è la sua straordinaria esperienza di vita, il suo definirsi attraverso scelte dolorose e irripetibili. Dentro c'è la storia di una generazione intera, lacerata dalla guerra. Quella stessa generazione che ci ha consegnato questo presente buono, sorto dalle ceneri delle città abbattute, del sangue versato.
È stato uno scrittore sfortunato, Fenoglio. Un uomo sfortunato. Nato quando la notte fascista calava sul Paese, imponendo a ciascuno l'improcrastinabile scelta tra libertà e acquiescenza, tra lotta e indifferenza. Gli è stata rubata la giovinezza, strappata dall'implacabilità di un tempo che si consumava sui lati opposti di una barricata.
Fenoglio è stato uno scrittore partigiano e un partigiano scrittore. Mai troppo apprezzato in vita, se non da intelligenze vivaci come quella di Calvino, che di lui disse, commentando Una questione privata, “riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato”.
Attaccato dalla critica, azzoppato dagli editori, lo scrittore Fenoglio non ebbe grande fortuna in vita. Parlavano del suo stile e della sua visione come di “gretta acredine filistea”. La sua opera fu definita un “brutto capitolo nella letteratura della Resistenza”, un “contrabbando miserevole”, fatto di “ignobili racconti”, “brutte parole” e “tono qualunquista”.
Fenoglio era un non allineato, un eretico. E come tale venne percepito. Raccontava la Resistenza per quello che era stata, un'esperienza cruda, fatta anche di tante contraddizioni. Non ci metteva quell'enfasi retorica che il sentimento comune avrebbe voluto sentire. Non partecipava al racconto ufficiale, cercava di trasmettere il proprio. Per questo non poteva andare, per questo la critica lo massacrò. Aveva già superato la fase dell'enfasi ridondante, dell'uniformazione alla voce unica del post Resistenza. Aveva anticipato i tempi, era già avanti di qualche decennio.
Sempre nel “wrong sector of the right side”. Non fu garibaldino e neppure compiutamente badogliano. Ma fu certamente partigiano.
I personaggi di Fenoglio sono schiacciati dalla storia. Dalla guerra, dalla povertà, dalla miseria, ma anche da un male più assoluto. Sono uomini soli, soldati che devono sopravvivere alla natura, alle logiche sballate di un mondo storto. Combattono l'ingiustizia, la violenza insita nell'animo umano. Anche senza speranza di vittoria, solo perché si sono impegnati a dir di no fino in fondo.
“La virtù di Fenoglio è una virtù eminentemente passiva”, ha scritto Valter Boggione. Consiste nella forza dell'attesa, nella resistenza a oltranza. Non solo contro i fascisti, ma contro le storture del mondo. Contro la rassegnazione, l'indifferenza, l'assuefazione, l'accondiscendenza.
I'll go on to the end, I'll never give up, dice il partigiano Johnny. L'importante era che ne restasse sempre uno, di partigiano.
“Alla radice del mio scrivere c'è una primaria ragione che nessuno conosce all'infuori di me”. È la ragione del sopravvissuto, di quello che ne è uscito vivo mentre tutti gli altri sono morti. È forse il senso di colpa del superstite, del reduce che non riesce ad adattarsi.
“Io non mi trovo in questa vita perché ho fatto la guerra – dice Ettore ne La paga del sabato - Ricordatene sempre che io ho fatto la guerra, e la guerra mi ha cambiato, mi ha rotto l'abitudine a questa vita qui”.
Il 18 febbraio del 1963, Beppe Fenoglio muore a Torino, a poche settimane dal suo quarantunesimo compleanno. Sono passati quasi sessant'anni.
“Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano”. (I ventitré giorni della città di Alba). Scrittore partigiano e partigiano scrittore. Il più realista dei romantici e il più romantico dei realisti.
La sua scrittura così ricca di immagini, suoni, profumi, è davvero un'esperienza incomparabile e di rara bellezza. Non si può essere antifascisti senza subire il fascino di Beppe Fenoglio, senza lasciarsi attraversare dalla sua forza dell'attesa, dalla resistenza come dimensione morale oltre che esperienza storica. I suoi non sono neppure libri, racconti. Sono atti di fede, promesse solenni. Perché in mezzo alla neve e al fango, tra gli spari e i morti ammazzati, tra le contraddizioni e le incoerenze di un tempo che chiede di schierarsi, Fenoglio ci restituisce un mondo ad altezza d'uomo, un mondo in cui è necessario saper lottare “non solo senza paura, ma anche senza speranza” come ricordava Sandro Pertini, il Presidente partigiano.
“Stanno facendovi cascare come passeri dal ramo. E tu, Johnny, sei l'ultimo passero su questi rami, non è vero? […] Dà retta a me, Johnny. La tua parte l'hai fatta, la tua coscienza è sicuramente a posto. Dunque smetti tutto e scendi in pianura”, dice il mugnaio a Johnny. No, mai. “Mi sono impegnato a dir di no fino in fondo”.
Dir di no fino in fondo. Cinquantotto anni dopo, Fenoglio sa ancora indicarci la via.
WORDNEWS.IT © Riproduzione vietata