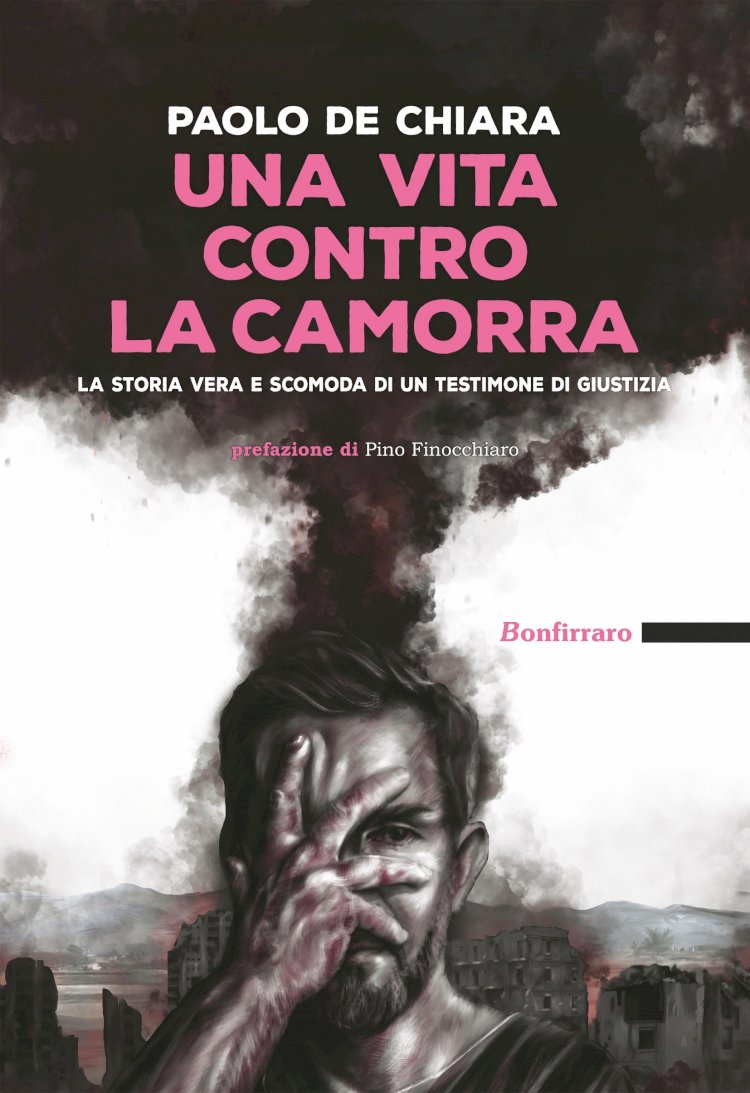Firenze al tempo del Covid-19
«Non ci sono trincee, non ci sono spari e non ci sono bombardamenti. Ma ci sono i caduti. Ho amici bergamaschi. Sento i loro racconti al telefono e mi rendo conto che la situazione (la diffusione del contagio, lo spavento e lo sgomento diffuso, il numero dei morti, portati via senza esequie, la sanità, puntellata dall’abnegazione di medici, infermieri e volontari, che tuttavia è al collasso) è molto più grave di come non la dipingano i TG».

Fa quasi spavento, in questi giorni, la bellezza di Firenze. Che è l’ineguagliabile città di sempre, un luogo che vive di una grazia, insieme, «teologale e umana», come scrisse il prete-contadino-poeta David Maria Turoldo in un suo testo (pubblicato anni fa su «Testimonianze», la rivista della cultura del dialogo fondata da Ernesto Balducci) significativamente intitolato L’anima misteriosa di Firenze. Una città-mondo e un luogo-simbolo.
Che però ha, adesso, strade e piazze completamente vuote, avvolte in un silenzio irreale. Un silenzio e un vuoto che colpiscono e impressionano. In una delle ultime iniziative pubbliche cui ho partecipato prima che l’emergenza incredibilmente sopraggiunta sovvertisse tutto, il tema all’ordine del giorno era quello dell’« overtourism», cioè del rischio di soffocamento di importanti centri storici (ridotte a «città Disneyland») ad opera di una massa numerosissima di turisti, mosso prevalentemente da pulsioni di carattere consumistico. Un tema che oggi sembrerebbe, drammaticamente stravagante. I turisti, presenti in maniera spesso invasiva (con intere porzioni di palazzi del centro storico destinate ormai agli affitti - di pochi giorni di durata - per visitatori di passaggio), oggi sembrano essersi dileguati. Improvvisamente, se ne sente la mancanza. Il supplemento Affari & Finanza di un quotidiano a larga diffusione titola oggi Allarme turismo zero. Chiusi, sprangati a decine pub, locali destinati alla ristorazione, caffetterie, bar.
Il rito del cappuccino seduti ad un tavolo (magari, per un riunione di lavoro con amici e collaboratori) della caffetteria «Dolci pensieri», simpaticamente gestita da un gruppo cordialissimo di ragazzi e ragazze, sembra un ricordo lontano. Tante le persone, le situazioni, le cose che sembrano essersi dissolte.
Anche gli immigrati, gli «extracomunitari», non ci sono più. Non c’è più il buonissimo senegalese che da anni, fisso, ogni giorno stazionava accanto al portone di casa, con i poveri cartoni della sua mercanzia: due ombrelli, tre accendini, qualche borsa in finta pelle. Non ci sono più i suoi amici africani che il pomeriggio si riunivano sulla panchina per fare due chiacchiere nella loro lingua dal suono, per noi, strano. Mancano, tutti. Abituati, noi europei, a settanta anni di pace (con le dovute sanguinose eccezioni, intendiamoci: la guerra n Bosnia, la repressione dell’Ungheria insorta nel 1956…), ci troviamo improvvisamente catapultati in mezzo ad una guerra.
Non ci sono trincee, non ci sono spari e non ci sono bombardamenti. Ma ci sono i caduti. Ho amici bergamaschi. Sento i loro racconti al telefono e mi rendo conto che la situazione (la diffusione del contagio, lo spavento e lo sgomento diffuso, il numero dei morti, portati via senza esequie, la sanità, puntellata dall’abnegazione di medici, infermieri e volontari, che tuttavia è al collasso) è molto più grave di come non la dipingano i TG. Anche se (ma va detto con cautela), negli ultimi giorni, sembra intravedersi un minimo allentamento della drammaticità della situazione. Oggi, lo vedo da casa, è una giornata di sole, in cui l’unico rumore che si sente è quello del vento. Un vento che sembra portare l’eco di vicende, vicine e lontane, segnate dall’ansia e dal dolore, punteggiate da un’implicita domanda. Quando, quando finirà?
E a cosa possiamo appellarci perché finisca prima possibile e per lenire le ferite, quelle profonde, che non si vedono, psicologiche e spirituali, che segneranno la coscienza individuale e il sentire collettivo? Due sono, come sempre, le risorse a cui noi, nella nostra fragilità (dimensione che la nostra supponenza ci fa, a volte, obliare), possiamo appellarci. Due, sempre quelle: la ragione e il cuore.
La ragione, che dà forza e base alla scienza, è a fondamento della medicina moderna. È la nostra concreta speranza ed è l’arma più potente per sconfiggere questo nemico insidioso e nascosto (più temibile e terribile del terrorismo medesimo, che ha, se non altro, una sua visibilità) che ha sconvolto le nostre vita e ha scombussolato il mondo intero viaggiando spedito sulle veloci piste della globalizzazione e dell’interdipendenza planetaria. È il mondo intero che è al fronte. E che può trovare nella scienza e nei suoi progressi (impensabili ai tempi della tremenda epidemia della «spagnola», che seminò milioni di morti in società piagate dalla guerra) l’unico efficace baluardo da opporre al minuscolo, eppur temibile, nemico che avanza. In questo senso, questa emergenza, in un tempo in cui il possesso di specifiche competenze troppo spesso è stato scioccamente contestato o sbeffeggiato, serve a ridefinire, parametri, priorità e, speriamo, modo di pensare. Ma la scienza e la ragione, da sole, non bastano, a ridarci un orientamento ed una bussola nell’uscita da questa triste stagione, se insieme non trovano spazio le ragioni del cuore. Dire del cuore non significa dire del sentimentalismo.
Il cuore è lo spazio dell’anima e della sensibilità esistenziale. Quella che cerca (per le vie più diverse: le religioni, la poesia e la letteratura, la filosofia…) un rapporto con il mistero del mondo in cui siamo immersi. Sono giorni in cui, martellati dalle notizie che giungono da questo insolito fronte, non c’è persona che non sia tornata a percepire il senso della nostra finitezza. Abbiamo il dono della vita, ma questa vita ha un limite, ha, ahimè, un termine ed è esposta (come evidenzia un’epidemia di sapore medioevale emersa nel pieno dei nostri anni duemila) alla precarietà.
Scrive Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose ( Gli sguardi della tenerezza, «La Repubblica», 23 Marzo): «(…) ci poniamo inevitabilmente domande che non ci esentano dal pensare alla morte. Sì, la morte che ormai ha colto non solo “altri”, ma anche persone care, qualcuno con un volto per noi riconoscibile, che aveva una famiglia, degli amici, un lavoro, una vita di relazioni». C’è un lutto collettivo, oltre che particolare (quello delle singole famiglie), da elaborare. E c’è un’idea di fondo con cui è opportuno andarsi a misurare.
Mentre infermieri, scienziati, volontari, e anche ognuno di noi per il niente che può, cercano e cerchiamo di contribuire a salvare vite e a far vincere le ragioni della vita su quelle della morte, possiamo realizzare che è proprio a partire dalla percezione della comune condizione di precarietà e di finitezza che trova fondamento la dimensione (sempre auspicata, mai realizzata) della fraternità umana. Con la ragione e con il cuore, dunque.
Come se ne può uscire? Insieme. Torno a guardare fuori dalla finestra. Firenze deserta è illuminata dal sole e spazzata dal vento. E’ possibile ascoltare il silenzio e la propria inquietudine. Ma bisogna anche saper guadare oltre. Sognando il domani. Dopo tutto, come diceva Ernesto Balducci, con il suo linguaggio immaginifico, non c’è che un tempo degno dell’uomo. E quel tempo è il futuro.
Testimonianza di Severino Saccardi
Severino Saccardi è nato a Gaiole in Chianti (in provincia di Siena) il 3 maggio 1949, vive attualmente a Firenze. Insegnante (all’inizio come maestro elementare, poi come insegnante di Lettere alle Medie, di Filosofia e Pedagogia all’ Istituto Magistrale, di Filosofia e storia nei Licei), è stato consigliere regionale della Toscana dal 2005 al 2010 (dove poi è rientrato come primo dei non eletti della lista di appartenenza, dal Luglio 2014 al Giugno 2015).
È stato segretario della commissione cultura del Consiglio Regionale ed è stato anche rappresentante del consiglio nel comitato Regionale di Bioetica. Fin dalla fine degli anni Settanta fa parte della redazione della rivista Testimonianze, fondata da padre Ernesto Balducci come strumento della cultura del dialogo nell’ormai lontano 1958 e da anni dedita all’impegno per il dialogo fra credenti e non credenti, la cultura della pace, i diritti umani, la riforma ed il rinnovamento della politica. Negli anni Ottanta ha partecipato all’ideazione e all’organizzazione dei convegni Se vuoi la pace prepara la pace. Della rivista è direttore (prima insieme a Lodovico Grassi e poi come direttore unico) dal 1996.
Collaboratore di pubblicazioni periodiche e quotidiani, è autore del volume Il continente ritrovato- Da Helsinki alla “Casa comune Europea” (Edizioni cultura della Pace, 1990) è curatore e autore (insieme a Diana De Lorenzi) del Dizionario Atlante dello sviluppo umano (Edizioni Cospe Cmsr) ed è stato curatore (insieme a Diana De Lorenzi e a Patrizia Russo) dei materiali multimediali sulle culture del mediterraneo Afaq- Orizzonti(Edizioni Cospe- Cmsr). E’ anche coautore del volume La Costituzione della Repubblica Italiana, Firenze (Diple Edizioni
È stato inoltre presidente della Onlus COSPE (Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti) e dell’ Associazione «Uomo Planetario» (per la valorizzazione di Santa Fiora, paese natale di Ernesto Balducci, sul Monte Amiata, e luogo-simbolo della cultura della pace).