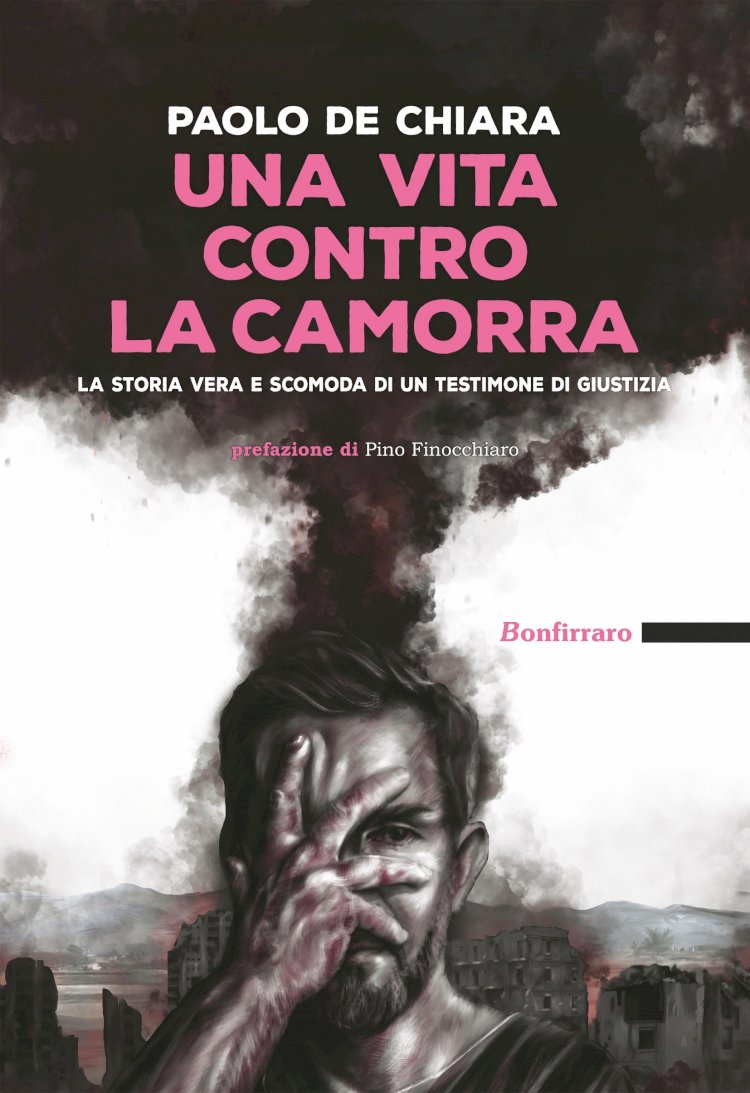«Uomini del Colorado vi saluto e me ne vado». In ricordo del padre del giornalismo investigativo italiano
Perché Mario Francese fu ucciso? Sicuramente perché fu il primo ad aver messo mano sul rapporto tra mafia e appalti e proprio per questo fu assassinato dalla mafia.

Erano le 21:15 del 26 gennaio 1979 quando Mario Francese arrivò sotto casa. Scese dall’auto e il killer di Cosa Nostra Leoluca Bagarella gli sparò con una calibro 38 alle spalle. Bagarella, secondo la testimonianza di una donna che era seduta dietro i vetri del balcone di casa sua che si affacciava sul Viale Campania e che vide la scena, aveva sparato con tremenda freddezza e determinazione e, in questo brevissimo arco di tempo, aveva indirizzato ripetutamente lo sguardo verso il balcone della sua abitazione. I loro sguardi si erano incrociati, e, per un istante, la donna aveva temuto per la propria vita. Mario Francese fu raggiunto da almeno sei dei proiettili esplosi: quattro alla testa, uno al collo e uno alla mano sinistra. La morte avvenne quasi istantaneamente per le gravissime lesioni cranio-facciali provocate dai proiettili che raggiunsero la testa. I colpi furono esplosi tutti da una distanza superiore ai 20- 25 cm. Dagli atti, emerse che l’unico proiettile repertato proveniva da un revolver calibro 38 special, del tipo Smith & Wesson.
Mario Francese era un giornalista. Lavorava al Giornale di Sicilia e quel 26 gennaio era uscito dalla redazione salutando i colleghi con il suo solito “Uomini del Colorado, vi saluto e me ne vado”. Non sapeva che non li avrebbe più rivisti, come che non avrebbe più rivisto la sua famiglia. Sulle pagine del quotidiano raccontava dell’ascesa dei “corleonesi” Liggio, Riina, Provenzano, Bagarella, e della caduta dei “palermitani” Cavatajo, La Barbera, Torretta e tanti altri. Mario Francese aveva una visione unica del sistema mafioso. Non parlava mai di frattura o cambio della guardia, non parlava mai di discontinuità. La parola che più ricorre nei suoi articoli è “evoluzione”.
Raccontò la strage di Ciaculli e l'omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Fu tra i primi a capire e a raccontare che l’omicidio di Peppino Impastato non fosse un atto terroristico, come i depistaggi istituzionali volevano far credere, ma un delitto di mafia e andò intervistare Felicia Impastato, ascoltando e dando risalto alla sua voce, voce che era aspramente criticata anche da quei giornalisti che avevano, facilmente, creduto alla versione di Impastato terrorista morto suicida il 9 maggio 1978. Mario Francese fu l’unico giornalista a intervistare la moglie di Totò Riina, Ninetta Bagarella. Le fece delle domande, una sorta di “lesa maestà” per la moglie del più feroce capo mafia che, proprio in quel periodo, stava scalando la gerarchia di Cosa Nostra. Fu anche uno dei sostenitori dell’ipotesi che l’omicidio di Cosimo Cristina fosse un di matrice mafiosa. Mario Francese aveva un approccio al giornalismo unico in quegli anni e che, purtroppo, ancora oggi rimpiangiamo. I suoi scritti non erano articoli ma erano vere e proprie inchieste ed era un giornalista abituato a scavare. Come quando si occupò della pioggia di miliardi per la ricostruzione post terremoto del Belice.
Mario Francese era un giornalista che non si fermava alla descrizione del singolo crimine o della singola “ammazzatina” fatta dai mafiosi. Non gli bastava. Mario Francese riusciva a collegare il singolo evento nell’ampio contesto che lo circondava anche quando, e ciò succedeva troppo spesso, questo veniva evitato dai suoi colleghi. Erano gli anni ’60 e ‘70, quei decenni cruciali prima delle stragi che hanno insanguato le strade di Palermo.
Gli attentati, i morti ammazzati di Roccamena e Corleone, gli scomparsi del “circondario nero” e, forse, anche qualche clamoroso sequestro hanno pubblicizzato l’inizio dei lavori per la costruzione della grande diga Garcia che investe i comuni di Contessa Entellina, Roccamena (letto della diga), Monreale, Bisacquino, Santa Margherita Belìce, Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Partanna, Campobello di Mazara, Castelvetrano.
Mario Francese scoprì come, alla base del forte scontro interno mafioso, ci fossero i soldi stanziati per la costruzione della diga Garcia e che alcuni dei terreni erano dei cugini Salvo, gli esattori siciliani. Il suo fiuto lo spinse ad approfondire gli interessi economici che si nascondevano dietro la costruzione della diga Garcia. Nel settembre del 1977 pubblicò un'inchiesta in sei puntate dove descriveva tutta la rete di collusioni, corruzioni ed interessi che si erano sviluppati per la realizzazione della diga. La prima vera inchiesta dei rapporti tra mafia e appalti mai redatto, dieci anni prima di quello denominato “mafia-appalti” redatto dagli ex Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno per volere di Giovanni Falcone.
Le tracce lo portarono a occuparsi di un costruttore, tale don Peppino Garda, presunto “boss” di Monreale, che vendette frettolosamente molti degli edifici di sua proprietà, costruiti in via Sciuti in società con Peppino Quartuccio, e si ritirò in eremitaggio. Dalla vendita degli edifici furono ricavati circa cento milioni e quegli stessi soldi furono reinvestiti in un latifondo nei pressi del Lago Garcia. Una mossa che andava a realizzare un progetto che, nel giro di dieci anni, avrebbe fatto intascare ai clan quasi un terzo dei 17 miliardi stanziati dallo Stato per la costruzione della ”faraonica” diga.
Così quando nel 1975, approvato il progetto dell'opera, iniziarono le procedure per gli espropri, i Salvo, don Peppino e i loro “compagni di merenda” andarono all'incasso e per i terreni pagati complessivamente due miliardi di lire, grazie al denaro della Cassa del Mezzogiorno, i nuovi e vecchi proprietari di quei terreni, ne incassarono più di diciassette. Si trattava di denaro che in gran parte finì nelle casseforti mafiose e solo in piccolissima parte agli altri proprietari e agli affittuari.
L'affare derivante dalla costruzione della diga Garcia, però, non riguarda solo i terreni e Francese si rese conto subito che c’era moltissimo altro denaro di cui appropriarsi. Era quello derivante dai subappalti, dalle forniture di cemento, pietrame e quant'altro, da posti di lavoro da distribuire, da mezzi meccanici da affittare. Questo intreccio di appetiti e ingordigia lasciò sul terreno una dozzina di morti e una scia di attentati. E fu in quell’occasione che Mario Francese dettagliò come, dietro la sigla della misteriosa società che si chiamava Risa, si nascondesse Salvatore Riina.
Collega uno dei primi delitti eccellenti, quello del colonnello Giuseppe Russo nel 1977 a Ficuzza, a controversie per i subappalti ma indaga anche su alcuni morti ammazzati alla guerra nelle cave.
E a proposito delle intuizioni di Mario Francese relativamente all’assassinio del colonnello Russo, in seguito, dai vari documenti investigativi, risulterà un nome legato a quel giro di affari miliardari, quello di Angelo Siino, il cosiddetto ” ministro dei lavori pubblici” della mafia corleonese di Liggio, Riina e Provenzano. Sarà proprio Siino a dire che il movente dell’omicidio del colonello Russo era da ricercare nelle indagini che l’alto ufficiale aveva svolto nella costruzione della diga Garcia e nel suo interessamento per far aggiudicare i lavori della costruzione della diga Piano Campo all’impresa Saibeb. Il pentito Balduccio Di Maggio aggiungerà: «Riina stesso mi disse che dato che nella nostra zona non c’erano imprese in grado di concorrere a tale opera, l’unica soluzione possibile era quella di farla aggiudicare alla ditta Costanzo di Catania». E poi ci sarà Giovanni Brusca a dire: «Per volontà di Riina era stato stabilito che l’appalto andasse a Costanzo e Lodigiani». Si tratta di imprese nazionali di rilievo e di appalti miliardari guidati da Totò Riina. Il giornalista Mario Francese aveva capito tutto, anticipando in parte quello che poi sarà evidenziato dal dossier mafia-appalti in cui, e non è un caso, il nome della Lodigiani compare.
Francese indaga, annota e scrive sul Giornale di Sicilia quel che accade nel territorio, facendo nomi e cognomi. È il primo a farlo e ancora è il primo a scoprire e raccontare l'ascesa dei Corleonesi e a chiamare "commissione" il vertice della cupola.
Dal 1928 si parla di una diga nella valle del Belice, ma non s’è fatto mai nulla. Ci fu un progetto durante il fascismo, che risultò inservibile. Poi, dal 1955 l’Ente per la riforma agraria siciliana elaborò cinque studi successivi, tutti respinti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progetto di base prevedeva la costruzione della diga a Bruca, sul Belice sinistro ma fu respinto in via definitiva dopo il disastro del Vajont, perché non offriva assicurazioni sull’impermeabilità dei terreni e la stabilità delle sponde. Il progetto dell’attuale diga Garcia, che oggi porta il suo nome, è quello di un’opera progettata e avviata negli anni ‘60 e che fu completata negli anni ‘80, dopo una serie impressionante di omicidi e di denunce. Si tratta di un invaso da 80 milioni di metri cubi d’acqua che doveva servire lo sviluppo dell’agricoltura e che invece, per molti anni, favorì la crescita della mafia e della corruzione dentro i palazzi dello Stato. Costò, a suo tempo, centinaia di miliardi delle vecchie lire e oggi serve per irrigare anche i campi del Belice.
Ne abbiamo sentito parlare di recente, agli inizi del mese di gennaio di quest’anno quando, a causa delle poche piogge, il livello dell'acqua nella diga Garcia si abbassò e ai suoi bordi riaffiorarono delle ossa. Quasi certamente umane, ma dovranno gli accertamenti di laboratorio del Ris dei carabinieri a doverlo confermare definitivamente, e quasi certamente lì da più di un anno. A chi appartenessero, di quante persone si possa trattare e come siano finite proprio lì, nel territorio del comune di Contessa Entellina, è invece un mistero anche se le ipotesi sono diverse. Ma non sono le uniche ossa umane che il tempo ci ha restituito.
A pochi chilometri dalla diga, nei pressi Roccamena, nel 2016 fu rinvenuta, grazie ad una segnalazione confidenziale, una delle foibe della mafia. Si tratta in una cavità simile a una foiba in cui la mafia ha occultato i corpi delle sue vittime di lupara bianca. Furono trovati 7 corpi, che salirono a 14 nel corso degli scavi ordinati dai Pm e coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Monreale. Due di dei corpi appartenevano a due ragazzi. Oltre ai cadaveri vennero ritrovati anche indumenti e bossoli. È ovviamente impossibile risalire al nome delle vittime anche a causa della cattiva conservazione dei corpi che non permise di eseguire l’esame del Dna. Il caso rimane a tutt’oggi una pagina bianca di un libro denso di misteri.
L’indagine è stata archiviata e i 14 corpi resteranno senza nome, forse per sempre. A Roccamena, i corleonesi di Riina avevano un fedelissimo, Bartolomeo Cascio, imprenditore e padrino incontrastato fino a poco tempo fa. È morto a luglio del 2016, nella sua Roccamena dopo aver finito di scontare la sua pena per associazione mafiosa. Che strana coincidenza. Dopo la sua morte, qualcuno finalmente parla della foiba. Qualcuno, forse, ha voluto togliersi un peso dalla coscienza. Magari, solo perché sapeva chissà da quanto tempo, o perché aveva visto. E aveva deciso di dare un morto su cui finalmente piangere ai figli e ai nipoti delle vittime.
È una storia che s’intreccia da un lato con i traffici e gli interessi delle famiglie mafiose di Castelvetrano e di Corleone e dall'altro con le indagini che il giudice Cesare Terranova svolse assieme al maresciallo Lenin Mancuso e con l'inchiesta di Mario Francese sulla diga Garcia.
Le ossa rinvenute nella foiba di Roccamena risalgono proprio agli anni in cui la costruzione della diga era all’apice della sua realizzazione e le inchieste di Mario Francese si sviluppavano giorno dopo giorno.
E proprio in quelle inchieste Mario Francese cita l’impresa milanese Lodigiani, la Pantalena, la Garboli e in particolare la Saiseb: l’impresa con sede centrale a Roma che, conosciuta a Castelvetrano per il famoso contenzioso di oltre 3 milioni di euro con il comune, giocava un ruolo importante nella ricostruzione del Belice, facendo lavori per vari miliardi di lire, giocando molto sulle perizie di variante, facendo molto lievitare i costi degli appalti.
Le ricerche di Francese e le sue pubblicazioni si sono rivelate intuizioni fondamentali per comprendere la scalata dei corleonesi all’interno di Cosa Nostra e a Palermo. In quel periodo proprio da Palermo la mafia gestiva il più grande traffico di droga esportandola in tutto il mondo e si accaparrava gli appalti edilizi per la costruzione di opere pubbliche. Francese ne studiò le dinamiche, entrò nei dettagli familiari e questo gli permise di comprendere aspetti fino ad allora inediti. Denunciava i boss e pubblicava i loro nomi.
L’inchiesta sulla diga Garcia è per Mario Francese lo scoop di una vita di giornalista. Dettagliata, circostanziata, piena di riferimenti puntuali, di fatti, di nomi e cognomi, la diga è l’ordito intorno al quale egli tese una trama fitta di personaggi , avvenimenti luoghi, indagini, testimonianze, rapimenti, assassini, appalti, burocrazia, mafia e politica.
Perché fu ucciso? Sicuramente perché fu il primo ad aver messo mano sul rapporto tra mafia e appalti e proprio per questo fu assassinato dalla mafia.
Il modus operandi mafioso è lo stesso di quello che sarà utilizzato il 6 gennaio 1980, quando sarà ucciso il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella.
L’unico proiettile repertato, dei quattro che hanno ucciso Mario Francese, era di una pistola della stessa marca di quella usata, una Smith & Wesson calibro 38, per l’omicidio di Piersanti Mattarella e inoltre fu utilizzato lo stesso tipo di contraffazione della targa dell’auto usata per la fuga, avvenuta utilizzando due spezzoni di targhe diverse. Anche in questo caso, quello di Piersanti Mattarella, si parla di appalti tra le casuali dell’omicidio.
Le carte processuali ci permettono di apprendere che «il movente dell’omicidio Francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un’approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni Settanta» e che «emerge – scrivono i giudici - una straordinaria capacità di operare collegamenti tra i fatti di cronaca più significativi verificatisi nel corso degli anni, di interpretarli con coraggiosa intelligenza e di tracciare così una ricostruzione di eccezionale chiarezza e credibilità sulle linee evolutive dell’organizzazione mafiosa, in una fase storica nella quale emergevano le diffuse e penetranti infiltrazioni di Cosa Nostra nel mondo degli appalti e dell’economia ed iniziava a delinearsi la strategia di attacco alle Istituzioni da parte dell’illecito sodalizio».
I giudici, inoltre, evidenziano il fatto significativo che sia stato proprio l’omicidio di Mario Francese ad aprire quella lunga catena di “omicidi eccellenti” che insanguinò Palermo tra la fine degli anni 70 e il decennio successivo, in attuazione di un preciso disegno criminale che mirava ad affermare il più assoluto dominio mafioso sui gangli vitali della società, dell’economia e della politica in Sicilia. In quel 1979 caddero dopo Mario Francese anche Michele Reina, politico democristiano, Giorgio Boris Giuliano, capo della squadra mobile palermitana, il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, suo stretto collaboratore.
Francese, Giuliano, Terranova, Mancuso. Nel giro di poco meno di otto mesi Cosa Nostra stroncò gli uomini che, dotati d’intuito investigativo al di sopra della media, la stavano non solo colpendo duramente ma ne avevano capito dinamiche ed evoluzioni e, proprio per questo, dovevano essere eliminati.
Il cronista del Giornale di Sicilia, senza ogni ombra di dubbio fra i più bravi che la Sicilia abbia mai avuto, pochi giorni dopo la sua morte fu completamente dimenticato. Mario Francese pagava la “colpa” di essere andato oltre, in una Palermo spietata che si era abituata ai morti ammazzati e che preferiva voltarsi dall’altra parte spesso far favorire interessi personali. Da quel giorno, e prima delle condanne dell’11 aprile 2001, in pochi rimasero accanto alla famiglia Francese. Per anni si disse: “La mafia non c’entra nulla”.
Negli anni Duemila, soprattutto grazie all’incessante lavoro del figlio Giuseppe che nella notte tra il 2 e il 3 settembre del 2002 si è tolto la vita schiacciato da un dolore che lo aveva accompagnato fin dal primo momento dopo l’omicidio del padre, invece, fu tutta la cupola a finire a giudizio, da Salvatore Riina a Francesco Madonia, passando per Michele Greco, Antonino Geraci, Giuseppe Farinella, Matteo Motisi, Pippo Calò, Giuseppe Madonia imputati per essere stati i mandanti e Leoluca Bagarella come esecutore materiale.
“Mario Francese è morto perché ha detto ciò che non doveva dire, secondo l'ordine stabilito da Cosa Nostra, e ha scritto ciò che per i mafiosi non doveva essere scritto e portato alla coscienza di tutti”. Sono le conclusioni della requisitoria di Laura Vaccaro, la Pm del processo.
WORDNEWS.IT © Riproduzione vietata