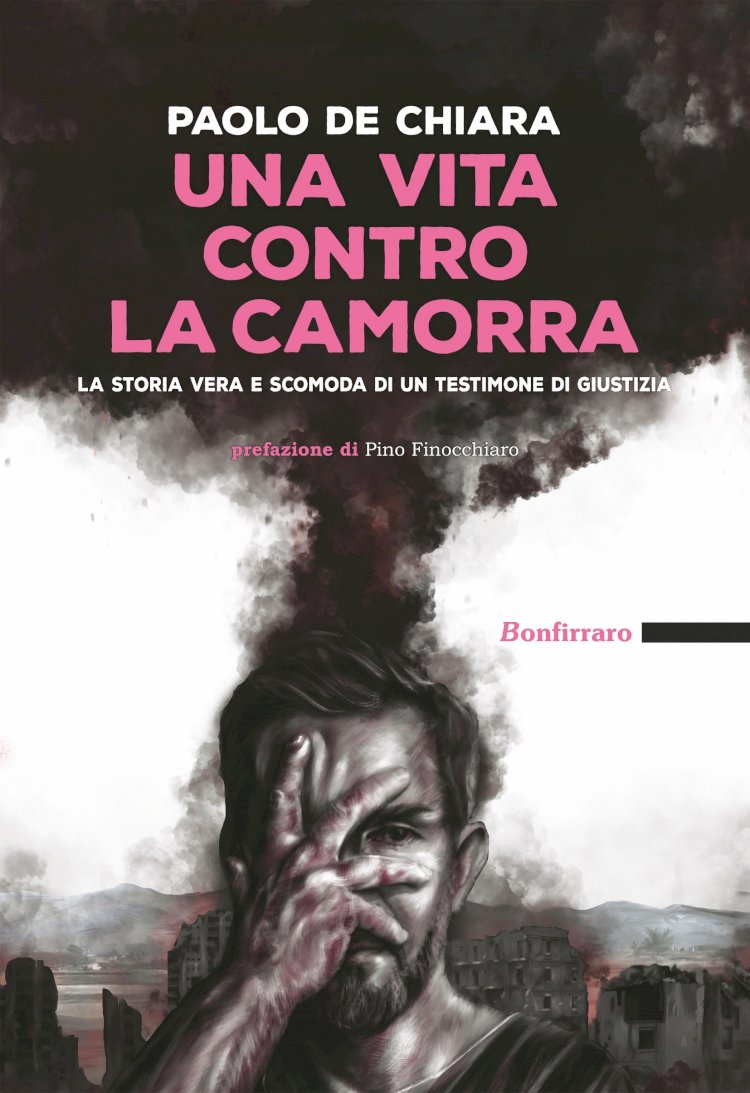Giancarlo Siani, parla D’Alterio: «La sua morte ha prodotto un risveglio delle coscienze»
L'INTERVISTA. Per il PM del caso Siani, autore del libro "La stampa addosso": «Era un giovane uomo che aveva voglia di verità, che voleva un forte contrasto della criminalità organizzata, aiutare a rompere i collegamenti tra criminalità organizzata e la politica e l’amministrazione. Credeva fortemente nei valori dell’onestà. Esigeva dalle Istituzioni che si facesse di tutto, non bastava a lui una onestà passiva di chi fa il suo dovere, ma esigeva che si facesse di più per sconfiggere ogni collusione».

Sembra una sera come tante altre. È buio, un giovane ragazzo sta parcheggiando la sua autovettura nei pressi della sua abitazione. Nella sua mente si affollano diversi pensieri e, forse, qualche preoccupazione legata al suo lavoro. Senza accorgersene si trova di fronte, nell’oscurità, due pistole puntate. Dieci colpi vengono sparati senza pietà. I vigliacchi colpiscono all'improvviso.
È la sera del 23 settembre del 1985. Il giovane ragazzo è un giornalista precario (senza contratto) del Mattino, si chiama Giancarlo Siani. Un cronista giovane ma con la schiena dritta. Si occupava anche di camorra, raccontava la realtà criminale. Solo quattro giorni prima, il 19 settembre (il giorno di san Gennaro, un appuntamento molto importante per la città di Napoli), aveva compiuto 26 anni.
Sono passati 35 anni da quel barbaro omicidio, commesso da inutili e schifosi vigliacchi che si fanno chiamare camorristi. Oggi, Giancarlo, avrebbe compiuto 61 anni. Da quattro giorni. La Citroen Mehari, che ha raccolto il suo corpo senza vita, è esposta presso la Fondazione Siani. La memoria, nel Paese senza memoria, è fondamentale. Non solo per ricordare. Il dovere di ogni giornalista è quello di fare il proprio bellissimo mestieraccio con dignità. Costi quel che costi.
«Ho cominciato a chiamarlo per nome dopo il suo omicidio. La morte me lo ha reso un punto di riferimento. Uno che lascia il segno, presente anche quando non c’è più. Ricordo che dall’ottobre del 1984 al settembre dell’anno successivo, quando lo hanno ucciso, l’ho visto qualche volta in Procura a Napoli. Il nove ottobre 1984 era iniziata la mia esperienza in Procura, dopo il tirocinio a Napoli e qualche anno trascorso a Savona come giudice di Tribunale. La prima volta avevo pensato fosse un poliziotto in borghese, per la determinazione nelle domande insistenti, che rivolgeva a qualche collega più anziano e che contenevano uno stimolo – ed una ammonizione tacita – nonché per la conoscenza che aveva di fatti e circostanze. Un atteggiamento coerente con la spinta etica che caratterizzava il suo impegno di giornalista. La massima determinazione veniva fuori nella sua avversione per l’illegalità e più in generale per l’ingiustizia, anche se non aveva bisogno di essere un “giornalista anticamorra” per sentirsi realizzato. Era una persona completa, ricca d’interessi e di passioni. Non si occupava di quei temi per trarne fama o successo, né per l’esigenza di riempire con la “missione” la propria vita».
Questo breve passaggio è contenuto nel libro «La stampa addosso. Giancarlo Siani, la vera storia dell’inchiesta» (Guida editore) scritto dal magistrato Armando D’Alterio, il PM “tenace” (così definito da Paolo Siani), del caso Siani. D’Alterio, già procuratore capo della DDA di Campobasso, oggi è Procuratore Generale di Potenza.
Lo abbiamo intervistato per comprendere il suo pensiero su una figura straordinaria del giornalismo italiano, vittima della camorra napoletana.
 Armando D'Alterio, oggi PG di Potenza
Armando D'Alterio, oggi PG di Potenza
Dott. D’Alterio, chi era Giancarlo Siani?
«Era un giovane uomo che aveva voglia di verità, che voleva un forte contrasto della criminalità organizzata, aiutare a rompere i collegamenti tra criminalità organizzata e la politica e l’amministrazione. Credeva fortemente nei valori dell’onestà. Esigeva dalle Istituzioni che si facesse di tutto, non bastava a lui una onestà passiva di chi fa il suo dovere, ma esigeva che si facesse di più per sconfiggere ogni collusione.»
Lei quando si imbatte in questa storia?
«Ci sono stati vari momenti, anche precedenti a quello dell’inizio dell’indagine. Ricordo che già anni prima un collaboratore mi aveva dato delle indicazioni sugli ambienti criminali da cui era scaturito il delitto.»
Possiamo spiegare meglio?
«Sulla causale camorristica. All’epoca indagava Palmeri (all’epoca giudice istruttore, nda), io trasmisi il verbale a lui. Quando poi Palmeri firmò quella fondatissima sentenza di proscioglimento dei primi imputati, anche senza averne un motivo tecnico professionale, me ne procurai una copia e la lessi. E la condivisi, perché era estremamente motivata e fondata su elementi incontestabili.»
Come nasce il suo interessamento?
«Successivamente iniziai ad interessarmi delle cosche di Torre Annunziata e Marano, tutto nasce dall’omicidio di Eduardo Di Ronza, avvenuto il 3 novembre del 1989. Un vice di Gionta, accusato di aver rotto il patto di omertà nel corso delle indagini sulla strage di Sant’Alessandro del 26 agosto del 1984. Lui incontrò esponenti delle forze dell’ordine, rendendo dichiarazioni confidenziali e accusando il clan Alfieri-Bardellino di avere effettuato quell’intervento sanguinoso (conosciuta anche come la strage del Circolo dei pescatori, in cui morirono otto persone, nda). E questa cosa il suo clan non gliel’aveva mai perdonata. Pasquale Gallo, capo di una famiglia alleata al clan Gionta, alla fine degli anni Ottanta si parlava di clan Gionta-Gallo-Limelli, chiese che fosse ucciso perché aveva rotto il patto di omertà.»
Ritorniamo all’omicidio del Di Ronza.
«Durante la notte mi chiamano dal commissario Auricchio di Torre Annunziata e mi avvisa di questo fatto e decido di andare sul luogo del delitto. È il mio primo sopralluogo a Palazzo Fienga, poi ce ne saranno altri tre. Tutti segnano momenti importanti dello sviluppo delle indagini. Così cominciai a capire di fronte a che tipo di organizzazioni ci trovavamo: pericolose, pervasive, collegate con la criminalità politica.»
Poi arriverà l’arresto del boss.
«Nel ’91 ci sarà l’arresto in flagrante di Valentino Gionta, latitante rispetto all’esecuzione di una pena al 416 che gli era stata inflitta precedentemente. Fu trovato in un nascondiglio, in una stanza segreta a Palazzo Fienga, insieme al cognato Gabriele Donnarumma. In realtà non potevamo arrestarli per nulla…»
Perché?
«Valentina Gionta era semplicemente uno che si era sottratto agli arresti domiciliari. All’epoca non esisteva l’arresto fuori flagranza per evasione. Un evaso poteva essere arrestato solo nel momento in cui evadeva, non a distanza di tempo dall’evasione stessa. Ragionando decidemmo che non era possibile riportare Valentino Gionta agli arresti domiciliari da cui si era allontanato, allora formulammo una imputazione di 416 bis in flagranza, insieme al cognato Donnarumma Gabriele, in concorso con altri in corso di identificazione, costruito sulla base della precedente condanna per 416 sulla natura permanente del reato di associazione per delinquere e sugli elementi dati dalla caratteristica stessa di Palazzo Fienga. Ecco perché dico che furono importanti i sopralluoghi.»
Cosa c’era a Palazzo Fienga?
«Era attrezzato come un vero e proprio fortino militare, con cani pastori sui terrazzi, telecamere, monitor. Cosa che all’epoca erano abbastanza rare. Stiamo parlando del ’91. Così inizia una lunga traghettata attraverso i clan di Marano e Gionta che vide varie tappe. Nel 1993, sotto la pressione delle indagini, collabora Salvatore Migliorino; nel 1994 collabora Graziano Matteo, che è quello che una notte ci disse che poteva condurci nel milanese, a Sesto San Giovanni, dove erano i latitanti del clan. Nel frattempo avevamo già arrestato molti esponenti del clan.»
Cosa succede quella notte?
«Quella notte del 12 settembre del 1994, prima di tutto, ci indica un deposito di armi in Torre Annunziata. Sequestrammo un vero e proprio arsenale. Successivamente ci mettiamo in auto e andiamo con quattro macchine nel milanese. E lì ci fu il blitz che consentì la cattura di otto uomini armati. Un’impresa coraggiosa condotta, soprattutto, dagli uomini del commissariato di Torre Annunziata e dalla questura di Napoli.»
Cosa ci facevano a Milano?
«Loro, essendo latitanti, si erano portati altrove. Avevano scelto Milano dove effettuavano un traffico di stupefacenti pesanti, eroina e cocaina, di cui i proventi poi servivano a sostenere le famiglie dei detenuti del clan Gionta. Proprio la cesura di questo canale di finanziamento indusse Gabriele Donnarumma, cognato di Gionta Valentino, a collaborare perché nacque la convinzione, dopo tutti quegli arresti e la continuità dell’azione che non si limitava a scoprire i reati ma anche a cercare di catturare i latitanti, che era venuto il momento di deporre le armi e decide di collaborare. Poi ci furono tanti altri collaboratori, una dozzina del clan Gionta.»
Indagini indirizzate non solo nei confronti della malavita organizzata.
«Abbiamo indagato sui legami con la pubblica amministrazione. Abbiamo scoperto tutto quello che Giancarlo aveva scoperto. E quello che lui aveva scoperto continuava ad essere fatto: corruzioni e concussioni continuate dagli anni ’80 fino agli anni ’90, quando noi stavamo indagando.»
Con quali risultati?
«Abbiamo arrestato tre ex sindaci, quattro assessori del Comune di Torre Annunziata, esponenti apicali di tutti gli uffici del Comune di Torre Annunziata per reati, in vari blitz, di pubblica amministrazione. Quattro ondate di arresti ordinati dal GIP su nostra richiesta.»
Quali erano i collegamenti criminali di Gionta?
«La famiglia Nuvoletta di Marano, questo risulta affermato nella sentenza di condanna definitiva. Infatti hanno riconosciuto l’esistenza di un unico clan facente capo all’alleanza fra questi due gruppi.»
Collegamenti solo con clan campani?
«Avevano collegamenti con la banda della Magliana ma, soprattutto, con la mafia siciliana, con i corleonesi. C’era il giuramento di sangue di cui parlano i vari collaboratori.»
Perché viene ucciso il giornalista Giancarlo Siani?
«La discussione dell’omicidio trae origine dal suo articolo del giugno 1985, pubblicato sul Mattino, dove lui immagina che l’arresto di Valentino Gionta, nei pressi della tenuta di Poggio Vallesana dei Nuvoletta a Marano, potesse essere scaturito da una voce proveniente dall’interno del clan di Marano. Questa è una circostanza che è stata smentita, ma era solo un sospetto di Giancarlo Siani. E per questo nacque la decisione di ucciderlo: per punirlo, per avere lanciato questo sospetto. Però, nelle fasi decisive in cui si discuteva se farlo o meno questo omicidio, veniva ricordato da Donnarumma Gabriele che Valentino Gionta, da lui sentito in carcere, si era opposto.»
Perché?
«Il delitto avrebbe provocato un forte rilancio della pressione delle forze dell’ordine nei confronti del clan Gionta. A questa affermazione («la colpa ricadrà su di noi») venina replicato che Siani aveva dato molto fastidio al clan Gionta.
Ci fu una causale mista, formata da un antecedente storico, costituito dalle inchieste di Siani sui clan di Torre Annunziata, e un antecedente immediato, costituito da quell’articolo.
La decisione omicidiaria era stata anche preceduta da pedinamenti, probabilmente anche antecedenti a quell’articolo. Del pedinamento abbiamo tracce in una intercettazione di uno dei componenti del gruppo di comando del clan Gionta, che fa questa affermazione: «gli abbiamo fatto le poste sotto la vesuviana». La vesuviana è il tratto ferroviario che collega Napoli con i paesi alle falde del Vesuvio, tra cui Torre Annunziata.»
Ma Siani non stava lavorando ad un dossier?
«Abbiamo molto indagato su questo dossier. Abbiamo sentito anche il tipografo o presunto, quello a cui ci fu riferito che Giancarlo si rivolse per concordare questa stampa. Ma questo tipografo, da noi sentito in maniera molto pressante e approfondita, ha detto di non aver mai ricevuto nulla da Giancarlo.»
Perché un semplice “sospetto” fa scattare la decisione di eliminare un giornalista?
«L’omertà e il rispetto della chiusura totale alla collaborazione con le forze dell’ordine è una regola. Così come provocò l’omicidio del Di Ronza, che aveva parlato con le forze dell’ordine, quella stessa squallida e vergognosa logica criminale indusse a dire “dobbiamo eliminare l’uomo che ha detto che noi siamo dei traditori”.»
Cosa è cambiato dall’omicidio di Giancarlo Siani?
«La morte di Giancarlo Siani ha prodotto un risveglio delle coscienze.»
E per il clan Gionta?
«Valentino Gionta non è più uscito dal carcere, una detenzione continuata senza permessi al 41bis e come lui, nello stato, si trovano i killer del clan. Questo vuol dire aver inferto un grosso danno al clan. Non si può dire definitivamente debellato, ma non è più paragonabile a quello che era una volta. Anche i figli, i parenti e i nipoti di Valentino Gionta sono stati arrestati, processati e condannati.»
Perché ha deciso di scrivere un libro su Giancarlo Siani?
«Il primo motivo era di parlare ancora più approfonditamente di Giancarlo, un esempio per tutte le nuove generazioni. Il secondo motivo è dare omaggio a quegli uomini delle forze dell’ordine del commissariato di Torre Annunziata e della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Napoli che, con grande coraggio e grande impegno, hanno anche rischiato la vita. Parlo di quella trasferta nel milanese. Uomini che sono sempre rimasti nell’ombra e, quindi, era arrivato il momento di omaggiarli. Il terzo motivo era quello di chiarire che Giancarlo aveva ragione quando parlava delle collusioni politico-criminali, come le tangenti sul depuratore, sui vari progetti, sulla ricostruzione post-sismica. Era tutto vero. Realtà criminali già marce e consolidate all’epoca di Siani, protrattesi negli anni. C’era il politico che prendeva le tangenti e le distribuiva a tutti i partiti dell’epoca. Noi abbiamo arrestato amministratori ed esponenti di partito, di tutto l’arco costituzionale. Un’azione di accertamento a tappeto, riconosciuta dalle sentenze passate in giudicato. In quegli anni abbiamo fatto otto blitz e sei maxiprocessi, tutti conclusi con una vasta conferma delle nostre ipotesi di accusa e con condanne agli ergastoli e a svariati anni di reclusione. Tutto quello che aveva attenzionato Giancarlo. Poi, se lo possiamo dire, c’è un quarto motivo…»
Prego…
«Il passaggio del tempo, che consente di guardare le cose con maggiore obiettività, con maggiore distacco, con una certa imparzialità.»
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright WordNews