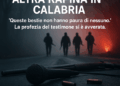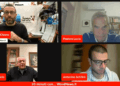Non è possibile chiudere la ricerca, che la Commissione ha tentato, sulle origini e sul consolidamento della mafia negli anni dell'Italia liberale, senza ricostruire, sia pure in via approssimativa, la linea politica seguita dallo Stato nel corso di quegli anni, per conoscere e per fronteggiare un fenomeno che diveniva col tempo sempre più preoccupante; ciò anche per avere, ai fini delle conclusioni cui la Commissione perverrà un preciso punto di riferimento, che valga a ricollegare la presente inchiesta a quelle che l'hanno preceduta, affinchè sia possibile non ripetere gli errori del passato, nel mutato contesto politico e sociale, e battere alla fine una via nuova ed efficace per lottare, in modo deciso e si spera definitivo, il fenomeno della mafia.
In questa prospettiva, il primo dato di fatto che viene in considerazione è il notevole ritardo col quale il problema della mafia emerse alla consapevolezza della classe dirigente. I governi unitari, per la verità, si preoccuparono subito di acquisire una conoscenza più approfondita delle condizioni di vita delle popolazioni meridionali e già nel 1861 il Presidente Minghetti incaricò Diomede Pantaleoni di recarsi nel sud e in Sicilia per studiarne le strutture e i rapporti sociali e per indagare più semplicemente sulla situazione dell'ordine pubblico. Pantaleoni però non si occupò specificamente della mafia, che del resto era allora alle sue prime manifestazioni, ma riuscì egualmente a farsi una idea abbastanza precisa delle caratteristiche e della natura del disordine che regnava incontrastato nell'Isola e a mettere anche in una certa evidenza, nella relazione conclusiva dell'inchiesta e più ancora nelle lettere private che scriveva al Presidente del Consiglio, le cause d'ordine sociale, e quelle riconducibile alle croniche disfunzioni di una Pubblica amministrazione inefficiente.
Ma quando si andò ai rimedi, il Governo non seppe fare altro che usare metodi repressivi, pensando che con la forza si potesse porre fine ai mali della Sicilia. Memorabile, in questo quadro, la missione affidata dal Governo nel 1863 al generale Covone di percorrere con «truppe disposte a cerchio e in assetto di guerra» le province di Caltanissetta, di Agrigento, di Trapani e di Palermo, alla ricerca di malviventi, ma anche allo scopo di togliere ogni possibilità di azione ai gruppi politici dissidenti che ancora operavano nell'Isola.
I risultati di questa iniziativa del Governo furono deludenti, così come non ebbe esito, ai fini della lotta contro la delinquenza, l'incarico affidato in seguito al generale Medici di reprimere, con i fermenti insurrezionali che facevano capo all'ala sinistra del partito d'azione, anche la mafia, che, secondo l'opinione allora diffusa, costituiva «una setta» scriveva l'esponente moderato Nicolo Turrisi Colonna «che trova ogni giorno affiliati nella gioventù più svelta della classe rurale, nei custodi dei campi e nell'agro palermitano, nel numero immenso dei contrabbandieri, che da e riceve protezione e riceve soccorsi da certi uomini che vivono col traffico e intenso commercio, che poco o nulla teme la forza pubblica, perché crede potersi facilmente involare alle sue ricerche, che poco teme la giustizia punitrice, lusingandosi nella mancanza di prove, e per la pressione che si esercita sui testimoni, e sperando sulle rivoluzioni che dal 1848 al 1860 fruttarono due generali amnistie pei prevenuti e poi condannati per reati comuni».
Di fronte a questi insuccessi, la Camera con una deliberazione del 25 aprile 1867 nominò una Commissione d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Giuseppe Pisanelli, con l'incarico di indagare sulle condizioni della città e della provincia di Palermo. Nemmeno questa volta la Commissione parlò della mafia, ma si limitò ad esporre l'opinione che per riportare alla normalità la situazione siciliana non fossero necessarie leggi eccezionali, ma strade ed opere pubbliche, che servissero a favorire i traffici e quindi ad accrescere le possibilità di sviluppo del Paese. Furono inoltre proposti ed approvati alcuni progetti di legge, per finanziare opere stradali e per facilitare le comunicazioni anche con il continente.
La successiva Commissione di inchiesta, nominata con deliberazione del 3 luglio 1875, si occupò specificamente della mafia, ma la sua diagnosi fu superficiale e approssimativa, perché si negò decisamente che il fenomeno potesse trarre origine in fattori di carattere sociale, come la disparità delle condizioni economiche tra le classi abbienti e quelle popolari, e si arrivò ad affermare che la mafia era dovuta a circostanze contingenti e che non era nemmeno un fenomeno peculiare della Sicilia, perché «sotto varie forme, con vari nomi, con varia e intermittente intensità si manifestava anche nelle altre parti del Regno, e si scoprivano a quando a quando terribili mostri del sottofondo sociale: le camorre di Napoli, le squadracce di Ravenna e di Bologna, i pugnalatoti di Parma, la cocca di Torino, i sicari di Roma».
La Commissione in conclusione ritenne di individuare le cause delle manifestazioni mafiose nel pervertimento sociale, residuo dell'antico regime, e nella riluttanza delle popolazioni locali a lasciarsi modificare dalle nuove istituzioni; con la conseguenza perciò che a suo giudizio la mafia poteva essere eliminata con un'operazione di forza. Furono invece ben diversi i risultati a cui pervennero, nello stesso periodo di tempo, le inchieste condotte per proprio conto sulle condizioni della Sicilia da Sidney Sommino e Leopoldo Franchetti.
Entrambi sottolinearono come la mafia avesse profonde radici nella società e nell'economia siciliane e come una delle cause, che ne erano state all'origine, fosse stata la mancanza di un ceto medio efficiente, insieme alle condizioni precarie e di estrema miseria della classe dei contadini. L'analisi dei due giovani studiosi perciò fu soprattutto rivolta a studiare il problema della mafia, non come un problema di semplice delinquenza, ma inserendolo nel contesto della vita sociale dell'Isola e ricavandone quindi la conclusione che per combatterlo non bastavano i mezzi di polizia, ma occorrevano invece profonde riforme organiche, capaci di eliminare le premesse dalle quali il fenomeno traeva alimento. Intanto però il Governo, avvalendosi delle misure eccezionali adottate con la stessa legge che aveva istituito la Commissione di inchiesta, aveva intrapreso e portato avanti in tutta l'Isola una massiccia operazione di polizia, con un accanimento che non aveva precedenti.
Si ricorse, come sempre, ai soliti mezzi repressivi e cioè all'accerchiamento di notte dei comuni e alla perquisizione delle case sospette, ma si provvide in più ad applicare su larga scala l'ammonizione e il confino. Le operazioni, specie tra il gennaio e l'agosto del 1871, furono dirette, secondo l'indirizzo del ministro dell'interno dell'epoca, Pasquale Nicotera, dal prefetto di Palermo, Antonio Malusardi, certamente 'meno famoso del prefetto fascista Cesare Mori, ma che come lui menò vanto di aver totalmente e definitivamente liberato l'Isola dal flagello del brigantaggio e della mafia.
L'opera del Prefetto ebbe anche pubblici ed entusiastici riconoscimenti e furono molti, e tra gli altri Pagano, ad approvare le misure illegali adottate dalla Polizia, essendo una necessità sociale colpire in modo deciso «più che la mafia che preparava, che il brigantaggio che eseguiva».
Sul versante opposto invece, si accusò il Governo (come poi si sarebbe fatto anche nei confronti del governo fascista) di aver condotto un'azione tipicamente mafiosa, usando arbitrariamente la violenza contro pacifici cittadini e adottando una politica indiscriminata di forza, che avrebbe finito col favorire, piuttosto che sconfiggere, quel fenomeno che si voleva combattere.
La mafia comunque non diede segni di stanchezza, ma riprese con vigore la propria attività; tanto che il deputato Abele Damiani, autore della relazione conclusiva dell'inchiesta disposta con legge del 15 marzo 1877 sulle condizioni della classe agricola in Italia, dovette riconoscere, nonostante l'ottimismo che caratterizzava il suo giudizio, che «le associazioni di malfattori, il malandrinaggio, la mafia, quantunque molto scemate non sono spente del tutto; anzi, anche quando una di queste forme di malessere sociale accenni ad essere scomparsa, ricomparisce alle volte inaspettatamente e mostra con ciò che la sicurezza pubblica lascia colà a desiderare».
La verità è infatti che proprio negli ultimi decenni del secolo XIX e nel primo decennio del nuovo secolo, la mafia riuscì ad accrescere di proprio potere, non solo continuando negli abusi e nelle angherie da sempre, ma anche rafforzando i legami con i detentori del potere formale, e in modo speciale con gli uomini politici, spinti dai loro interessi elettorali a cercare accordi con i mafiosi.
Non possono dunque far meraviglia le considerazioni a cui pervenne Giovanni Lorenzoni nella relazione che chiudeva per l'Isola l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, disposta nel 1907 e ultimata nel 1910. Oltre a ribadire quanto già avevano rilevato Franchetti e Sannino circa le connessioni esistenti tra il fenomeno mafioso e le strutture economiche e sociali della Sicilia, Lorenzoni non esitò a demandare le responsabilità, non solo del ceto dirigente locale, ma dei dirigenti politici nazionali, colpevoli di non aver mostrato la necessaria comprensione per il popolo locale, ma di aver anche favorito, per ragioni elettorali e di partito, le mene dei mafiosi.
La mafia perciò – secondo Lorenzoni – sarebbe nata dalla naturale diffidenza del popolo nella giustizia e nell'azione degli organi statali, con la conseguenza dell'omertà e della vendetta privata. I mafiosi, in altri termini, avrebbero saputo approfittare della sfiducia del popolo nello Stato e avrebbero saputo estendere le proprie amicizie verso l'alto, facendo poi pagare i propri favori «anche quando chi li subisce è l'autorità prefettizia o politica, che in una lotta tra un candidato amico del Governo e un candidato dell'opposizione difficilmente resiste alla tentazione di valersi anche della mafia, perché il candidato amico abbia a riuscire; e per tal modo un esempio che è più pernicioso della azione di mille mafiosi, perché alimenta la fonte stessa dello spirito di mafia: lo sprezzo dell'autorità della giustizia e dello Stato, il quale giovandosi di mafiosi, diventa esso stesso tale».
Per eliminare la mafia nell'Isola, pertanto, doveva essere per primo il Governo a non dare il cattivo esempio, valendosi del suo appoggio nelle lotte elettorali e tollerando che ben noti mafiosi «reggano le sorti dei comuni, facciano da sollecitatori negli uffici e divengano intermediari tra il pubblico e le Autorità».
Purtroppo le parole e le proposte di Lorenzoni rimasero lettera morta, e ancora una volta la mafia mostrò una vitalità economica e politica tale da permettersi ogni affermazione e da sfruttare ogni risorsa, tra le altre quella di assicurare tempestivi espatri agli affiliati, apertamente compromessi o minacciati di arresto.
La guerra mondiale non creò in Sicilia gli stessi problemi che movimentarono la vita politica nel resto della penisola, ma il ritorno dei reduci disorientati e senza lavoro finì col favorire la formazione di una mafia giovane, che doveva muoversi, in forme nuove, accanto alla mafia tradizionale, interessata come sempre a conquistare il monopolio delle terre e a soffocare con i vecchi metodi della lupara, degli incendi, delle intimidazioni, le aspirazioni e i movimenti contadini, ricorrendo ancora una volta alla soppressione violenta dei loro esponenti più rappresentativi, come avvenne per Nicola Alongi, ucciso a Palermo il 28 febbraio 1920 e per Sebastiano Bonfiglio, ucciso il 10 giugno 1922.
All'avvento del fascismo, una parte almeno di questa mafia finì con l'aderirvi e dal canto loro i piccoli proprietari terrieri pensarono che con l'instaurazione di un regime forte avrebbero potuto liberarsi delle incomode alleanze mafiose e difendere egualmente i propri interessi, una volta che con la soppressione delle libertà politiche e sindacali fosse venuta meno la possibilità stessa delle lotte contadine contro il latifondo.
Questo atteggiamento favorì la lotta che il fascismo intraprese contro la mafia, emanando il decreto-legge 15 luglio 1926 e inviando in Sicilia, per dirigere le operazioni di polizia, il prefetto Cesare Mori. Il decreto del 1926 consentiva alla Pubblica sicurezza di denunziare in stato di arresto, per farli assegnare al confino di polizia, coloro che fossero designati «per pubblica voce» come capeggiatori, partecipi o favoreggiatori «di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose alla sicurezza pubblica».
Avvalendosi di queste norme eccezionali, Mori portò alla mafia una lotta di tale estensione e severità che egli stesso la definì «uno stadio di assedio in ventiquattresirno». Non sempre le operazioni di polizia furono condotte con l'osservanza delle norme di legge, ma almeno in apparenza vennero raggiunti risultati non indifferenti, non certo contro l'alta mafia, ma contro la massa di manovra di cui essa si era sempre servita.
Tra l'altro, nel 1926, venne arrestato e condannato anche Vito Cascio Ferro, ancora considerato il grande capo della mafia, e nel 1931 il Procuratore generale di Palermo Giampietro potette annunciare con compiacimento, ma purtroppo con la stessa ingenua fiducia che aveva salutato l'opera del prefetto Malusardi, che ormai la mafia, che nel 1925 era dominatrice e signora di tutta la vita isolana, si era ridotta a pura ombra.
Considerazioni conclusive.
Le cause e la forza della mafia.
Due punti emergono con chiarezza dalle vicende e dagli episodi che sono stati sommariamente ricordati nelle pagine precedenti, e si tratta proprio idei punti che dovrebbero spiegare le ragioni per le quali la mafia da un lato si è sviluppata soltanto nella Sicilia occidentale e dall'altro ha avuto una durata ben più lunga di fenomeni analoghi, come la camorra; ciononostante che la storia dell'Isola, almeno per quanto riguarda l'evoluzione delle sue strutture sociali, non sia stata gran che diversa da quella del resto del Mezzogiorno d'Italia.
Il primo di questi punti è senza dubbio costituito dal rilievo che le azioni della mafia si risolsero in genere a favore dei ceti dominanti, in particolare dei proprietari terrieri, che ebbero nei mafiosi gli alleati più convinti e più preziosi nella lotta contro le rivendicazioni contadine.
La mafia d'altra parte (e questo è il secondo punto), fin dalla sua nascita e con un impegno sempre maggiore nel corso degli anni, si esercitò nella costante ricerca di un intenso, incisivo collegamento con i pubblici poteri della nuova società nazionale, rifiutando il ruolo di una semplice organizzazione criminale in rivolta contro 1o Stato, o magari interessata soltanto a una funzione di supplenza del potere legittimo.
Ma se la mafia si rafforzò, grazie ai collegamenti con l'apparato pubblico dello Stato sabaudo, è lecito supporre che anche il nuovo Stato abbia tratto un preciso vantaggio da questi collegamenti, il vantaggio cioè di garantirsi una facile posizione di dominio, senza essere costretto ad affrontare il problema scottante di un radicale rinnovamento della società siciliana.
Per realizzare l'Unità, la borghesia nazionale, emersa al ruolo di classe dirigente, non esitò ad allearsi in Sicilia con la nobiltà feudale locale, ed è proprio dalla logica di questo accordo, e correlativamente, dall'ostinata opposizione all'autogoverno, che nacque e si sviluppò il fenomeno della mafia.
Dopo avere confermato le sue posizioni di privilegio e di dominio, infatti, l'aristocrazia terriera si trovò ad avere bisogno, al di là delle strutture legali dello Stato, troppo deboli per garantirglielo, di un forte potere repressivo che tenesse a bada i contadini e che ponesse un freno alle emergenti rivendicazioni delle classi subalterne, interpretate in quegli anni soprattutto dai Fasci dei lavoratori.
Questo aiuto i proprietari lo trovarono nella mafia del feudo e nel suo interesse a ricercare, per i propri fini, un collegamento con i ceti dominanti. In questo senso, perciò, si può ben dire che la mafia è stata all'origine un fenomeno non delle classi subalterne, escluse, come tali, da ogni accordo di potere, ma al contrario dei ceti che al momento dell'Unità già esercitavano (e che continuarono ad esercitare) il dominio politico ed economico nell'Isola, cioè in definitiva, della vecchia nobiltà feudale e della grande proprietà terriera.
La mafia, quindi, come, prima si è visto più in dettaglio, fu costituita non soltanto da soprastanti, campieri e gabellotti, ma anche, e in misura non sempre marginale, da rappresentanti delle classi dominanti.
Fu proprio il loro interesse a mantenere le posizioni di privilegio conquistato nel corso dei secoli e a impedire che i ceti medi si trasformassero in una borghesia imprenditoriale moderna che rafforzò le basi, come ora si è detto, del sistema di potere mafioso e dell'intrico di complicità e di connivenze col potere formale dello Stato, che ne ha caratterizzato la storia.
Da questi collegamenti, la mafia trasse decisivo alimento per condurre in porto i suoi illeciti traffici e per assicurarsi la sua stessa sopravvivenza. In cambio, i mafiosi riuscirono a realizzare un'opera imponente di mistificazione, perché, facendo leva sul malcontento popolare per gli arbitri e le vessazioni dello Stato poliziesco, finirono per guadagnarsi la solidarietà o almeno la comprensione dei siciliani, che però sfruttarono contro il loro interesse, favorendo, per mantenere in piedi i privilegi dei potentati locali, una divaricazione sempre più accentuata tra la società nazionale e quella isolana e ostacolando quindi, con tutti i mezzi, anche i più sanguinosi, ogni istanza di rinnovamento e di progresso.
Questa situazione cambiò solo apparentemente con l'avvento del regime fascista. Durante il fascismo, il bisogno di fare ricorso al potere extralegale della mafia si affievolì, perché lo Stato si impegnò a garantire in prima persona la repressione del movimento contadino, ma non par questo la mafia scomparve.
Il prefetto Mori riuscì certamente a distruggere le bande armate, collegate agli aggregati mafiosi, che infestavano le zone interne della Sicilia, specialmente quelle delle Madonie e delle Caronie, e riuscì pure a stroncare l'attività delle associazioni mafiose che pullulavano nei centri urbani e rurali; ma è altrettanto certo che l'alta mafia non venne nemmeno toccata e che non fu rimossa nessuna delle cause, che erano state alla base del fenomeno.
Dal periodo fascista, i mafiosi che contavano uscirono indenni, o perché si erano integrati nel regime o perché avevano potuto continuare a vegetare all'ombra del potere, senza bisogno di ricorrere a gesti clamorosi, visto che bastava la repressione fascista a frenare le rivendicazioni e il movimento dei contadini.
Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, VI legislatura, 4 febbraio 1976
Per approfondimenti:
Prima parte, venerdì 27 marzo 2020: MAFIA, le origini remote
Seconda parte, venerdì 3 aprile 2020: La MAFIA nella storia dell’Unità d’Italia
Terza parte, venerdì 10 aprile 2020: Le attività mafiose
Quarta parte, venerdì 17 aprile 2020: I mafiosi
uploads/images/image_750x422_5ea3093443b56.jpg
2020-04-24 17:44:11
13