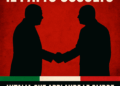Oltre ai numerosi delitti di sangue, commessi nel periodo considerato e di cui si è fatto un elenco sommario e largamente incompleto, molti altri reati di tipica marca mafiosa resero in quel tempo pericolosa e difficile la vita delle popolazioni siciliane nelle campagne occidentali dell'Isola.
Ebbero particolare frequenza, specie negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, i sequestri di persona, a scopo di rapina e di estorsione.
Così come dilagarono, nelle zone agricole, i delitti di danneggiamento e di abigeato; caratterizzati i primi, non soltanto dal grave e connaturale attentato al patrimonio e alla libertà morale delle vittime, ma anche dal nocumento non meno grave che essi provocarono all'economia di alcune parti del territorio isolano e dalla generale sfiducia verso i pubblici poteri che derivò dalla frequenza con cui venivano commessi; diffusi i secondi, soprattutto nelle campagne dell'interno, allo scopo ovviamente di illecito profitto patrimoniale, ma anche, sebbene più di rado, a fini di punizione o di vendetta. Non mancarono inoltre i delitti di estorsione e di rapina, spesso aggravati questi ultimi dal fatto che la violenza o la minaccia venivano eseguite con armi o da persone mascherate; e infine i delitti di violenza privata, particolarmente insidiosi, per la tendenza delle vittime a tollerare le vessazioni mafiose e a non denunziare i torti subiti e per la conseguente, pratica impossibilità di pervenire ad un accertamento giudiziario delle singole responsabilità.
Gran parte di questi delitti e di quelli di sangue, e forse si può dire la loro stragrande maggioranza, rimasero, come già risulta da quanto prima si è accennato, in pratica impuniti, o perché non si riuscì nemmeno ad individuarne i possibili autori, o perché coloro che furono imputati vennero poi assolti, la maggior parte delle volte, per insufficienza di prove.
Le allarmanti proporzioni che ebbe il fenomeno nel periodo di tempo che qui interessa e le ripercussioni che ne derivarono sulla pubblica opinione indussero la Commissione parlamentare, sin dalla sua istituzione, a dedicare specifica attenzione ai problemi connessi al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, in relazione ai reati di mafia.
In particolare, come già si è accennato, durante la IV Legislatura, uno speciale Comitato della Commissione prese in esame numerosi processi penali definiti dagli uffici giudiziari della Sicilia occidentale tra il 1° gennaio 1946 e il 31 dicembre 1964 con sentenze istruttorie o dibattimentali di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di imputati di delitti, consumati o tentati, di omicidio volontario, strage, associazione per delinquere, estorsione, rapina, sequestro di persona, violenza privata, incendio doloso, abigeato, danneggiamento, dei reati cioè più caratteristici e frequenti tra quelli che vengono commessi da mafiosi o che hanno comunque un movente di impronta mafiosa.
Successivamente, la Commissione ha portato di nuovo la sua attenzione sul materiale raccolto in quella occasione, e ciò nel quadro di un'indagine di più ampio respiro, diretta da un lato ad individuare (con riguardo non solo alla delinquenza connessa alla mafia agricola, ma più in generale a tutti i delitti di stampo mafioso) le cause e le circostanze che hanno compromesso o pregiudicato, nel tempo, il corso della giustizia in questo settore così delicato, e dall'altro a studiare i rimedi più adeguati, che possano porre riparo – nei limiti di compatibilità con le garanzie assicurate a tutti dallo Stato di diritto – alla possibile inefficacia degli interventi giudiziari di fronte alla mafia, a un fenomeno cioè che, qualora superi una certa misura, può finire col gettare discredito sugli organi dello Stato, col rafforzare la speranza dell'impunità dei mafiosi, con l'indebolire il prestigio dei pubblici poteri.
A questi fini, la Commissione ha dovuto naturalmente portare il suo esame, non solo su processi già definiti, ma anche su fatti dai quali poteva derivare, per singole persone, una specifica responsabilità o per i quali erano addirittura in corso procedimenti penali.
Nell'esercizio di questo suo campito, però, la Commissione non ha mai inteso superare, né di fatto ha mai superato, i limiti che incontra l'istituto dell'inchiesta parlamentare nei rapporti con l'attività della Magistratura.
La nostra Costituzione si occupa, come è noto, della funzione giurisdizionale negli articoli 101 e seguenti, laddove prima afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e poi aggiunge che la Magistratura, governata dal Consiglio superiore, costituisce un ondine autonomo e indipendente da ogni altri poteri (art. 104) e che la legge assicura l'indipendenza anche delle giurisdizioni speciali (art. 108). In questo modo la Costituzione, da un lato ribadisce il principio, già operante nel sistema, dell'assoluta indipendenza della funzione giurisdizionale e della sua inconciliabilità con qualsiasi tipo di sindacato politico, e dall'altro denuncia il principio ulteriore che la Magistratura, e cioè il complesso degli organi (ordinari e speciali) a cui quella funzione è affidata, fruisce d'una larga autonomia ed indipendenza nei confronti degli altri poteri dello Stato.
La funzione giurisdizionale, perciò, in quanto manifestazione di un giudizio, si sottrae, nell'ambito delle istituzioni e per ciò che attiene ai suoi risultati concreti, a ogni intervento censorio che non provenga da organi giudiziari di grado superiore; mentre d'altra parte l'indipendenza assicurata all'apparato giurisdizionale, in quanto tale, finisce col coprire tutte le funzioni, che la legge gli riserva, anche se diverse da quelle propriamente giurisdizionali.
Non v'è dubbio di conseguenza che dagli accennati princìpi derivi un limite all'istituto dell'inchiesta parlamentare, non solo per quanto attiene al contenuto della funzione giurisdizionale, ma anche per ciò che riguarda l'attività degli origami della Magistratura e dei soggetti ad essa estranei, ma comunque operanti a fini giurisdizionali. Si tratta di un limite per così dire connaturale al potere d'inchiesta, tanto che, come già si è visto nella parte dedicata ai precedenti parlamentari, il Senato e la Camera, in sede di discussione e approvazione della legge istitutiva della Commissione, votarono un ordine del giorno di eguale tenore, in cui si affermava che «II Parlamento, richiamandosi ai princìpi della Costituzione della Repubblica, che consacrano l'indipendenza della Magistratura, ritiene che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, nell'espletamento dei suoi compiti, non debba interferire nell'attività dell'Autorità giudiziaria e degli organi da questa dipendenti».
A queste raccomandazioni la Commissione si è sempre scrupolosamente attenuta, curando di evitare ogni valutazione del contenuto delle singole decisioni emesse in sede giudiziaria, e quindi ogni tipo di controllo, anche indiretto, sulle soluzioni date a determinati procedimenti.
La Commissione però sarebbe evidentemente venuta meno ai suoi compiti istituzionali e al suo stesso dovere se il rispetto per l'indipendenza della Magistratura l'avesse indotta ad astenersi dallo studio della delinquenza mafiosa e correlativamente dei! comportamento tenuto al riguardo dalla Magistratura e più in generale dagli organi giudiziari.
In effetti, il problema della coesistenza sugli stessi fatti di un'inchiesta parlamentare e di istruttorie giudiziarie (esaurite o in corso) si risolve considerando che in casi del genere, per salvaguardare a sufficienza l'autonomia della Magistratura basta che l'inchiesta non sia in nessun modo preordinata o diretta al sindacato delle (singole) decisioni giudiziarie o all'accertamento di responsabilità penali, o comunque individuali.
La Commissione, appunto, non ha mai avuto di mira simili risultati, ma anche in questo settore si è sempre fedelmente attenuta ai limiti, ad essa assegnati dalla legge istitutiva, di accertare la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia e di proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause. Ma, in questa prospettiva, la Commissione ha creduto legittimo non solo, ma indispensabile, rivolgere la sua attenzione ai fatti di mafia, penalmente rilevanti, di cui si è interessata l'Autorità giudiziaria; ciò proprio allo scopo da un lato di studiare vino degli aspetti più rilevanti e insieme più significativi della mafia, quello appunto delle sue iniziative delittuose, e dall'altro di accertare le eventuali disfunzioni dell'amministrazione della giustizia di fronte a fatti del genere, e quindi di individuare i rimedi necessari ed opportuni per il migliore funzionamento della giustizia nello specifico settore.
Nello svolgere questo compito, la Commissione non ha mai inteso dare un giudizio sulla corrispondenza alle emergenze istruttorie delle singole decisioni dell'Autorità giudiziaria, né ha voluto sindacare o criticare il giudizio dato dai magistrati nelle varie e spesso intricate vicende di marea mafiosa che li hanno occupati, nel corso degli anni; ma non ha potuto tuttavia fare a meno di valutare nel suo complesso il comportamento tenuto di fronte ai fatti di mafia della Magistratura e dagli organi di Polizia, appunto per accertare se i risultati che si sono ottenuti (e che si ottengono) nella repressione della delinquenza mafiosa siano o no diversi e di minore efficacia rispetto a quelli conseguiti nella lotta alla criminalità non mafiosa, e per individuare in caso affermative, anche riguardo a questo come a tutti gli altri settori dei pubblici poteri, se siano deprecabili infiltrazioni mafiose, colpevoli cedimenti o cause di altro genere ad avere ostacolato, nei confronti della mafia, l'opera della Polizia e della Magistratura.
Più specificamente, nel procedere a questa doverosa ricerca, la Commissione ha avuto di mira due finalità, quelle di accertare: 1) se i delitti di mafia rimangono o no impuniti in percentuale superiore ai reati con diversa causale e 2) quali siano le ragioni di un simile fenomeno, in particolare se siano dovute a fattori esterni, come i modi di esecuzione del delitto, la condotta dei soggetti interessati, eccetera, oppure a fattori in qualche misura connessi con l'atteggiamento della Polizia e dalla Magistratura rispetto ai delitti di mafia.
Ai fini della prima indagine, la Commissione ha curato anzitutto di accertare il numero dei processi definiti, per ogni anno dal 1946 in poi, dagli uffici giudiziali dei distretti mafiosi, separando, tra essi, quelli iniziati e conclusi contro ignoti da quelli definiti invece con sentenze istruttorie o dibattimentali, di assoluzione o di condanna. Sono stati poi distinti, soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici interessati, ma anche con un esame diretto dei fascicoli, i processi relativi a delitti di mafia da quelli che invece riguardavamo reati in nessun modo riconducibili al fenomeno in questione.
Purtroppo, i dati che così si sono avuti a disposizione non sono stati sufficientemente completi, per una serie di ragioni, che qui sarebbe inutile indicare, ma soprattutto per la difficoltà di individuare, in relazione ai vari reati, una sicura causale di stampo mafioso.
Si può dire tuttavia con certezza, almeno in relazione al periodo che va dal 1945 all'ultima frazione degli anni sessanta e per i delitti commessi nelle zone agricole dell'Isola, che i reati di mafia rimasti impuniti superano di gran lunga quelli di diverso tipo, per i quali si è registrato un uguale insuccesso delle indagini giudiziarie. In particolare, sono risultati numerosissimi, negli accennati limiti di spazio e di tempo, i processi di mafia iniziati e conclusi contro persone mai identificate; così come si è accertato che l'uso, anche in istruttoria, della formula assolutoria per insufficienza di prove fu particolarmente frequente negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, per andarsi poi man mano riducendo, sino a registrare, sempre per i reati di mafia, una caduta verticale, tale da restringere il fenomeno in proporzioni accettabili e pienamente spiegabili.
Passando quindi alla ricerca delle cause dell'insuccesso che caratterizzò, nel periodo considerato (e nei limiti accennati), l'intervento e le iniziative degli uffici giudiziari siciliani di fronte ai reati di mafia, la Commissione ha dovuto rilevare che una serie di anomalie procedimentali (per le quali non si è mai cercato di stabilire in che misura abbiano potuto incidere sulla formazione dei singoli giudizi) indubbiamente connotò le vicende processuali, prese in esame dallo speciale Comitato di cui prima si è fatto cenno, e successivamente valutate di nuovo, per un necessario approfondimento.
Si è così in primo luogo rilevato che in molti casi i Giudici istruttori pervennero a conclusioni assolutorie, senza dare il peso necessario alla circostanza che secondo il nostro sistema per rinviare a giudizio l'imputato non sono indispensabili le stesse prove che occorrono per condannarlo, ma bastano invece tutti e solo quegli elementi, sia pure indiziari, che consigliano comunque un'indagine dibattimentale diretta proprio al fine di raccogliere la prova di un'eventuale reità.
Al contrario, con alcune delle sentenze esaminate, si pervenne al proscioglimento con formula dubitativa sulla considerazione che non erano emerse le prove della colpevolezza dell'imputato, come cioè se si fosse dovuto esprimere un giudizio di certezza e non di semplice possibilità sull'opportunità dell'ulteriore indagine dibattimentale in relazione agli elementi già raccolti.
Inoltre, talune decisioni assolutorie, anche per delitti gravissimi, furono spesso motivate in modo eccessivamente sintetico, senza un riferimento puntuale ed approfondito agli elementi di prova raccolti. La circostanza può anche trovare spiegazione nella constatata impossibilità di conseguire comunque risultati migliori e in una specie di fatalistica rassegnazione di fronte a delitti, rispetto ai quali le indagini sono sempre particolarmente difficoltose, anche per le cause generali del disservizio giudiziario. Ma non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, accanto a queste telegrafiche motivazioni di assoluzioni, che avrebbero perlomeno dovuto presupporre di vaglio rigoroso delle contrastanti circostanze acquisite, stiano poi elaborate è lunghe decisioni, volte a criticare elementi validi di accusa e ad accreditare le tesi difensive.
Si è ancora notato che, sempre nel periodo che qui viene in considerazione, la durata delle istruttorie non fu ogni volta proporzionata alla gravita dei fatti e comunque alle loro circostanze. Talora, a distanza di pochi mesi dal commesso reato, vennero definite istruttorie anche complesse, che sarebbe stato invece possibile non concludere in breve tempo con formula assolutoria, ma indirizzate verso l'indagine dibattimentale o mantenere ulteriormente pendenti nel tentativo di esperire altri possibili mezzi di indagine.
Altre volte, invece, le decisioni di assoluzione intervennero a distanza di anni, ma senza che si mettesse a frutto il tempo trascorso per approfondire o estendere gli accertamenti istruttori. Tra le altre, l'istruttoria per l'omicidio in persona del sindacalista Accursio Miraglia, ucciso a Sciacca il 4 gennaio 1947, si concluse in soli sette mesi con la requisitoria dal Pubblico ministero di proscioglimento degli imputati con formula piena e con la successiva conforme sentenza della Sezione istruttoria della Corte d'Assise di Palermo in data 27 dicembre 1947.
Di contro, altre istruttorie per fatti di minore importanza rimasero pendenti per anni prima di pervenire ad una conclusione, mentre anche nel caso di rinvio a giudizio, trascorsero a volte lunghi anni, tra il dibattimento di primo grado e quello di appello, a tutto discapito della freschezza e vivacità dei ricordi, e quindi della genuinità della prova.
Così, ad esempio, non si può passare sotto silenzio che per l'omicidio in persona di Placido Rizzotto, attribuito tra gli altri a Luciano Leggio e avvenuto il 10 marzo 1948, la sentenza assolutiva della Corte di Assise di Palermo intervenne a quasi cinque anni di distanza dal delitto, il 30 dicembre 1952, e la sentenza d'appello che confermò l'assoluzione di tutti gli imputati fu pronunciata addirittura nel luglio 1959, a ben undici anni dal fatto.
Si deve anche ricordare che la maggior parte delle volte, non appena le indagini per un delitto si indirizzavano verso un individuo determinato e costui veniva posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ogni altra pista veniva immediatamente abbandonata, sia dalla Polizia che dalla Magistratura, e ogni altra ipotesi di responsabilità diversa veniva quindi implicitamente accantonata.
La Polizia in simili casi sospendeva ogni attività, per non interferire nell’istruttoria giudiziaria in corso, mentre dal canto loro i magistrati di null'altro si preoccupavano che di raccogliere elementi di prova nei confronti degli inquisiti: sì che il problema in definitiva non era più di accertare chi fosse stato a commettere il delitto, ma solo di verificare se a commetterlo fosse stata la persona denunciata. Avvenne così che per lungo tempo si condussero istruttorie volte soltanto a controllare se l'amputato fosse colpevole, mentre si tralasciarono tutte le altre possibili ipotesi, con la conseguenza perciò che, nel caso di errori della Polizia o di accuse calunniose o di calcolo studiato negli ambienti mafiosi di prospettare un falso colpevole, proprio per stornare le indagini dalla pista giusta, la sospensione dell'attività istruttoria in direzioni diverse da quella per prima imboccata finì col favorire, una volta assolto il presunto autore del reato, il vero colpevole, in quanto impedì a distanza di tempo di riprendere una ricerca interrotta e quindi di sollevare il manto dell'oblio, che aveva finito col coprire i responsabili con una vera e propria immunità.
Fu ancora nel periodo qui considerato che si mise talora in discussione l'indipendenza e l'obiettività dei giudici popolari delle Corti di Assise, competenti a giudicare proprio i delitti più gravi, e che si pensò che la sincerità dei testimoni potesse essere compromessa con maggiore facilità in ambienti tradizionalmente chiusi e legati a mentalità e costume mafiosi.
Si ritenne perciò che potesse porsi riparo all'accennato inconveniente con la rimessione dei processi ad altri giudici, di cui infatti largamente si servì in quegli anni il Procuratore generale di Palermo, per avere avuto sentore, come egli stesso ebbe a dichiarare nel suo discorso inaugurale del 13 gennaio 1966: «di fatti e circostanze che inducevano ragionevolmente a temere la esistenza di occulte manovre tendenti a turbare, anche mediante minacce più o meno palesi, la serenità dei giudici popolari e dei testimoni nei giudizi di Corte di Assise riguardante delitti di carattere mafioso» e per avere avuto, sempre nei confronti dei giudici popolari, «concreti motivi per temere che essi potessero cedere a pressioni e minacce da parte di elementi mafiosi».
Sulla base di queste congetture, furono pertanto rimessi ad altri giudici gravi processi per delitti di mafia, quali quello a carico degli, autori dell'omicidio di Lupo Leale, quello a carico degli assassini del Commissario Cataldo Tandoj, quello per associazione a delinquere e per una serie di gravissimi delitti, nei confronti dei più noti mafiosi, quello infine a carico di Luciano Leggio e di altri, per l'assassinio di Michele Navarra e per gli omicidi che ne seguirono e che insanguinarono le campagne di Corleone.
Sì è anche constatato che negli anni presi in considerazione, e in relazione ai tipi di reati che più spiccatamente traevano la loro origine dalla mafia agricola, era abbastanza frequente il caso che i giudici di appello, mentre di rado accoglievano le impugnazioni del Pubblico ministero, erano invece spesso propensi a riformare le decisioni gravate in favore degli imputati, togliendo così efficacia e potere coercitivo o intimidatorio ai provvedimenti di primo grado e contribuendo d'altra parte a diffondere una sottile sfiducia nell'amministrazione della giustizia ed anche a insinuare nei mafiosi l'erronea opinione che fosse sempre possibile, dopo la condanna, ottenere nei gradi ulteriori del giudizio, un risultato più favorevole.
Specie in tema di misure di prevenzione, la Corte d'Appello di Palermo, giudicando in secondo grado sui ricorsi prodotti contro provvedimenti del Tribunale a carico di elementi sospettati di appartenenza alla mafia, manifestò spesso, nel passato, la tendenza a revocare le misure inflitte, dai primi giudici o ad attenuarne l'entità, con una riforma delle decisioni impugnate e in particolare dei provvedimenti che imponevano il soggiorno obbligato in comuni diversi da quelli di abituale dimora.
Di conseguenza, per l'addietro, mentre noti e pericolosi mafiosi potettero beneficiare di una riduzione della durata delle misure di prevenzione, altri, non meno mafiosi e temibili, potettero addirittura, mercé la clemenza dei giudici di secondo grado, rientrare nei luoghi di residenza a seguito della revoca del soggiorno obbligato inflitto dal Tribunale, acquistando così rinnovato prestigio, provocando un giustificato allarme nelle popolazioni locali, e aggravando il senso di sfiducia nell'autorità dello Stato, con la possibilità ulteriore che veniva offerta in tal modo nuova linfa all'attività delinquenziale.
L'ultimo rilievo riguarda l'orientamento allora abbastanza frequente dei magistrati istruttori di svalutare i risultati delle indagini di polizia giudiziaria e dare peso alle dichiarazioni rilasciate agli organi di polizia da imputati e da testimoni, quando fossero state ritrattate davanti al giudice, e per il solo fatto della ritrattazione.
Numerosi imputati di delitti gravissimi, i quali avevano confessato agli organi di polizia o erano stati raggiunti dalle accuse di testimoni, che in un primo tempo li avevano indicati come gli autori di questi delitti, furono prosciolti per insufficienza di prove, spesso in istruttoria, perché le confessioni o le testimonianze erano state in seguito ritrattate.
Quasi sempre naturalmente coloro che ritrattavano le dichiarazioni iniziali sostenevano di averle rese per le violenze o le pressioni a cui affermavano da essere stati sottoposti dagli organi procedenti, ma furono ben rari i casi in cui i giudici ritennero necessario, prima di addivenire a una definizione istruttoria, di sentire a confronto gli inquisiti e i verbalizzanti, o di svolgere le opportune indagini per saggiare la fondatezza delle ragioni addotte a motivo delle pretese fallaci dichiarazioni rese inizialmente.
Nella maggior parte dei casi, invece, i giudici si accontentarono della circostanza che le deposizioni raccolte dalla polizia giudiziaria non erano state confermate al magistrato, né pensarono mai, se non in rarissime occasioni, di iniziare l'azione penale a carico degli ufficiali di polizia presunti autori dei denunziati abusi o a carico dei calunniatori, ove tali abusi non fossero mai avvenuti.
Inoltre, nell'epoca qui considerata, avvenne spesso che i giudici usassero nelle sentenze il termine «stragiudiziale» per indicare le dichiarazioni rese da imputati o da testimoni agli inquirenti; e ciò senza considerare che l'attività di polizia giudiziaria, pur non essendo attività del giudice, rientra comunque nel processo, tanto è vero che nel vigente codice di procedura essa viene regolata tra gli atti preliminari di istruzione, dei quali tratta il libro secondo, intitolato appunto all'istruzione penale. D'altra parte, le dichiarazioni dei testimoni ascoltati dalla polizia venivano abitualmente indicate col termine «propalazioni», e ciò non soltanto nel caso in cui i testi si limitavano a riferire voci correnti nel pubblico o comunque di ignota provenienza, ma anche quando raccontavano episodi personalmente vissuti o colloqui avuti direttamente con persone determinate e magari con gli stessi indiziati.
L'uso continuo e pressocché costante di siffatta terminologia, mentre non serviva a censurare nei modi opportuni gli eventuali specifici comportamenti arbitrali di determinati esponenti della polizia, finiva col rivelare una generica pericolosa predisposizione di scarso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine; con la conseguenza di rendere ancora più difficile l'attività della polizia giudiziaria, che già si svolgeva in condizioni di notevole difficoltà per gli abili meccanismi di difesa predisposti dagli ambienti legati agli imputati, e di costringere in particolare gli inquirenti ad assicurarsi anticipatamente la prova della propria obiettività, magari facendo assistere numerosi testimoni alla verbalizzazione delle dichiarazioni raccolte.
Ciononostante, in relazione a gravi delitti riconducibili alle iniziative della mafia nel feudo, furono abbastanza numerosi, come prima si è accennato, i casi di imputati che dopo la confessione resa alla Polizia si videro prosciolti, per insufficienza di prove e anche con formula piena addirittura in istruttoria, per il solo fatto che il giudice, senza altra autonoma valutazione critica e facendo leva sulla mera contrapposizione tra dichiarazioni «stragiudiziali» e dichiarazioni «giudiziali», ritenne di non attribuire alle confessioni e alle dichiarazioni (propalazioni) raccolte dalla Polizia neppure il lieve valore di indizio, almeno tale da giustificare la celebrazione del dibattimento.
Così, ad esempio, con la sentenza del 21 maggio 1952, nel procedimento penale contro Castrense Madonia ed altri, da Sezione istruttoria di Palermo assolse i prevenuti per insufficienza di prove, con la sola motivazione che la confessione e la chiamata di correo fatta da uno degli imputati ai Carabinieri non poteva da sola assurgere a dignità di prova; così ancora la stessa sezione istruttoria, in un altro procedimento penale, assolse Salvatore Mannino dal delitto di rapina aggravata, limitandosi ad osservare che le dichiarazioni di accusa rese da un testimone ai Carabinieri e indicate come «propalazioni» non potevano avere il valore di prova, anche se poste in relazione con la latitanza dell'imputato e con il suo tentativo di espatrio; mentre con una successiva sentenza del 29 aprile 1953, tornò ad assolvere il Madonia da altri gravissimi delitti, perché gli unici elementi di accusa a suo carico erano costituiti dalle propalazioni stragiudiziali di un testimone, poi ritrattate dinanzi al giudice; sempre la Sezione istruttoria di Palermo, infine, con sentenza del 3 giugno 1953, assolse Giuseppe Cucinella dal delitto di omicidio perché gli unici elementi di accusa (erano) costituiti dalla sua stragiudiziale confessione e dalle propalazioni pure extragiudiziali di Pisciotta Francesco, che però, essendo state ritrattate giudizialmente, non avendo trovato conforto in altre risultanze processuali, non si ritenne potessero assurgere a dignità di prova certa a carico del prevenuto.
Un analogo procedimento venne del resto seguito anche in casi più mati. Così, ad esempio, nel procedimento a carico di Luciano Leggio ed altri, imputati del clamoroso omicidio in persona del segretario della Camera del lavoro di Corleone, Placido Rizzotto, la Corte di Assise di Appello di Palermo, pose nel nulla la confessione stragiudiziale di due degli imputati, par la successiva loro ritrattazione durante l'istruzione; a sua volta la Sezione istruttoria di Palermo, nella sentenza del 27 dicembre 1947, contro Bartolomeo Oliva ed altri, imputati dell'omicidio altrettanto clamoroso di Accursio Miraglia, tolse ogni valore alle «confessioni e propalazioni stragiudiziali» di due imputati, soltanto perché «giudizialmente ritrattate».
In questa ultima occasione, peraltro, si iniziò anche procedimento penate contro gli agenti di polizia, che erano stati accusati di avere estorto le confessioni, ma il relativo processo si concluse col proscioglimento degli imputati con formula piena, senza che però seguissero alla sentenza un'azione dei poliziotti contro i loro calunniatori, o la riapertura del processo Miraglia.
Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, VI legislatura, 4 febbraio 1976
Per approfondimenti:
Prima parte, venerdì 27 marzo 2020: MAFIA, le origini remote
Seconda parte, venerdì 3 aprile 2020: La MAFIA nella storia dell’Unità d’Italia
Terza parte, venerdì 10 aprile 2020: Le attività mafiose
Quarta parte, venerdì 17 aprile 2020: I mafiosi
Quinta parte, venerdì 24 aprile 2020: Lo Stato di fronte alla mafia
Sesta parte, venerdì 1° maggio 2020: La MAFIA degli anni del dopoguerra
Settima parte, venerdì 8 maggio 2020: La MAFIA a difesa del latifondo
Ottava parte, venerdì 16 maggio 2020: MAFIA: le vicende del separatismo
Nona parte, venerdì 22 maggio 2020: MAFIA e Banditismo
Decima parte, venerdì 5 giugno 2020, Le funzioni della MAFIA di campagna
Undicesima parte, venerdì 19 giugno 2020, Il capo della mafia di Corleone
Dodicesima parte, venerdì 26 giugno 2020, Il capomafia dell’intera Sicilia
Tredicesima parte, venerdì 3 giugno 2020, Le attività della mafia di campagna
Quattordicesima parte, 17giugno 2020, Gli omicidi di sindacalisti e uomini politici
uploads/images/image_750x422_5f1af5d3dbe30.jpg
2020-07-24 16:54:37
13