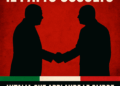Le anomalie rilevate dalla Commissione nei processi e nelle sentenze esaminate, e di cui ora si è fatto sommario cenno, sono state riscontrate, in misura più o meno accentuata, anche in procedure che non avevano nessuna relazione con i delitti di mafia ed alcune di esse anzi hanno caratterizzato negli anni passati e in qualche grado tuttora connotano l'amministrazione della giustizia non solo in Sicilia, ma in tutta l'Italia.
Proprio per valutare meglio il significato e il valore delle riferite circostanze, la Commissione ha creduto opportuno procedere ad un esame comparativo dei processi relativi a delitti di mafia, di cui si è prima parlato, con altri processi, definiti nello stesso periodo di tempo e inerenti a delitti dello stesso genere, ma non riconducibili al fenomeno mafioso. Ciò sul presupposto che se il metro di azione e di giudizio della Magistratura fosse stato nelle grandi linee sempre eguale, in relazione a ogni tipo di delitto, non sarebbe stato evidentemente possibile attribuire nessun particolare rilievo agli elementiprima elencati, ai fini di una valutazione dell'atteggiamento degli organi giudiziali di fronte alla mafia.
È stato appunto a questa conclusione che la Commissione ha creduto di dover pervenire dopo lo studio accurato di un numero significativo di processi e dopo naturalmente un'attenta valutazione delle anomalie indicate, anche in riferimento a quelli che sono stati nel passato (e sono tuttora) i moduli normali di azione dell'Autorità giudiziaria e dei suoi ausiliari.
Si deve, in primo luogo, riconoscere che la tendenza manifestata dalla Magistratura in alcuni processi di mafia di non privilegiare le dichiarazioni rese alla Polizia rispetto a quelle di diverso contenuto successivamente raccolte dal giudice si è riscontrata, con note più o meno simili, anche in processi che nulla hanno a che fare con la mafia; così come anche in casi del genere si è potuto notare come ricorresse, con una certa frequenza, l'uso del termine propalazioni e come non fosse insolita, pure in queste occasioni, la contrapposizione tra dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali, per indicare con la prima espressione le deposizioni rese agli organi di polizia.
Sarebbe praticamente impossibile e in sostanza inutile dare un elenco di tutti i processi, a cui si riferiscono gli accennati rilievi. Ma non si può tuttavia fare a meno di ricordare, a titolo di esempio, che nel processo contro Francesco De Stefano ed altri, relativo ad una rapina aggravata commessa a Palermo, gli elementi raccolti dalla Polizia durante le indagini preliminari non furono ritenuti validi dal Giudice istruttore, ai fini dell'accusa nei confronti degli imputati, appunto a causa dei contrasti (nemmeno di eccessivo rilievo) esistenti tra le prime dichiarazioni degli interessati e quelle rese successivamente al giudice; che il Giudice istruttore di Trapani, con sentenza del 24 giugno 1954, prosciolse per insufficienza di prove gli imputali di un grave delitto di1 omicidio, negando rilievo alle cosiddette «propalazioni» di un testimone, certo Filippo Renda, e non svolgendo nessuna indagine diretta ad accertarne l'attendibilità, in relazione alle sue asserite condizioni di deficienza mentale; che la Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 1° marzo 1957, assolse Vincenzo Marazzita, imputato tra l'altro di tentato omicidio in persona di Castrense Canale, nonostante che il Marazzita avesse reso ai Carabinieri un'ampia confessione e che le successive precisazioni addotte a sostegno della ritrattazione non fossero nemmeno concordanti tra loro: che infine in un altro procedimento, pure per tentato omicidio in persona di Nicola Pillitteri, gli imputati furono del pari assolti per insufficienza di prove, in quanto il giudice preferì dare peso alle dichiarazioni istruttorie della vittima e dei suoi familiari, piuttosto che a quelle che essi avevano reso agli origani di polizia, nella immediatezza del fatto.
Allo stesso modo, non mancano esempi riguardo a delitti che non hanno relazione con la mafia e che risultano avvenuti nel tempo che assume qui rilievo di una scarna propensione degli organi giudiziali e di quelli di polizia a prendere dopo la denunzia del sospetto autore del reato altre iniziative, che potessero portare a più concreti risultati, sia in ordine all'individuazione dei veri responsabili, sia perlomeno circa l'accertamento del vero movente dell'azione criminosa.
Così, tra gli altri, nel processo contro Giuseppe Lombardo, accusato dell'omicidio di Giuseppe Piccione, avvenuto il 16 luglio 1960 in località Ponte Salemi di Trapani, tanto la Magistratura quanto la Polizia tennero conto, nello svolgimento delle loro investigazioni, di una sola pista, e non presero nemmeno in considerazione la possibilità che il delitto avesse trovato la sua origine in una causale diversa da quella prospettata dai familiari della vittima e che proprio per questo poteva non essere corrispondente al vero.
Così ancora nei processi contro Michele Zotta e Giovanni Sacheli e contro Salvatore Colli non furono sfruttate, con la dovuta tenacia e i necessari approfondimenti, le occasioni fornite dall'iniziale avvio delle indagini, per cercare al momento opportuno quella svolta, nel corso degli accertamenti, con la quale evitare che rimanessero impuniti anche in queste circostanze delitti gravissimi.
È noto, del resto, e non è nemmeno il caso di insistervi, come questo inconveniente di processi, nei quali una volta imboccata una pista, si trascurano altre possibili ipotesi di responsabilità, abbia in effetti un'estensione, anche territoriale, ben più vasta di quella limitata ai delitti di mafia, su cui la Commissione ha portato la sua attenzione.
In tutta Italia, si può ben dire, avviene frequentemente che gli inquirenti, qualora si profilino indizi di colpevolezza a carico di persone determinate, siano portati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente ad accentrare i propri sforzi nella ricerca di elementi che convalidino la prima ipotesi, piuttosto che spostare in altra direzione le proprie iniziative.
Sono troppo noti alcuni episodi del genere, accaduti negli anni recenti in settori della criminalità del tutto diversi da quello della mafia, perché vi sia bisogno di dare una specifica e più ampia documentazione di quanto si è ora affermato; ciò tanto più che il fenomeno trova spesso la sua causa in fattori facilmente individuabili, in primo luogo di ordine materiale, quali quelli inerenti alla difficoltà di disporre di mezzi sufficienti per approfondire, circa i singoli delitti, tutto il ventaglio delle possibili ipotesi di responsabilità, e poi di ordine anche psicologico, essendo naturale, per così dire, che una volta individuato un possibile colpevole, si concentri su di lui tutto il fuoco dell'indagine.
Anche per quanto riguarda la maggiore o minore brevità della motivazione delle sentenze (istruttorie o dibattimentali) e la diversa durata dei procedimenti penali, non si può dire davvero, per poco che si abbia una esperienza delle cose di giustizia, che si tratti di anomalie, lacune e inconvenienti propri soltanto di un determinato settore dell'amministrazione della giustizia; essendo al contrario noto e facilmente riscontrabile, anche attraverso la sola consultazione degli annali statistici, che i processi penali hanno in genere una durata che oscilla tra un minimo e un massimo, tra i quali esiste spesso un'escursione di notevole latitudine.
Si tratta anche qui di un dato che trova le sue cause in fattori difficilmente generalizzatili, in quanto legati a circostanze contingenti, come la semplicità o la complessità delle indagini, la disponibilità dei mezzi di ricerca necessari, le pendenze più o meno gravose dei singoli uffici giudiziari e non ultimo il temperamento stesso dei magistrati impegnati nella trattazione e definizione delle varie vicende processuali.
Non diversamente, la brevità o la struttura eccessivamente analitica di certe sentenze istruttorie è anch'essa una evenienza che non si presta a interpretazioni univoche, potendo spiegarsi con cause del genere più vario e difficilmente riconducibili ad unità.
Parimenti la rilevata frequenza con cui, in un certo periodo di tempo, vennero riformate in appello, a favore degli incolpati, le decisioni dei giudici di primo grado relative a delitti di mafia o a indiziati di appartenenza alla mafia non è certo un fenomeno che ha avuto le sue manifestazioni solo o prevalentemente in questo settore della criminalità.
Le cronache giudiziarie infatti documentano, in modo irrefutabile, come non sia raro il caso di processi, anche particolarmente importanti per il loro rilievo sociale, ma non inerenti comunque a fatti di mafia, che vengono definiti in appello con decisioni più vantaggiose agli imputati; così come risulta dalle statistiche giudiziarie che tendenzialmente si affievolisce, durante il corso verticale del processo, il rigore attinente alla valutazione delle prove raccolte e all'asprezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento.
D'altra parte, l'abitudine o la tendenza della Magistratura siciliana, almeno nel periodo che qui interessa, di definire con sentenze di proscioglimento istruttorio processi che avrebbero anche giustificato, per il grado delle prove raccolte, il rinvio a giudizio degli imputati non una condanna, si può anche spiegare con la preoccupazione dei magistrati istruttori di non precludersi definitivamente la possibilità di utilizzare in un momento successivo le eventuali sopravvenienze probatorie; ciò in quanto, secondo il sistema vigente, d'assoluzione dibattimentale impedisce in ogni caso un nuovo procedimento a carico dello stesso imputato, anche qualora emergano prove sicure di responsabilità, mentre a1 contrario, in presenza di prove nuove, è sempre consentito riaprire ]e istruzioni chiuse, allo stato, con sentenze di proscioglimento.
È dunque possibile che, di fronte a situazioni di dubbio, si sia preferito prosciogliere gli imputati in istruttoria, piuttosto che rinviarli a giudizio, appunto e soltanto per impedire che essi, in mancanza di altri elementi, fossero definitivamente assolti in dibattimento.
D'altra parte, di fronte alla frequenza con cui nel periodo qui considerato vennero rimessi ad altri giudici processi per fatti di mafia accaduti in Sicilia, non si può fare a meno di sottolineare come molti di quei procedimenti sottratti al loro giudice naturale abbiano avuto fuori dell'Isola una conclusione a favore degli imputati non diversa da quella che avrebbero potuto avere là dove erano avvenuti i fatti.
Così, tanto per citare gli esempi più famosi, vennero assolti dal delitto di strage e condannati soltanto per lesioni personali gli autori dell'attentato di Villalba, nel quale venne ferito (come si è già detto) Girolamo Li Causi, e tra cui si trovava Calogero Vizzini, allora supremo capo della mafia ed esponente separatista; in seguito, nel 1963, furono assolti dalla Corte di Assise di Appello di Napoli gli imputati dell'omicidio del sindacalista Salvatore Carnevale, condannati all'ergastolo in primo grado, mentre il 1966 vide due assoluzioni in gravissimi processi, l'una della Corte d'Assise di Bari nei confronti dei cosiddetti «mafiosi dell'edilizia» di Palermo, precisamente dei ventiquattro «mafiosi di Via Lazio» rinviati a giudizio per rispondere dei vari omicidi e di associazione a delinquere; l'altro della Corte di Assise di Appello di Perugia, che assolse gli imputati dell'omicidio di Salvatore Lupo Leale, poi condannati nella stessa Perugia, in sede di rinvio dalla Cassazione.
In tempi più recenti la Corte di Assise di Bari assolse da una serie impressionante di delitti il bandito Luciano Leggio, che però i giudici di appello hanno definitivamente condannato; mentre dal canto suo, la Corte di Assise di Catanzaro ha assolto molti mafiosi, anche di rango elevato, imputati di delittigravissimi.
Gli accennati episodi sembrano dimostrare come non possa nemmeno attribuirsi all'influenza della mafia sull'ambiente o addirittura alla mancanza di indipendenza delle giurie siciliane la soluzione in senso favorevole agli imputati di determinate procedure. Deve essere ben chiaro, per dare un'adeguata impostazione ad un problema che ha facce così diverse, che nei processi di mafia ciò che più conta, ai fini di un'esatta decisione dei singoli casi, è certo la capacità con la quale il giudice sa valutare gli elementi probatori specifici nel contesto dell'illuminante presenza mafiosa.
Non sono indubbiamente mancati, in Sicilia, gli episodi giudiziari, in cui si è avvertita un'inversione, se così si può dire, dell'accennata ideologia, nel senso che la presenza mafiosa è stata posposta nella valutazione dei singoli elementi di prova e che l'esame della natura mafiosa del processo è stato confinato nei limiti ristretti della ricerca della causale; ma non c'è dubbio davvero (e i fatti successivi alla fase, che qui si sta esaminando, ne danno la più convincente dimostrazione) che nei processi di mafia la maggiore approssimazione della verità può essere raggiunta solo da chi conosce gli ambienti, in cui maturano certi delitti, nelle sfumature dei cenni, delle allusioni, delle perifrasi che stanno a significare, per chi intende, certezza di situazioni e di rapporti.
Non c'è altro da aggiungere per concludere che la ricorrente frequenza con cui negli anni successivi al dopoguerra rimasero impuniti in Sicilia gravissimi delitti di mafia non può in nessun modo attribuirsi, al di là di eventuali particolari episodi, che in questa sede non è nemmeno il caso di ricercare, a fattori che siano in qualche misura connessi con uno specifico atteggiamento tenuto nei confronti del fenomeno mafioso dalla Magistratura e in genere dagli organi che con essa collaborano.
Se i fatti e le considerazioni enunciati depongono per l'esclusione dell'ipotesi che la Magistratura e più in generale gli organi giudiziari si siano comportata, nei confronti della mafia, in modo diverso da come di solito hanno fatto, nei tempi considerati, nel settore della criminalità comune, deve di conseguenza escludersi – almeno nei termini di una ricostruzione valida per il fenomeno come tale e non soltanto per alcuni suoi aspetti – che sia riconducibile a specifici cedimenti dell'amministrazione della giustizia l'insuccesso che caratterizzò, negli anni ruggenti della mafia della campagna, la repressione giudiziaria dei delitti ad essa addebitabili.
La verità è che, almeno per quel periodo, l'insuccesso della giustizia ha avuto cause più profonde, ricollegabili, in primo luogo, alla natura stessa del fenomeno mafioso e solo in via indiretta e secondaria alle disfunzioni e ai moduli operativi degli organismi giudiziari. Dovrebbe risultare già chiaro da quanto fin qui si è detto che, nella società agricola siciliana, la delinquenza mafiosa ha avuto connotati caratteristici, tali da distinguerla con sufficiente nettezza di contorni da altre forme di delinquenza.
In quella società, il mafioso ricorre al delitto non solo per realizzare un profitto economico o per accrescere una propria condizione di prestigio, ma anche e soprattutto per dirimere, attraverso l'intimidazione o la violenza, i conflitti propri di quel determinato tipo di società, per contribuire alla salvaguardia delle strutture sociali vigenti, secondo le aspirazioni dei ceti dominanti, per risolvere infine, nel modo più sbrigativo possibile, e spesso con l'eliminazione fisica dell'avversario, i contrasti personali sorti all'interno dell'organizzazione mafiosa.
In questo modo, il mafioso mette la sua opera anche delittuosa al servizio degli altri e anche le azioni contro gli antagonisti (interni al gruppo o esterni, com'è nel caso degli uomini politici e dei sindacalisti, che lottano per un rinnovamento della società) sono uno strumento che i mafiosi adoperano per accrescere tra i consociati la propria sfera di influenza.
Mediante il delitto, la mafia si esprime e si afferma come un vero e proprio potere, che si consolida con l'esercizio continuo delle funzioni di mediazione dei conflitti sociali e che finisce con l'essere accettato come legittimo dalla comunità in cui si manifesta.
Per rafforzare questo suo potere, il mafioso tende ad accreditare l'opinione che l'opera sua (anche se delittuosa) non è diretta contro il potere istituzionale dello Stato, ma serve al contrario a sostituire lo Stato e la sua giustizia in quei settori, in cui la loro (pretesa o supposta), debolezza renderebbe estremamente difficile un efficace intervento.
In questo senso, la delinquenza mafiosa si presenta, nella società che l'ha generata, come un sistema, giuridico di autogiustizia che appunto perché adempie la funzione di esprimere l'autorità e la forza dell'organizzazione mafiosa deve essere percepibile come tale dall'intera collettività, affinché tutti capiscano che è un'altra da quella legittima la giustizia a cui è opportuno rivolgersi per vedere soddisfatte le proprie pretese.
Deriva di qui la presenza – nei modi di esecuzione di molti delitti di mafia – di un rituale e di una simbologia, evidentemente diretti a richiamare l'attenzione del pubblico sugli specifici moventi delle singole azioni delittuose; così come deriva dalla forza e dalla credibilità con cui riesce ad esprimersi all'interno di una società ancora chiusa ed angusta, qual è quella agricola della Sicilia, la legittimazione almeno parziale del potere mafioso all'interno della comunità.
Ed è proprio in quest'ultimo dato che può trovarsi una attendibile spiegazione della frequente, diffusa impunità dei delitti di mafia, che si sono verificati nelle campagne siciliane.
L'accettazione del comportamento mafioso, infatti, può spingere perfino all'assistenza dell'associato alla mafia e concorre comunque alla formazione di quel caratteristico fenomeno che è l'omertà, dissuadendo dalle accuse e inducendo al silenzio i testimoni e le vittime.
Non diversamente avviene in relazione a certe forme di banditismo, e basta pensare, per convincersene, a quello sardo; ma in più la mafia, nella misura in cui riesce a manifestarsi come un potere informale, riesce anche a creare un'atmosfera, se non favorevole, certamente non sufficientemente reattiva ed aggressiva contro le sue attività, sia pure delittuose.
Si viene cioè a creare nelle popolazioni locali una naturale propensione ad accettare la mafia, con una rassegnazione fatalistica, come una normale manifestazione di vita e di consuetudini; con la conseguenza ulteriore che in molti ambienti si finisce col non dare la necessaria importanza a fatti anche gravissimi e col consideragli a1 più come espressione di normale delinquenza, non inseriti, come invece sono, in un contesto tutt'affatto speciale, e che riverbera sui singoli episodi una luce degna di attenzione particolare.
La mafia, in questo modo, finisce per perdere quel rilievo che invece dovrebbe avere e di fronte alle sue manifestazioni delittuose si attenua o addirittura scompare la necessità di una valutazione rigorosamente negativa, tale da non lasciare spazio, con pericolosi cedimenti od omissioni, a tentativi di infiltrazione o comunque alle possibilità di successo dell'organizzazione mafiosa.
In questo senso, per renderei conto di come un atteggiamento del genere abbia avuto una preoccupante estensione, tanto da raggiungere tutti i livelli sociali, è davvero illuminante una sentenza pronunciata nel 1964 da una Corte siciliana e nella quale si legge che «anche i mafiosi hanno i loro affetti, anche loro vivono la loro vita di relazione che può essere ispirata anche a princìpi di socialità e di liceità se non anche di onestà. Non è l'uomo che qualifica l'azione ma l'azione che qualifica l'uomo. Un'azione se onesta sussiste tale anche se compiuta da un mafioso e non può trasformarsi in delitto solo perché promana da un mafioso… In certi ambienti purtroppo non è consentito lavorare in pace senza la protezione dell'uomo politico o dell'uomo per censo o per altre qualità positive qualificato e rispettato o del mafioso».
Non si potrebbe esprimere meglio quel sentimento di rassegnata accettazione della presenza mafiosa, che ha caratterizzato, per secoli ed anche negli ultimi decenni, la vita delle campagne siciliane, e che è stato il motivo di fondo e certo la ragione principale dell'insuccesso, che ha avuto, nel periodo che qui si considera, l'azione giudiziaria contro la mafia; ciò appunto perché è stato quel sentimento, che ha inciso negativamente, fino ad annullarla, sulla partecipazione del pubblico all'amministrazione della giustizia, in altri termini sull'attiva cooperazione dei cittadini interessati con gli organi della giustizia e, nei pochi casi in cui può essere avvenuto, anche sulla decisione e sulla volontà degli uomini che amministrano la giustizia, ad affrontare il fenomeno col rigore e, se è possibile dirlo, con lo sdegno necessari.
Ma appunto perciò le anomalie, di cui si è prima parlato, se non servono a spiegare da sole, per quanto prima si è detto, l'impunità dei mafiosi (e, in questo ambito, il più ristretto fenomeno delle assoluzioni per insufficienza di prove) hanno tuttavia esercitato, insieme a disfunzioni dello stesso tipo, un peso non indifferente sui risultati della azione giudiziaria nei confronti della mafia: ma ciò non perché la Magistratura e gli organi che con essa collaborano abbiano tenuto in questo settore un atteggiamento diverso da quello che ne ha in genere connotato l'opera, ma al contrario, proprio perché essi non hanno potuto combattere la mafia, con metodi di azione diversi dai soliti e dotati di maggiore incisività, corrispondenti almeno alle attitudini di infiltrazione dell'insidia mafiosa.
In effetti, il regolare, efficace funzionamento degli uffici giudiziari e degli organismi ausiliari, in primo luogo della Polizia, è in ogni caso e dappertutto una condizione indispensabile per un positivo risultato nella lotta contro la criminalità di qualsiasi tipo.
Così come è chiaro, per converso, che i mali che hanno afflitto nel passato e che tuttora affliggono l'amministrazione della giustizia, e di cui le accennate disfunzioni rappresentano talora un aspetto e altre volte una conseguenza, finiscono con l'avere un'incidenza di non poco peso nella repressione e nella prevenzione della delinquenza.
Ma se questi mali compromettono dappertutto una regolare amministrazione della giustizia, essi hanno reso in Sicilia ancora più grave una situazione che era già grave, per i motivi che si sono prima accennati, e che sono in sostanza riconducibili alle particolari difficoltà, che, per le situazioni ambientali e per l'atteggiamento delle persone interessate, caratterizzano o almeno in certi momenti hanno caratterizzato la lotta alla mafia.
È in pratica ovvio ricordare, ancora una volta, dopo quello che si è detto, che le caratteristiche stesse dell'ambiente mafioso, nella società agricola, quali si è cercato di descrivere, rappresentano un ostacolo oggettivo all'opera della Polizia e quindi della Magistratura e rendono difficile e spesso impossibile sia attribuire a persone determinate le singole responsabilità, anche quando si è individuata la provenienza del delitto da una certa casa, sia riuscire a identificarne, insieme con gli esecutori, i mandanti degli atti criminali.
Ma queste difficoltà, è evidente, aumentano ancora di più, fino a divenire insostenibili, se le stesse anomalie, disfunzioni, incertezze che caratterizzano, in generale, l'amministrazione della giustizia, si ritrovano, magari aggravate, anche nel settore della lotta alla mafia.
Una situazione del genere si è appunto verificata in Sicilia, negli anni e in relazione ai delitti che qui sono stati presi in esame, e certamente le circostanze e le anomalie prima indicate ne costituiscono una prova non discutibile.
Ma al di là di quei fatti non si può dimenticare che nel periodo considerato furono particolarmente avvertite le conseguenze derivanti per un verso dalla coesistenza e talvolta dalla concorrenza di una pluralità di polizie, ciascuna subordinata a un proprio centro di comando, e per l'altro dal mancato intrinseco collegamento con la Autorità giudiziaria degli organi di polizia giudiziaria, nemmeno operanti come corpo a sé.
Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, VI legislatura, 4 febbraio 1976
Per approfondimenti:
Prima parte, venerdì 27 marzo 2020: MAFIA, le origini remote
Seconda parte, venerdì 3 aprile 2020: La MAFIA nella storia dell’Unità d’Italia
Terza parte, venerdì 10 aprile 2020: Le attività mafiose
Quarta parte, venerdì 17 aprile 2020: I mafiosi
Quinta parte, venerdì 24 aprile 2020: Lo Stato di fronte alla mafia
Sesta parte, venerdì 1° maggio 2020: La MAFIA degli anni del dopoguerra
Settima parte, venerdì 8 maggio 2020: La MAFIA a difesa del latifondo
Ottava parte, venerdì 16 maggio 2020: MAFIA: le vicende del separatismo
Nona parte, venerdì 22 maggio 2020: MAFIA e Banditismo
Decima parte, venerdì 5 giugno 2020, Le funzioni della MAFIA di campagna
Undicesima parte, venerdì 19 giugno 2020, Il capo della mafia di Corleone
Dodicesima parte, venerdì 26 giugno 2020, Il capomafia dell’intera Sicilia
Tredicesima parte, venerdì 3 giugno 2020, Le attività della mafia di campagna
Quattordicesima parte, 17giugno 2020, Gli omicidi di sindacalisti e uomini politici
Quindicesima parte, 24 luglio 2020, Gli interventi giudiziari
uploads/images/image_750x422_5f3187fa8862d.jpg
2020-08-10 19:47:21
13