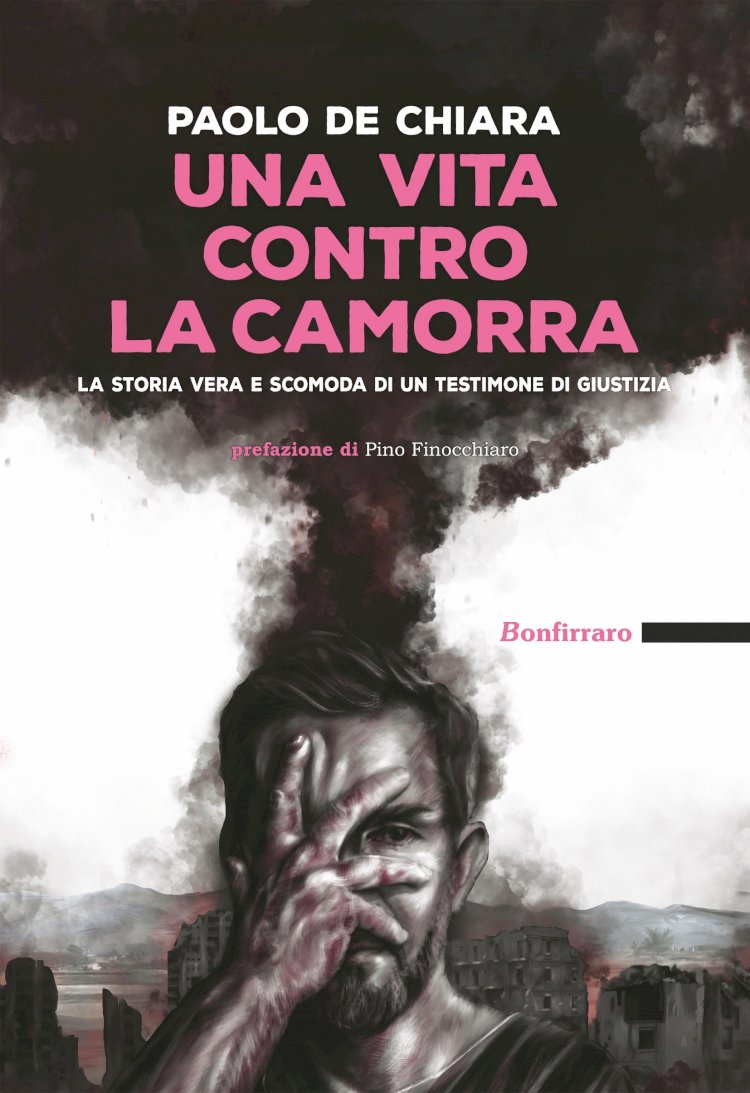Nasce l’urgenza di riscrivere la prima grande pagina della storia del cancro del pancreas in Italia
Cristiana Panebianco, presidente della costituenda associazione “Giuseppe Panebianco per la ricerca contro il cancro del pancreas” descrive attraverso il suo primo racconto, la crudeltà di questo cancro, ma anche la necessità di fare una informazione costante, e rivolge l’invito a denunciare per tutti coloro che sono rimasti vittima di episodi di malasanità o che sono venuti a conoscenza di fatti controversi: “denunciate e sarete salvi,” chiosa.

Mio padre ha combattuto, letteralmente, tre tumori, o se lo si vuole dire in termini più morbidi, tre patologie neoplastiche, in un arco temporale di circa nove anni.
La prima malattia è arrivata dopo dieci giorni esatti dal mio trentesimo compleanno, e l’ho scoperta io, anche se ho faticato un pò perché si arrivasse alla diagnosi considerato che ho dovuto combattere con medici e familiari per spezzare la fama – contro cui ancora tribolo e pure parecchio – di figliola eccessivamente ansiosa.
La seconda malattia è arrivata dopo sei anni e mezzo, e non è stata scoperta soltanto perché mio padre faceva il noto “follow up”, ma perché io continuavo a sottoporre, lui e la sua pazienza, a sistematici e strettissimi controlli dei benedetti marcatori tumorali, e questo già prima che esplodesse la prima malattia (i marcatori tumorali sarebbero quelli che, per intenderci, nessun medico ti prescrive più, visto che parrebbero privi del valore predittivo di tipo oncologico).
Perché lo confesso, è vero che ho sempre ascoltato la scienza e i suoi medici, e tuttavia ho voluto dare, a questo ascolto, il mio personale contributo, perché credo che sia indispensabile dare fiducia anche se stessi, specie in certe circostanze, anzi direi che sarebbe doveroso farlo, e seguire con forza il proprio intuito per attuare quella che, in gergo, viene definita prevenzione primaria.
Il terzo cancro, invece, non ci ha dato tempo di indagarlo perché la sua colpevole presenza è stata subito chiara visto che è esploso all’improvviso.
Se un cancro devasta una famiglia, tre la mettono in croce.
Polmone, pancreas, vescica: questa è stata la sequenza, in assenza di mutazione genetiche conosciute dalla scienza, o almeno così ci hanno detto. Complessivamente mio padre ha subìto tre grossi interventi chirurgici, dodici chemioterapie e trenta sedute di radioterapia, con una miriade di effetti collaterali di cui, forse, ho perso memoria e conto, insieme ad un edema polmonare fulminante che ha superato soltanto grazie alla tempestività degli operatori della centrale operativa di emergenza della città di Perugia, all’alba di una domenica mattina di giugno.
Alla sua ultima seduta di radioterapia, è arrivato in giacca e cravatta, e io me la ricordo bene la sua camicia rosa. Era diventato un fuscello, ma la sua forza non aveva, e non vedeva, ostacoli, esattamente come la sua bellezza, entrambe indifferenti al tempo e alla sofferenza. Il suo medico mi disse, proprio in quell’ultimo giorno di terapia, che non avrebbe mai creduto che mio padre riuscisse a concludere quel ciclo di cure. Ma lui non sapeva chi era e com’era mio padre, ovviamente.
Il cancro del pancreas però l’ha ucciso, e ha ucciso pure qualche pezzo di noi, anche se non vogliamo ammetterlo. E ha ucciso, con spietati epiloghi, un numero di persone spaventosamente troppo lungo.
Il cancro del pancreas è una malattia senza cura, dicono. Io, sinceramente, al concetto di incurabilità, anche nel senso generale, faccio davvero tanta fatica a credere. Credo, invece, nell’immenso potere della parola, della informazione e della denuncia. Che poi è pure una bella parola e possiede un bel suono, rassicurante e protettivo: “denuncia” quando strumento vivo nelle mani di ciascuno di noi, mai abusivo, sempre usata nel sacro nome della legge. Legge che esiste e che è uguale per tutti, anche se, talvolta, questa esistenza e questa uguaglianza arrivano dopo un po' di (fervida) attesa.
Ma non in ritardo.
Denuncia, anche, per denunciare una sanità che non esiste tanto bene in certi posti di questo bel paese, costringendo i più “fortunati” ad emigrare, come è stato per mio padre, e sarebbe ora di creare le condizioni per dire basta e di fermare questa emigrazione e che è tanto, tanto, tanto dura, per il malato e per tutti coloro che lo amano.
Denunciare se si diventa testimoni, anche inconsapevoli, di circostanze sanitarie non chiare, e anche se gli altri ti consigliano di lasciare stare, “perché tanto non cambia niente”: non è affatto vero.
Sarà vero per loro, per i pavidi, per gli indifferenti, per quelli che vogliono farsi i fatti loro sperando di cavarsela alla meglio se dovesse arrivare il loro turno, per quelli che scelgono scientemente di scappare ignorando che la vita si può fare a piedi scalzi certo, ma mai in ginocchio. Denunciare se si diventa vittime sanitarie, denunciare per adempiere al dovere morale di far emergere gli abusi; denuncia per denunciare la malasanità dei colletti bianchi di cui ci informano, ogni giorno, gli articoli di giornale che oramai, quasi, non leggiamo più. Ma non dimenticare di continuare a vivere, nel frattempo. E non dimenticare nemmeno chi è stato meno fortunato, nella malattia, e restare in battaglia, per loro, e anche per noi stessi. Io, dopo la morte di mio padre e dopo quei nove anni che hanno dato la giusta luce, il giusto fuoco e la vera direzione alla mia vita, devo dire che non ho più sentito il gusto pieno della felicità come ero abituata a pensarla e a viverla, fino a quel momento. Ma poteva andarmi peggio. Ed ogni volta che mi trovo dinnanzi ad un ostacolo, io penso sempre a quello che mio padre mi ha fatto vedere, e vivere, in quei nove anni.
E proprio quegli anni mi hanno concesso il grosso dono della relativizzazione di problemi, ostacoli, difficoltà e delusioni. E divento forte. E sono felice, felice di una felicità imperfetta, intrinsecamente malinconica, sostanzialmente fatta di lacrime, ma questa è la felicità, e costa cara, esattamente come diceva Leo Longanesi in una sua frase celebre che, per fortuna, i social hanno riportato alla ribalta, ed io già la scrivevo sulla mia Smemoranda in quarta ginnasio, forse in una sorta di inconscia premonizione: “vissero infelici perché costava meno”.
Ecco, direi, questo mai e poi mai. E se, come diceva mio padre, “non bisogna temere le malattie ma sempre combatterle” è necessario cominciare, ad ogni costo e a costo di qualunque sacrificio, e battersi affinchè la incurabilità diventi curabilità, e non sono soltanto, queste, un mucchio parole.
Basta non adempiere, mai, al “vissero infelici perché costava meno.”
A mio padre.
Cristiana Panebianco